La Giogana
Testo di Bruno Roba (10/10/2017 – Agg. 8/11/2025) - Passo della Calla: WGS84 43° 51’ 36” N / 11° 44’ 39” E - Poggio Scali: WGS84 43° 50’ 41” N / 11° 47’ 18” E – Prato alla Penna: WGS84 43° 48’ 46” N / 11° 49’ 49” E – Presso tutti i popoli del mondo le montagne erano considerate i luoghi delle divinità, così era anche per l’Appennino e il significato del suo nome riporta alle antiche religioni preromane e politeiste della penisola adoratrici del Dio Penn (Pennina, secondo Catone), profondamente connesse con la natura e la ciclicità delle stagioni. Le radici linguistiche del toponimo probabilmente sono celtiche o liguri, per l’appartenenza alle lingue di quei popoli dei termini 'pen(n)' o 'ben'. La radice indoeuropea pen / pend, che ha il significato sia di 'montagna' o 'cima' sia di 'essere appeso' o 'essere in pendenza', rifletterebbe la natura scoscesa della catena montuosa, caratterizzata da cime e pendii. Inizialmente, il nome potrebbe aver indicato solo l'Appennino settentrionale, per poi estendersi a tutta la catena montuosa. In latino classico: Appenninus, in romagnolo: Epinẽ’.
Nel contesto del sistema montano del versante emiliano-romagnolo dell’Appennino Settentrionale, la testata dell’Alta Valle del Fiume Bidente nel complesso dei suoi rami di origine (delle Celle, di Campigna, di Ridràcoli, di Pietrapazza/Strabatenza), assieme a quella delle vallate collaterali, occupa una posizione nord-orientale, in prossimità di una piega di crinale adiacente al Monte Fumaiolo. È parte del sistema orografico dei «[…] tanti contrafforti, i quali, staccandosi dall’Apennino, vanno paralleli a finire nei piani della Romagna Pontificia, solcati da altrettanti fiumi e torrenti, molti dei quali scaricano le acque direttamente nell’Adriatico.» (G. Mini, 1901, 1978, p.2, cit.) riguardo al quale già il Repetti aveva precisato che: «Tutta quella porzione della sinistra costa dell’Appennino che acquapende nelle Valli del Savio, del Bidente, del Rabbi, del Montone, del Tramazzo, del Marzeno, del Lamone, del Senio e del Santerno, appellasi ROMAGNA GRANDUCALE […]» (E. Repetti, 1841, p. 809, cit.). Se l’appellativo Romagna di questo territorio risale ai tempi della donazione di epoca carolingia allo Stato della Chiesa, la parte poi incorporata alla Repubblica di Firenze divenne dalla fine del Quattrocento fino al 1923 prima Romagna Fiorentina poi Romagna Toscana.
GEOLOGIA
Ancora nel XIX secolo si riteneva che: «[…] quel vasto tratto di terreno sollevato, che attualmente comprende la Romagna Toscana, fosse in antico un largo seno di mare […]. Volendo ora assegnare una ragione al sollevamento […] questa è giuoco forza riconoscerla in una di quelle, che più volte obbligarono la crosta consolidata del globo a corrugarsi, e farsi ineguale. – L’Alta Romagna ha in passato grandemente patito per la violenza dei terremoti. […] tutto prova a mio senso, che nelle secrete viscere di questa porzione di terreno vi ardesse in passato, come tutt’ora vi arda, un fuoco, che energicamente dilatandone le materie racchiusevi, e liquefatte distraesse, slogasse gli strati petrosi, depositi tranquilli del mare antico, sollevasse, rendesse verticali, e spezzasse i più ribelli, lasciando ricader sopra sé stessi, e ripiegarsi a zig zag i più cedevoli, e per tal modo si creasse un gran vano ove meglio potesser bollire, e gonfiarsi in seguito quelle da lui fuse materie.» (L. Fabbroni, 1854, 1978, pp. 11-13, cit.). Se risale al 1590 la prima ipotesi del cartografo olandese A. Ortelius sullo spostamento e allontanamento reciproco dei continenti, dopo varie formulazioni occorre attendere il 1912 per l’introduzione della teoria della deriva dei continenti da parte di A. Wegener, ovvero che i continenti in passato fossero tutti uniti in un unico blocco e che, nel corso dei milioni di anni, con il movimento interno della Terra, si siano pian piano allontanati. La grande quantità di dati geofisici sulla morfologia e composizione dei fondali oceanici ottenuti nella prima metà del XX secolo e le scoperte scientifiche tra gli Anni ’50 e ’70 del secolo scorso hanno permesso alla scienza moderna di individuare il modello di dinamica della Terra, sviluppando e consolidando la teoria della tettonica delle placche, o a zolle, secondo cui la litosfera (crosta terrestre) è suddivisa in circa venti frammenti definiti placche, che si muovono in varie direzioni almeno da 3,5 miliardi di anni. Le Alpi e gli Appennini sono stati generati dallo scontro tra la placca Africana e la placca Euroasiatica, prima separate dalla diramazione di un vasto oceano (Tetide) apertosi a partire dal Giurassico medio (180 milioni di anni BP, Before Present, anni dal presente, inteso per convenzione il 1950). I sedimenti depositati in questa diramazione oceanica (Oceano Ligure) nel Cretaceo superiore (circa 95 milioni di anni BP) vennero coinvolti nei movimenti di avvicinamento di Europa e Africa fino all’Eocene medio (circa 45 milioni di anni BP) e la progressiva compressione provocò intense deformazioni facendo assumere alle rocce argillose, più duttili, l’assetto fortemente caotico che le contraddistingue, mentre i calcari marnosi hanno in parte mantenuto l’originario ordine stratigrafico. Nelle successive Epoche geologiche proseguì una contemporanea attività di sedimentazione e orogenesi della catena paleo-appenninica sotto il livello del mare con processi di rotazione iniziati 35-30 milioni di anni BP e sollevamento 14-10 milioni di anni BP, con sovrapposizione di masse rocciose nei punti di contatto tra placche. Durante questa fase, tra 8 e 2 milioni di anni BP, la crosta terrestre continentale ha subito anche un assottigliamento che spiega altresì l’origine di un’importante attività vulcanica. A partire dall’Oligocene superiore (circa 26 milioni di anni BP) iniziò il riempimento, con sedimenti erosi dai paleo-Appennini e dalle Alpi, di una profonda depressione sottomarina, detta avanfossa, che fronteggiava l’embrione di catena paleo-appenninica settentrionale emersa. La sedimentazione avvenne soprattutto grazie a veloci flussi sottomarini, detti correnti di torbida, composti da sabbie, ciottoli, limo e argilla ad alta densità che prima si depositano poi vengono rimossi velocemente sui fondali marini. C. Migliorini nel 1943 per primo illustrò con chiarezza il modello geologico delle Torbiditi, prodotto dal processo di trasporto dei sedimenti della piattaforma continentale a grandi distanze e della loro risedimentazione in un ambiente marino profondo. Il progressivo riempimento dell’avanfossa e i processi di corrugamento e sollevamento determinarono la formazione, tra Miocene inferiore e Miocene medio (18-10 milioni di anni BP), di una nuova porzione di catena appenninica corrispondente all’incirca all’attuale dorsale romagnolo-umbro-marchigiana e di una nuova avanfossa, con ripetizione dello stesso fenomeno evolutivo. La Formazione Marnoso-Arenacea oggi nota è costituita dal riempimento dell’avanfossa più recente, l’Arenaria del M.Falterona è costituita dal riempimento dell’avanfossa più antica, quando «[…] le stratificazioni inferiori si sedimentarono in epoca di ancora forti movimenti tettonici collegati al corrugamento appenninico, per cui continuano ad ospitare potenti banchi di arenaria che infatti affiorano sugli alti versanti fino al crinale Termini-monte Falco al contatto con le due formazioni arenacee toscane (con le quali fanno graduale passaggio)» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi - a cura di, 1992, pp. 23-24, cit.). Tra il Miocene medio e il Pliocene inferiore (8-4 milioni di anni BP) masse rocciose sono avanzate fino all’attuale margine appenninico-padano per poi essere quasi completamente asportate dall’erosione nelle ultime centinaia di migliaia di anni, lasciando lembi “relitti” salvaguardati dallo smantellamento erosivo; infatti, se gli strati torbiditici derivanti da questi processi e dominanti nei due versanti del crinale tra Mugello, Casentino e Romagna appenninica, sono generalmente costituiti da un’alternanza di arenaria per lo più sabbiosa e grossolana e marne argillose e finissime, non mancano affioramenti risalenti alle fasi più antiche di questo tratto appenninico. Per il parziale sovrascorrimento dell’unità Cervarola-Falterona e della Falda Toscana sulla Marnoso-Arenacea, un banco geologico risalente all’Eocene (50-27 milioni di anni BP), la Linea di Monte Falco, affiora infatti sul versante romagnolo del Monte Falco, tra Il Poggione (a quota 1217) e Prato Bertone, e continua ad estendersi riaffiorando sotto il crinale tra i Passi del Porcareccio (è evidente presso la Fonte a quota 1384) e dei Fangacci. Fino al Pliocene il territorio della provincia e della Romagna rimase allo stato di vasto penepiano (quasi piano) inclinato da SO a NE appena ondulato e inciso solo dagli alvei dei principali fiumi attuali, ma ancora senza le notevoli deviazioni che saranno prodotte dalle ultime fasi orogenetiche del Quaternario da cui è conseguita la definitiva morfologia della catena appenninica attuale e le vallate del Casentino e del Mugello, tra cui le alluvioni terrazzate dovute ai depositi alluvionali della prima parte del Quaternario, ovvero del Pleistocene medio e superiore (800.000-10.000 anni BP), che caratterizzano i fondovalle della Romagna, determinando ripiani posti a decine o centinaia di metri più in alto degli alvei fluviali. Nel tardo Pliocene e nel Quaternario un intenso processo erosivo ha inoltre interessato l’Appennino romagnolo; riguardo ad esso P. Zangheri scrive: «[…] cercai di calcolare (basandomi sullo spessore della coltre alluvionale padana) […] e trovai che non poteva considerarsi inferiore al valore medio di circa 650 metri (sulla superficie occupata dalla montagna e dalla collina) […] calcolato in un millimetro annuo circa, si ottiene come quoziente il periodo di 650.000 anni, […] corrispondente […] con buona approssimazione, alla durata del Quaternario, cioè di quel periodo geologico nel quale qui si è avuto per cause diverse […] il più potente effetto erosivo. Anzi è pensabile che l’erosione abbia superato le cifre esposte […]. Si tratta di erosione imponente che ha prodotto la colmata (dello spessore medio di un chilometro e mezzo) che costituisce l’attuale pianura, mentre un altro forte quantitativo di tale prodotto di erosione trasportato dai corsi d’acqua è finito e finisce nel fondo dell’Adriatico.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 40, cit.). In particolare, le erosioni, unitamente ai fenomeni collegati alle oscillazioni glaciali, comportarono la formazione dei terrazzi orografici (antichi piani fluviali) a partire dal Periodo interglaciale Mindel-Riss, 350-300.000 anni BP fino a poche migliaia di anni fa. «L’importanza dei terrazzi è notevole a livello antropico, in un territorio geologicamente e tettonicamente “giovane” dove la morfologia dominante offre pendici scoscese e terreni instabili, anche per colpa dell’uomo, e quindi difficili condizioni ambientali. È sui terrazzi del Mindel-Riss che si trovano ubicati numerosi dei più antichi nuclei abitati alpestri, come Poggio alla Lastra, Strabatenza, Castel dell’Alpe, Pian del Grado-Celle, Biserno, Sasso ecc., oppure i più recenti insediamenti sparsi legati alla diffusione della mezzadria in montagna nel corso del’Ottocento-Novecento – e significativamente segnalati dal toponimo iniziante con “pian” […]» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi - a cura di, 1992, p. 28, cit.).
Dal Pleistocene, oltre al sollevamento regolare dell’Appennino, si accentuarono fino alla seconda fase del Quaternario, ovvero l’Olocene (11.700 anni BP, connotato dalla scoperta dell'agricoltura e dallo sviluppo storico della civiltà umana fino ai tempi odierni – N.B.: è in corso il dibattito scientifico se ritenere concluso l’Olocene con il XX secolo e considerare il nuovo millennio come inizio dell’Antropocene, ovvero l'era dell'uomo che impatta enormemente sull'ecosistema terrestre), processi tettonici di sollevamento degli strati e di corrugamento che hanno generato un sistema di pieghe che si susseguono quasi parallele dal Tirreno all’Adriatico, caratterizzando la provincia e la Romagna ed attenuandosi progressivamente ma senza esaurirsi del tutto, come testimoniano gli eventi tellurici recenti. Il profilarsi delle pieghe assieme all’ultimo sollevamento delle terre ed il ritiro definitivo del mare anche a N di Cesena conferirà gradualmente al territorio provinciale e romagnolo l’assetto attuale, con aumento delle pendenze e restrizione degli alvei fluviali, dando origine alle grandi incurvature dei fiumi e dei contrafforti che li dividono. L’assetto orografico principale orientato SO-NE e le rotazioni terminali testimoniano della genesi di queste montagne evidentemente sottoposte più a valle da un movimento tettonico esercitato da SE mentre le spinte considerate principali provenivano da SO. Cinque pieghe interessano la Toscana e la sesta, ovvero il primo inarcamento degli strati sedimentari romagnoli, interessa il Casentino e l’Appennino dal Monte Falterona fino all’Alpe della Luna e oltre. La piega successiva segue le linea S.Benedetto in Alpe-M.Gemelli-M.Guffone-Piano d’Arcai-Berleta-Biserno-M.Frullo-S.Piero-M.dell’Incisa. Altre si susseguono. Questi ondulazioni, costituite da un succedersi di anticlinali (ripiegamenti convessi) e sinclinali (ripiegamenti concavi), si profilarono in senso trasversale rispetto allo sviluppo delle valli principali sostanzialmente ormai tracciate, così da sbarrare il deflusso delle acque, con formazione di bacini e conseguenti depositi alluvionali oltre che di meandri fluviali, che comunque non riuscirono a modificare la direzione dei fiumi ormai impostata, secondo un fenomeno detto della sovraimposizione. I fenomeni erosivi hanno poi comportato l’asportazione delle sommità (cerniere) delle anticlinali come è stato individuato p.es. alla base di Poggio Scali presso Ciriegiolino, fra Ridràcoli e Biserno e fra Biserno ed Isola. La costituzione geologica a pieghe parallele a volte ha lasciato qualche traccia visibile superficiale non ancora compromessa dall’erosione in corrispondenza dei rialzamenti dei nodi montani (che emergono con formazione di picchi a volte piramidali nello sviluppo digradante dei contrafforti verso la pianura) quando si incrociano con le linee degli anticlinali, quali sono p.es. i Monti Ritoio, Guffone e Castelluccio lungo la suddetta linea da S.Benedetto in Alpe, dove peraltro si evidenzia un notevole parallelismo nel ripetersi di tali rialzamenti tra i contrafforti adiacenti del tratto casentinese-romagnolo. Tali coincidenze sono significative tettonicamente, così come gli incroci tra i rialzamenti e gli avvallamenti delle linee di sinclinale sono significativi quali assestamenti delle rocce a seguito di ribaltamenti di sommità delle pieghe.
OROGRAFIA
Probabilmente all’interno di uno dei primordiali avvallamenti sopra descritti potrebbe essersi originato l’assetto orografico dell’Appennino tosco-romagnolo e quindi attinente all’Alta Valle del Fiume Bidente, quale parte del sistema montano accennato da Mini nella citazione sopra riportata, laddove la catena appenninica presenta evidenti inflessioni alle quali si accompagna un vario orientamento delle diramazioni montuose che si staccano ad oriente dividendo i sistemi vallivi, con una regolarità morfologica che conferma quanto siano geologicamente recenti, a differenza dei territori circostanti, specie toscani, dove le catene montane sono disposte nelle più varie direzioni con datazioni di rocce che possono risalire fino a 300 milioni di anni BP, ricadendo pertanto nel Paleozoico.
Schematizzando, la linea del crinale appenninico ai due estremi del tratto tosco-romagnolo, in coincidenza del Passo della Futa e del Passo di Viamaggio, presenta due nette inflessioni dove si modifica la direzione di sviluppo dello Spartiacque rispetto ai tratti precedente e successivo. Anche i contrafforti che da esso si distaccano proiettandosi verso l’area padana presentano un diverso orientamento a seconda del rispettivo tratto di origine: «[…] il crinale appenninico della nostra Provincia (e della Romagna) ha la direzione pressoché esatta da NO a SE […] hanno […] orientamento, quasi esatto, N 45° E, i contrafforti (e quindi le valli interposte) del territorio della Provincia di Forlì e del resto della Romagna. […] tale direzione non continua uniforme fino a raggiungere le ultime propaggini dei contrafforti stessi verso la pianura, e cambia invece alla distanza di 25-35 chilometri dalla dorsale, per piegare verso la direzione N 25° E […] passando progressivamente a N […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, pp. 9, 59 cit.). Queste serie di rupi dai profili spesso frastagliati per la velocità del disfacimento roccioso che si snodano come un bastione naturale tra le valli denominate contrafforti terminano nella parte più bassa con uno o più sproni mentre le loro zone apicali fungenti da spartiacque sono dette crinali, termine che comunemente viene esteso allo stesso rilievo cui appartengono. Nei documenti storici per indicare i crinali, specie se costituenti elementi morfologici evidenti del territorio era spesso utilizzato il termine radium, raggio, forse in quanto netti e lineari (come quelli solari), allorquando erano parte di un itinerario (che consentiva collegamenti più diretti e rapidi tra luoghi altrimenti raggiungibili tramite lunghi tragitti) e/o costituenti confine di un’area. Per rilevanza o consuetudine a volte il termine diviene esso stesso toponimo o ne fa parte (Il Raggio, Raggio del Finocchio, Maestà del Raggio, Raggio alle Secche, Raggio dei Picchi, Raggio Grosso, Raggio Lungo, Raggio Mozzo, Fosso del Raggio, Raggio di Sopra, etc.).
All’interno dell’assetto orografico descritto il complesso montano inerente all’Alta Valle del Fiume Bidente è costituito dal tratto compreso tra il Monte Falterona e il Passo dei Mandrioli e dalla sequenza di ramificazioni primarie strutturate a pettine che da esso si distaccano prolungandosi secondo linee continuate e parallele verso Forlì e Cesena, fino a raggiungere uno sviluppo di 50-55 km. La testata è delimitata da due contrafforti principali che hanno origine, a NO, «[…] dal gruppo del M. Falterona e precisamente dalle pendici di Piancancelli […]» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 14, cit.) e, a SE, da Cima del Termine così sviluppandosi per circa 18 km; in tale ambito si staccano due contrafforti secondari e una ramificazione di dorsali e controcrinali di minore sviluppo ma non inferiore importanza delimitanti le singole vallecole del bacino idrografico.
Il contrafforte principale NO, presa origine dal gruppo del Monte Falterona tramite le pendici di Pian Cancelli, prosegue per il promontorio tondeggiante di Pian delle Fontanelle e precipita con la Costa Poggio Corsoio. Tende quindi a stabilizzarsi intorno a Poggio Bini per poi manifestare una piega a oriente con il Monte Ritoio, già ricordato per l’interesse come nodo montano, ed un sollevamento di cresta fino al Monte Guffone comprendendo il Monte dell’Avòrgnolo. Riprende poi l’andamento principale verso Forlì e termina presso la chiesa di Collina sopra Grisignano dopo circa 47 km, non prima di avere evidenziato un’ulteriore sequenza di rilievi (il Monte della Fratta, i Poggi Penna e Montironi, i Monti Prignolaia, Altaccio, Spino, delle Forche, Martellino, Grosso, Fuso, Brucchelle e Velbe, i Colli delle Caminate e di Lardiano).
Il contrafforte principale SE si stacca da Cima del Termine, presso il Passo dei Mandrioli, diretto verso Cesena. Subito precipita tramite le Rivolte di Bagno fino al Poggiaccio proseguendo più regolare con l’alternanza dei modesti rialzamenti dei Monti Carpano e Castelluccio e la sella di Macchia del Cacio fino al Monte Piano (che offre una panoramica completa dello Spartiacque). Prosegue con il Monte Frullo, il Passo e Colle del Carnaio, i Monti Aiola, Calbano, della Faggia, Valnesta, Altello, Navacchio, gli attraversamenti di S. Stefano, Rivoschio e S. Matteo cui seguono i Monti Cavallo, della Rovere o dei Feriti, i Colli di Collinello, Madonna di Cerbiano e di Bracciano, infine raggiunge Casa Tomba, Massa e Monticino «[…] per finire sulla via Emilia presso Diegaro.» (P. Zangheri, 1961, rist.anast. 1989, p. 16, cit.) dopo circa 49 km.
Tra dette ramificazioni orografiche primarie si interpongono due ramificazioni secondarie. Il contrafforte secondario NO si distacca da Poggio Scali e precipita ripidissimo disegnando la sella “a corda molle” di Pian del Pero, serpeggiante evidenzia una sequenza di rilievi (i Poggi della Serra e Capannina, il Monte Grosso, l’Altopiano di S.Paolo in Alpe, Poggio Squilla, Ronco dei Preti, Poggio Collina e Poggio Castellina) fino a digradare presso Isola dopo circa 14 km. Il contrafforte secondario SE si distacca da Poggio allo Spillo, scende a Poggio della Bertesca, risale a Croce di Romiceto, evidenzia i Monti Moricciona, La Rocca, Marino, Pezzoli e Poggio Busca, già Croce La Lastra e il Monte Carnovaletto per concludersi con il Raggio delle Rondini presso Capaccio a valle di Isola dopo circa 15 km.
Questi contrafforti racchiudono le valli dove scorrono le 4 ramificazioni altomontane del Fiume Ronco, detto Bidente da Isola a Meldola, e Bidente di Corniolo da Corniolo a Isola. Tra i primi tratti dei contrafforti NO principale e secondario scorrono il Bidente delle Celle e il Bidente di Campigna (nelle descrizioni spesso ignorati nelle loro specificità e considerati ramificazioni anonime del Bidente di Corniolo) a loro volta separati dal contrafforte terziario che in fase di distacco è collegato dalla sella di Pian dei Fangacci alla morfologia piramidale di Poggio Martino ed al Monte Falco. A Poggio Martino fa seguito la geometrica sequenza di creste di altri quattro rilievi, detti (alcuni secondo l’antico oronimo) Poggio di Zaccagnino, Poggio di Mezzo, Poggio del Palaio e Poggio delle Secchete, oggi Poggio Palaio, che si sviluppa divaricandosi dallo Spartiacque Appenninico secondo un evidente fenomeno tettonico. Con la Costa Poggio dei Ronchi la cresta precipita fino alla sella dei Tre Faggi, riprende la risalita come crinale di Corniolino fino a innalzarsi con il Monte della Maestà per poi scemare terminando presso Lago dopo circa 8 km. Tra i due contrafforti secondari scorre il Bidente di Ridràcoli e tra il contrafforte secondario SE e il primo tratto del contrafforte principale SE scorre il Bidente di Pietrapazza-Strabatenza.
Il tratto di Spartiacque pertinente all’ambito descritto corre su altitudini tra le più elevate dell’Appennino forlivese, minime poco inferiori ai m. 1300 e massime fino ai m. 1500-1650, con abbassamenti in corrispondenza dei valichi e rialzamenti in coincidenza con i nodi montani da cui si distaccano le diramazioni montuose. L’inclinazione degli strati, immersi a SO, spiega la ripidità dei versanti esposti a settentrione della Bastionata di Campigna-Mandrioli, dove le pendenze, mediamente pari al 35%, raggiungono acclività del 70-100%, dando alla montagna il noto aspetto di imponenza e invalicabilità, con pareti evidenzianti la stratigrafia “a reggipoggio” modellata dall’erosione e la formazione di canaloni fortemente accidentati, con distacco detritico e lacerazioni della copertura forestale. A tale asprezza morfologica si contrappone la generale morbidità del crinale dovuta alla lentezza dell’alterazione delle bancate arenacee, la cui superficie coincide, appunto, con quella della stratificazione.
Il primo e principale rilevo di questo tratto dello Spartiacque o giogo appenninico è costituito dal gruppo del Monte Falterona (m 1653,5), con il Monte Falco (m 1657,4) posto sulla linea del crinale tosco-romagnolo che, limitatamente alla testata delle valli bidentine, si prolunga a N anche quale stacco del contrafforte principale NO evidenziando Poggio Piancancelli (m 1576,7) e Pian delle Fontanelle (m 1524,4), tagliato a O dalle Balze delle Rondinaie. Dal Monte Falco verso SE emergono lievi dal crinale Poggio Sodo dei Conti (m 1573,6 // +1,104 km LDA = in linea d’aria) e Poggio Lastraiolo (m 1490 // +0,985 km LDA), con i prati della Burraia, mentre l’innalzamento del Monte Gabrendo (m 1538,2 // +0,640 km LDA) prelude alla prima importante sella valicata dal Passo della Calla (m 1295,7 // +0,946 km LDA). Dal passo inizia il tratto centrale dello Spartiacque e il crinale si innalza velocemente fino al poggio detto Il Poggione (m 1432 // +1,190 km LDA) dove inizia un lungo tratto in gran parte in penepiano, anticamente detto Raggio Lungo, fino a Poggio Pian Tombesi (m 1463 // +1,070 km LDA). Una nuova e decisa risalita prelude alla seconda maggiore vetta del tratto, Poggio Scali (m 1521,2 // +1,743 km LDA) a cui segue la netta discesa fino alla sella del Passo Sodo alle Calle (m 1334,3 // +1,784 km LDA), oltre il quale il crinale mostra modeste variazioni di quota nel lungo sviluppo fino al passo di Prato alla Penna (m 1250 // +3,130 km LDA), dove termina la parte centrale dello Spartiacque che, dopo un veloce rialzamento fino a Poggio Tre Confini (m 1395,2 // +1,070 km LDA), sviluppa il suo ultimo e articolato tratto bidentino, infatti subisce una serie di disallineamenti, selle e rialzamenti costituiti da Poggio allo Spillo (m 1448,8 // +1,823 km LDA), Poggio Rovino (m 1393,4 // +1,065 km LDA) e Monte Cucco (m 1330,9 // +1,100 km LDA), per terminare con la rotazione a 90° di Cima del Termine (m 1277 // +2,160 km LDA), che di fatto costituisce asse di allineamento N/S tra il contrafforte principale SE e la prosecuzione verso i Poggi Lombardona o dei Mandrioli e Magiovanna e contro rotazione con ripresa dell'orientamento principale NO-SE. In particolare, da Poggio Porcareccio ha inizio quella serie di biforcazioni di crinale che si accompagnano a disallineamenti dello Spartiacque terminanti dopo il complesso di Cima del Termine, già Terminone, per cui solo oltre l’incisione del Passo dei Mandrioli riprende l’orientamento principale NO/SE da Monte Zuccherodante verso Poggio Tre Vescovi. Osservando lo sviluppo appenninico complessivo di quest’area si nota infatti che, mentre lo Spartiacque da Poggio Porcareccio si sviluppa perfettamente allineato fin oltre Poggio Tre Confini, proseguendo fino a Poggio alle Capre (da cui una dorsale punta su Badia Prataglia), il piano inclinato in contropendenza della Posticcia di Matteino riconnette il Porcareccio allo slittamento di una serie di creste e rilievi, tra cui Poggio Cornacchia, Monte Penna e altri picchi minori. Questo scostamento si sviluppa in sostanziale allineamento con il tratto di Spartiacque compreso tra Poggio allo Spillo e Cima del Termine, il quale slitta mediamente sul NE però evidenziando le ampie pieghe iniziali e finali a cui corrispondono il Passo della Crocina e il Terminone. A seguito di tale assetto orografico si creano i valloni contrapposti dei Fossi degli Acuti e dei Fangacci che nel convergere verso lo stacco (una profonda sella) tra il Penna e il Cornacchia rinvigoriscono il Fosso della Lama - «[…] origini delle acque […] del Fiume Lama che va in quello di Santa Sofia e prende altre acque sino di là dalla Fonte al Sasso» (F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino e Monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla parte della Casa-Nuova in Romagna, 1788, BNCF, G.F. 164, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p.50, cit.; N. Graziani, 2001, vol. II, p.875; cit.) - generando inoltre quelle condizioni morfologiche che si riveleranno indispensabili per il transito. I disallineamenti sono forse esito del citato parziale sovrascorrimento dell’unità Cervarola-Falterona e della Falda Toscana sulla Marnoso-Arenacea, comportante l’affioramento della Linea di Monte Falco, tra l’altro tra i Passi del Porcareccio e dei Fangacci. La stessa particolare morfologia del Monte Penna - Geosito di rilevanza locale la cui asimmetria rispecchia l'andamento degli strati, evidenziati nella parete scoscesa per la giacitura a reggipoggio mentre quella retrostante si raccorda alla zona di crinale per la coincidenza del pendio con le superfici di strato - potrebbe essere dovuta a dislocazioni recenti lungo faglie subverticali tali da creare il risalto strutturale rispetto alle aree circostanti. Inoltre, nella valle del Fosso dei Fangacci si nota un Geosito puntuale di rilevanza locale costituito da un affioramento della suddetta Linea di Monte Falco, appartenente alla zona frontale di uno dei sovrascorrimenti principali dell'alto Appennino romagnolo, dove si evidenziano le deformazioni associate al fronte dell'accavallamento, in particolare una piega a ginocchio (anticlinale) con fianco verticalizzato-rovesciato.
CENNI STORICO-MORFOLOGICI
Le indagini archeologiche fanno presumere che questa area appenninica costituisse un’interconnessione tra i popoli italici risultando una visione unitaria sulle strategie insediative e assemblaggi di cultura materiale, per quanto complessi. Il confine fisico della catena montuosa non costituiva ostacolo al passaggio di persone e merci, di conseguenza impedimento al commercio tra versante adriatico e tirrenico. Inoltre, secondo gli studi paleo-ambientali l'area intorno al Monte Falterona era ricca di abeti rossi, faggi e pini silvestri fin dal IX millennio a.C., che davano il legname ideale per l’edilizia o altri sottoprodotti come la pece. L'importanza di quest'area per la presenza della risorsa lignea è testimoniata dalle fonti classiche (Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Strabone) che dimostrano come l’attività di sfruttamento forestale dal versante casentinese, lignum (combustibile) e materia (legname per le costruzioni), fosse presente nel periodo romano almeno dalla tarda età repubblicana, ma poche ed interessanti tracce risalgono fino all'epoca pre-romana, tanto da far ipotizzare che lo sfruttamento forestale fosse iniziato già dal IV secolo a.C. «Il fatto che i frati di Camaldoli e di Vallombrosa abbiano dovuto avviare una lunga opera di rimboschimento del territorio casentinese a partire dall’XI secolo, potrebbe essere un forte indizio dell’intensivo taglio di legname avvenuto in epoca romana. A mio parere alcuni abitati posti in altura […], alle pendici della Falterona, potrebbero essere stati costruiti proprio per lo sfruttamento dei boschi montani.» (C.M. Dominici, L’archeologia casentinese d’epoca romana. Uno studio topografico, in: Giornale di Bordo di storia letteratura e arte, Serie III, n. 36/37, 2014, p.17, cit.).
La più antica descrizione dell’Appennino risale al 145-140 a.C. ed è contenuta nelle Historiae in cui Polibio individua la catena appenninica tosco-romagnola come spartiacque culturale e politico tra le terre popolate dai Galli e l’Italia romana: «[…] questa pianura appare nel complesso triangolare. E il vertice di questo disegno lo forma l'incontro delle Alpi e delle montagne chiamate Appennini, a non molta distanza dal Mar di Sardegna sopra Marsiglia. Sul lato di questo triangolo rivolto a settentrione corrono le Alpi […] sul lato rivolto a mezzogiorno invece gli Appennini per tremilaseicento stadi [ca. 640 km.]. Infine si dispone come base dell'intera figura la linea della costa adriatica […] (1) Abitano l'Appennino, dal suo inizio al di sopra di Massalia e dalla sua intersezione con le Alpi, i Liguri, sia sul versante di esso rivolto verso il mar Tirreno, sia su quello verso la pianura sia lungo la costa fino alla città di Pisa, che è la prima della Tirrenia verso occidente, nell'entroterra, invece, fino al territorio degli Aretini. Di seguito ci sono i Tirreni; e, immediatamente dopo di loro, gli Umbri occupano entrambi i versanti di queste montagne. In seguito l'Apennino, tenendosi ad una distanza di circa cinquecento stadi [ca. 87,5 km - ndr] dal Mar Adriatico, abbandona la pianura piegando a destra, poi, correndo al centro del resto dell'Italia raggiunge il Mar di Sicilia. […] Il fiume Po, reso famoso dai poeti come Eridano, ha le sue sorgenti nelle Alpi, all'incirca presso il vertice della figura geometrica prima ricordata, e cala poi verso la pianura, dirigendo il suo corso verso mezzogiorno. Giunto alle zone pianeggianti, dopo aver piegato con la corrente verso est, le attraversa; si getta nell'Adriatico in due foci. […] È ricco di un volume di acque non inferiore a quello di alcun fiume d’Italia, perché in esso confluiscono da ogni parte, dalle Alpi e dagli Apennini, tutti i corsi d’acqua che discendono alla pianura. La sua corrente è più bella e imponente verso il sorgere della costellazione del Cane [24/28 luglio - ndr], quando cresce in seguito allo scioglimento delle nevi sui monti già ricordati.» (Polibio, Historiae, II, 14-16). Plinio visitò l’area romagnola dedicandole un brano: «Octava regio determinatur Arimino, Pado, Appennino. […] Padus […], omni numero XXX flumina in mare Hadriaticum defert, celeberrima ex iis Appennini latere Iactum, Tanarum, Trebiam Placentinum, Tarum, Inciam, Gabellum, Scultennam, Rhenum […]» (Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 115, 117, 118) (Trad.: L'ottava regione è delimitata da Rimini, dal Po, dall’Appennino. … Il Po … in tutto porta 30 fiumi nel mare Adriatico, famosi tra questi dalla parte degli Appennini Iatto, Tanaro, Trebbia Piacentino, Taro, Incia, Gabello, Scultenna, Reno). I riferimenti della letteratura geografica antica (oltre ai citati, Strabone e Livio) sono peraltro prevalentemente centrati sull’area costiera rendendo difficoltoso ricostruire la morfologia dell’appennino romagnolo nell’antichità.
Occorre attendere i secoli XIII e XIV, quando Firenze raggiunge uno stato di floridezza tale da indurla alla costruzione di una nuova cattedrale per vedere affidate all’Opera di Santa Maria del Fiore le risorse forestali di quel “dosso d’Italia” che già ai tempi di Dante è l’Appennino, risorse disponibili alla comunità dal 1380 dopo la sottrazione ai conti Guidi. L’organizzazione dell’attività per portar fuori dalla foresta il prezioso e ingombrante materiale arboreo necessitante per la “fabbrica del Duomo” comportò, tra l’altro, la redazione di una corposa documentazione, custodita nell’Archivio dell’Opera e purtroppo in gran parte andata perduta con l’alluvione fiorentina del 1966, che contiene un’abbondante descrizione del crinale appenninico e delle aree di Campigna e Lama. Lo studio archivistico di Gabbrielli e Settesoldi (cit.) effettuato negli anni precedenti alla catastrofe e il saggio di Becattini (cit.) sulla documentazione dell’Archivio, resa disponibile anche tramite link ipertestuali (cit.), consentono comunque una lettura comprensiva del contenuto del materiale perduto con utili approfondimenti. Occorre ricordare che fino alla metà del XV secolo gli introiti derivanti dalle vendite di legname erano pari a meno del 5% delle entrate complessive ma, a partire dalla fine del Quattrocento, divennero sempre più consistenti fino a rappresentare, nel Seicento inoltrato, oltre la metà del totale del bilancio dell’Opera. Dalla donazione fatta dal Comune a favore dell’Opera: «[…] la foresta divenne per la fabbriceria una vera e propria ‘cava’ di materiale, tanto che i documenti parlano di ‘estrazione’ dei tronchi dalla Selva, ponendosi in netto contrasto con le istanze di sostentamento della popolazione locale.» (I. Becattini, 2015, p. 35, cit.).
Per avere un primo testo descrittivo di questo territorio appenninico occorre risalire alla donazione del Campo Maldoli del 1012 e interpretarne i confini, limitati al crinale della Giogana a N, al Monte Faggiolo a O, al Monte Cotozzino e alla strada che conduceva in Romagna a Est, alla confluenza dei Fossi di Camaldoli e della Duchessa a S. Dopo la confisca del vasto feudo forestale da parte della Repubblica di Firenze a danno dei conti Guidi, prima l’alpe del Corniolo, la selva del Castagno, poi la selva di Casentino ovvero di Romagna che si chiama la selva di Strabatenzoli e Radiracoli tra il 1380 e il 1442 furono donate all’Opera del Duomo di Firenze in Romagna (il termine contenuto in atti è “assegnato in perpetuo” - A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 15-16, cit.). «Il vasto territorio ricevuto in dono si estendeva soprattutto nelle valli del Bidente, allora Romagna Toscana, per circa 13.000 ettari. Su questa parte di terreno iniziò ben presto una fitta antropizzazione: dato che la vita dei contadini era molto dura, si cercò di usare la maggior parte dei terreni disponibili per le colture agricole, consumando gran parte del manto forestale con un progressivo innalzamento del limite delle foreste sulle zone con forte pendenza e non adatte alla coltivazione. Si spiega così il progressivo espandersi dei “ronchi” e della messa a coltura dei terreni, che l’Opera in un primo momento cercò di arginare, ma senza risultato a causa della distanza dai centri di amministrazione e della scarsità del personale di sorveglianza. Ciò creò un impoverimento dei suoli che, per chi si affaccia oggi dal Monte Penna, è ben evidente in quei “ronchi” e nella “biancheria” formatasi nel tempo in quei territori dove si è venuto a esporre il sottosuolo agli agenti atmosferici con messa in vista della formazione marnoso-arenacea sottostante.» (M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, p. 37, cit.). Nel 1610 Cosimo II affidò all’Opera la Faggeta Granducale, che il Granduca utilizzava per le necessità militari, ovvero una striscia di bosco adiacente alla linea di crinale che si estendeva fino a Poggio Lastraiolo e ai Monti Gabrendo e Giogarello per mezzo miglio in larghezza e fino a un miglio dal crinale. Da un documento del 1637: «[…] in Casentino vicino alle macchie e boscaglie di detta Opera si trova una macchia o faggeta propria di S.A.S. della quale faggeta per servizio massime dei remi da galera sin dall’anno 1610 dal Serenissimo Granduca Cosimo II fu data la cura e custodia a detta Opera e sua guardie e di nuovo poi nel 1613, per il medesimo rispetto, fu dalla prefata Altezza Serenissima comandato al Signor Soprintendente di detta Opera che la faggeta facesse riguardare massime […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 25, cit.). Se già dagli anni 1559 e 1564 la Legge dell’Alpe, fino alla decadenza nel XVII secolo, obbligava con disappunto locale al rispetto della faggeta secondo le suddette distanze dal giogo, fin dal 1619 sorsero controversie con i confinanti Conti di Urbech e le comunità locali non tanto sul riconoscimento dei confini quanto per i nuovi controlli posti in essere da nuovi affidatari: «[…] cercando di proibire alle guardie di detta Opera la cura e custodia di detta parte di faggeta et il referire all’Opera i danni dati in essa, ne occuparono poi e di continuo ne occupano, il possesso nonostante anco che da altri giudici, già deligati in questa causa, ciò fusse loro proibito […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 25, cit.). Nel 1785 l’Opera acquistò dall’Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze l’Abetina di Poggio Corsoio, rinomata per la particolare dimensione delle sue “antenne” da marina. Nel 1818 e nel 1840, a causa dell’abbandono e malgoverno in cui versavano, le foreste gestite dall’Opera vennero affidate in enfiteusi per 100 anni ai monaci di Camaldoli e nel 1857 Leopoldo II le acquisì a titolo personale unendole alla tenuta di Badia Prataglia, acquistata nel 1846. I rilievi appenninici ricadenti nei territori dell’Opera si trovano citati in occasione della riconfinazione della Bandita di Campigna, con bando del 1645, e della suddivisione amministrativa della foresta, operata nel 1655, in parti da assegnare alle guardie delle selve, alcuni con utilizzo di toponimi in disuso e di difficile identificazione. Il crinale era detto Giogo, o Giogo appennino o Giogana, quindi venivano citati i Poggi Martino, Zaccagnino, di Mezzo, Palaio, delle Secchete (oggi Palaio) e la Calla di Giogo o a Giogo; in documenti successivi si trovano menzionati inoltre la Falterona, Pian delle Fontanelle, Monte Corsoio, le Rivolte di Bagno, estremo limite sud-orientale presso Cima del Termine e il c.d. Poggio di S.Paolo in Alpe. Poggio Scali e Sasso Fratino vengono citati nelle “lettere di taglio” del 1701. La lettura dei confini contenuta nei contratti del 1818 e del 1840 tra l’Opera e i monaci di Camaldoli è infine utile per un ragguaglio toponomastico su rilievi e luoghi principali quali Sodo dei Conti, Giogo di Scali, Giogo Seccheta, Prato al Soglio, Prato Bertone, Prato alla Penna, Gioghetto (presso il Passo dei Fangacci), crine dei Beventi e dei Segoni, Monte Cucco, elencati in ordine verso oriente. Di interesse è la lettura dei verbali conseguenti ai sopraluoghi o “visite” degli “operai” o funzionari dell’Opera, di cui si riportano di seguito alcuni brani. Dalla “visita” del 1605: «Visita fatta questo dì Primo d’Ottobre 1605 […] prima s’è visto e considerato il l.d. la Fonte de Beventi et La Penna; in questi luoghi è necessario far aggirare faggi e stirpare per fare delle posticce d’abeti per essere questi luoghi assai commodi e vicini» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 224-225, cit.). Dalle relazioni di due “visite” del 1677: «Il giorno di martedì montammo a cavallo assai per tempo e arrivammo alla Stradella dove cominciammo a vedere parte della nostra grandissima selva […] e tirando su arrivammo fino al Prato dei Conti il quale dicono essere il più eminente luogo di quelli Appennini e passando da Monte Corsoio luogo di nostro confino con lo spedale di S. Maria Nuova scesimo abbasso sino alla Chiesa delle Celle nel qual viaggio molto disastroso per li cattivi passi […]. La mattina di giovedì […] arrivati nella Calla di Giogo tirammo per quella Giogana per riconoscere i nostri confini; nel tempo in cui andavamo vedendo le nostre grandissime campagne d’abeti chiamate sotto diversi vocaboli […] salendo dalla Calla a Giogo si proseguì per Giogo al Poggio di Scali dove è la via di Scali che scende a San Paolo in Alpe […] e sempre camminammo per quella strada che da una parte per quanto acqua pende in Casentino verso mezzogiorno resta la faggeta di S.A.R. e per quanto acqua pende in Romagna verso tramontana restano le nostre mentovate abetie. […] seguitando per Giogo […] si osservò un gran buon terreno in una amena valle situata in mezzo agli orri di montagna […] si visitò la faggeta del Porchereccio proposta dal Ministro per farvi una piantata d’abeti che veramente sarebbe moto commoda et utile […]. Si ritornò poi per giogo e si giunse al Prato del Soglio […]. Venerdì 24 […] si camminò molte miglia sin presso le Rivolte di Bagno ultimo termine a levante della provincia di sotto e si vedde da più parte del Giogo le vaste provincie dell’abetio della Lama, Forconali, Bertesca, Aguti, Castagno, Sasso di Bosco, et altri dove sono abeti fino alle Rivolte di Bagno […].» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 320-322, 328-329, cit.).
LA CARTOGRAFIA
Solo dal XV secolo, con l’affermazione delle signorie e in seguito con lo stabilizzarsi degli Stati sovrani, per la necessità di acquisire maggiore formalismo e precisione nella rappresentazione del territorio ai fini della delimitazione confinaria rispetto all’impreciso sistema descrittivo degli atti notarili in uso fino ad allora (limitatamente accompagnati da disegni), iniziarono le prime rappresentazioni grafiche del territorio, ma occorrerà attendere il XVIII secolo per giungere ad un’apprezzabile precisione nella redazione delle mappe grazie ai progressi della tecnica cartografica - che comunque si limita ad evidenziare i caratteri ambientali più vistosi tramite uno stile pittorico misto planimetrico-prospettico per cui le zone montane erano disegnate secondo l’approssimativo metodo dei “mucchi di talpa” - e soprattutto il XIX secolo con l’affermazione del sistema catastale, per la nostra area su iniziativa napoleonica proseguita dal Granducato di Toscana.
Il documento cartografico storico forse più antico dove si può trovare una rappresentazione del nostro tratto di appennino tosco-romagnolo è una mappa francese del 1648 Estats del l’Eglise et de Toscane par N. Sanson d’Abbeuille Geogr. Du Roy Auecq Privilege Pour vint Ans 1648 (pubblicata in A. Anceschi, 2018, p. 28, cit.) riguardante gli interi Stati della Chiesa e della Toscana, quindi poco particolareggiata, dove accanto alla sua rappresentazione schematica a “mucchio di talpa” compare la scritta Monte (Falterona) da cui nasce il fiume Bedese (Bidente) che scorre rasentando Soffia (S.Sofia). Una rappresentazione particolareggiata è invece contenuta in una mappa di disegno probabilmente della stessa epoca riproducente i possedimenti dell’Opera al 1637 ed allegata con modifiche ad una relazione del 1710 del provveditore Gio. Batta Nelli, pare realizzata a china con orografia a tratteggio e sfumo ad acquerello principalmente verdastro o seppia, enfatizzazione dell’idrografia e della viabilità oltre a rappresentazione prospettica delle rare case coloniche. È custodita nell’Archivio dell’Opera e si trova riprodotta in A. Gabbrielli, E. Settesoldi (p. 20, cit.) e a colori in A. Bottacci, P. Ciampelli (p. 35, cit.). Nella sua approssimazione grafica la mappa riproduce l’area orientale romagnola interessata dalle selve dell’Opera, all’interno della quale sussistevano controversie con il Comune di Valbona, con punto di vista rivolto da Settentrione verso il crinale appenninico e interessante toponomastica che aiuta ad individuare i luoghi rappresentati. Nella mappa il Giogo, che delimita l’area a Mezzogiorno, è raggiunto presso la Croce di Guagno (Passo della Crocina) dalla Via Maestra che vien dall’Eremo e dalla Via del Rovino pare presso l’odierno Poggio Rovino (dove si trova ancora una consistente traccia sulla sua dorsale che si stacca verso valle). Le Rivolte delimitano l’area a Levante mentre a Ponente al Raggio di S.Paolo fa seguito la Via di Giogo di Scali che ancora oggi si conclude sul poggio omonimo.
Al XVIII secolo risalgono diverse mappe di iniziativa granducale (tutte conservate presso il Nàrodni Archiv Praha in quanto trasportate in Boemia al seguito di Leopoldo II, partito precipitosamente da Firenze la mattina del 27 aprile del 1859 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp) le quali, nel rappresentare l’area casentinese e/o romagnola, inquadrano con vario schematismo il territorio montano e la catena appenninica. La carta del Giachi del 1780, Il Granducato di Toscana diviso in tre provincie, cioè stato fiorentino, stato senese e stato pisano, contiene un tentativo di rappresentazione planimetrica dell’orografia a sfumo completa e d’effetto del tratto appenninico con segnalati il Falterona e le Alpi di Serra. La Descrizione delle provincie del Casentino e del Mugello, della Romagna, del granducato di Toscana, del territorio aretino, del piano di Cortona e del corso di tutta la Chiana, il tutto disegnato in faccia dei luoghi da Padre Antonino De Greyss dell'Ordine dei predicatori del convento di S. Spirito di Siena del 1776, è una carta ufficiale con stemma lorenese dove il territorio è inquadrato con discreta precisione d'insieme ma con un certo schematismo planimetrico anche nel poco evidente sfumo orografico ed è forse una delle rare mappe dove nell’ambito di un ampio tratto appenninico compare l’oronimo La Giogana, insieme a La Falterona e Alpi di Serra. Anche nella Pianta di una parte della Romagna granducale e della provincia del Casentino divisa in cancellerie ed ogni cancelleria divisa nelle sue comunità del 1796, i cui contenuti sono quelli consueti della cartografia amministrativa con disegno misto planimetrico/prospettico e l’orografia è tratteggiata convenzionalmente con le indifferenziate serie a disegno prospettico di 'monticelli' a “mucchio di talpa”, ombreggiati con acquerello grigio ma senza oronimi e, mentre il crinale non compare come confine, si trovano trascritti, tra gli altri, la Colla di Campigna e Sodo delle Calle, attribuiti alla Cancelleria e Comunità di Pratovecchio e S. Agos.no in Alpi attribuito alla Cancelleria di Rocca S. Cassiano e alla Comunità di Premilcuore. Nella Carta geografica della Provincia del Casentino, disegnata da De Greyss databile 1760-1780, piuttosto precisa e particolareggiata rispetto ad altri prodotti della metà del XVIII secolo con aspetti di modernità, l’orografia planimetrica a tratteggio e sfumo si limita al territorio casentinese ma il confine appenninico è dettagliato con gli oronimi Alpi della Falterona, Alpi dell’Opera, Alpi di Camaldoli, nonché (correttamente) Calla di Campigna, Sodo delle Calle, Prato alla Penna, Crocina di Bagno e Le Rivolte di Bagno. Nella Carta del Casentino e parte del Valdarno di Sopra divisa nelle loro comunità, della seconda metà del XVIII sec. si comincia a riportare le coordinate geografiche. Nella Pianta del Casentino, Mugello, Val d’Arno di Sopra, e contorni di Firenze (1760-1780) tra la fitta trama prospettica di 'monticelli', ombreggiati con acquerello grigio sono evidenziati i monti del Falterona sia come dimensione grafica sia con l’oronimo, unico riportato. Nella Pianta della diocesi del Borgo S. Sepolcro, con la porzione della Romagna granducale che appartiene alle diocesi di Forlì, di Bertinoro e di Sarsina, del 1794, i contenuti sono quelli consueti della cartografia ammnistrativa e l’orografia è resa con lo sfumo ma è (ovviamente) disinteressata agli oronimi. Si può chiudere la rassegna del XVIII sec. con due mappe amministrative del noto Ing. Ferdinando Morozzi risalenti al periodo 1770-1783, Vicariato di Bagno di Romagna e Vicariato di Poppi o Casentino, la prima dove l’orografia, resa con tecnica mista a tratteggio e sfumo, è disegnata fino al crinale accompagnato nel suo sviluppo dalla scrittura Sommità dei Monti Appennini che dividono la Romagna dal Casentino, la seconda è completata da riquadri nella cornice con varie vedute tra cui quella del Castello di Stia, ovvero del borgo nel suo aspetto settecentesco a cui fa da sfondo la catena appenninica disegnata a tratteggio e sfumo con acquerello grigio.
Come detto, i veri progressi della tecnica cartografica si manifestano nel XIX secolo e la Carta del Casentino, e parte delle Provincie limitrofe per servire all’itinerario dei Santuari celebri di dette Provincie, disegnata nel 1803 da autore ignoto, nell’evidenziare l’impostazione planimetrica moderna, con l'orografia a sfumo resa in modo plastico, strade, corsi d’acqua, edificato e molti toponimi, apre la strada ai successivi sviluppi catastali e topografici.
Nel 1765 Pietro Leopoldo Granduca di Toscana promulgò il Catasto Generale di Terraferma, noto anche come Catasto leopoldino ma l'idea di un catasto generale fu abbandonata nel 1785, per essere poi ripresa da Ferdinando III nel 1817 con decreto granducale che prevedeva sia di creare una solida rete geodetica e trigonometrica patrocinata dagli Asburgo-Lorena, sia di condurre un rilevamento topografico sistematico e regolare di tutta la Toscana. Nacque così il Catasto generale toscano, definitivamente attivato nel 1832-35 e rimasto in vigore per un secolo fini alla redazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.), ma le mappe relative all’area appenninica recano date di esecuzione del 1824 nel lato toscano e del 1826 in quello romagnolo. Per le loro caratteristiche geometrico-particellari di estrema precisione i catasti ottocenteschi costituiscono uno strumento fondamentale per lo studio e la restituzione dell'assetto territoriale prima delle grandi trasformazioni avvenute a partire dalla fine del XIX secolo. A seguito del decreto si concretizzò la possibilità di realizzare il progetto di Giovanni Inghirami della Carta Geometrica della Toscana in scala 1:200.000 che, dopo 14 anni di lavoro, venne pubblicata nel 1830 sotto il patronato di Leopoldo II. La Carta, fortemente ispirata da esigenze tecnico-amministrative, della mobilità e della scienza, si differenziò da molti progetti cartografici europei dello stesso periodo, mossi principalmente da necessità militari, e rappresentò un riferimento fondamentale per tutte le imprese cartografiche e topografiche successive, relative alla Toscana e poi al nuovo Regno d'Italia, stimolando l’elaborazione di un’ampia gamma di carte da essa derivate. L’opera prevedeva una versione a stampa destinata al commercio (di cui si trovano copie nel mercato antiquario), completa dell’orografia (assente nel Catasto generale toscano) realizzata a tratteggio artistico che, tra l’altro, consente una comprensione immediata del sistema appenninico tosco-romagnolo, composto dalla catena appenninica da cui si staccano i contrafforti proiettati verso l’area padana, come sopra descritto. Alla carta a stampa dell'Inghirami fecero seguito alcune incisioni ridotte anche a fini della stampa alla scala di circa 1:400.000, tra cui nel 1932 la Pianta geometrica della Toscana accresciuta d'indicazioni con imperiale e reale privilegio incisa da Girolamo Segato e la Carta geometrica della Toscana del 1839, nitidissima incisione di Vittorio Angeli.
Con l'unificazione, lo Stato si dotò di una cartografia nazionale unitaria tramite l’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) che nel 1882 iniziò la realizzazione, durata oltre trent'anni, della Gran Carta d’Italia alla scala 1:100.000. La Carta era formata da 4 quadranti rilevati in scala 1:50.000 da cui ebbe origine la Carta Topografica d'Italia, che però non giunse allora a coprire l’intero territorio statale, ma arrivò ad interessare l’area del nostro tratto di Spartiacque, conseguentemente compresa in due fogli con datazione della rilevazione 1893-94 (F.° 107-I, F.° 107-II). In seguito, fu stabilito di estendere all’intera penisola la realizzazione della Carta d’Italia in scala 1:25.000 come carta di base italiana; la realizzazione iniziò nel 1931 e venne conclusa nel 1937, data quest’ultima a cui risalgono i 6 fogli di grande precisione riguardanti la nostra area (F.° 107-I N.O., F.° 107-I N.E., F.° 107-I S.E., F.° 107-I S.O., F.° 107-II N.O., F.° 107-II N.E.). Le mappe sono reperibili presso l'ufficio cartografia storica dell' I.G.M. a Firenze.
Oltre alla cartografia citata sono di interesse la schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia (1830-40 – scala 1:40.000), le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna (1808-1830 – scala 1:5000), probabilmente di impianto napoleonico e la Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese e adiacenze, L’Anno 1850 (1850 – scala 1:20.000) che consente di conoscere, tra l’altro, il tracciato della viabilità antica dell’area, tra cui le Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi, dette anche vie dei legni o anche bordonaie se munite di “bordoni” (tronchetti lignei infissi tipo “paracarro” in modo da trattenere i traini dei tronchi), utilizzate per il trasporto del legname attraverso i valichi appenninici tosco-romagnoli fino al Porto di Dicomano o al Porto di Moscia sulla Sieve se provenienti dalla selva di Castagno, dalla Macchia dell’Opera detta le Buche del Piano del Grado o dalla Pastura detta di Monte Corsojo, o fino al Porto sull’Arno di Badia a Poppiena a Pratovecchio se provenienti dall’alpe del Corniolo o dalla selva di Casentino ovvero di Romagna (cfr. M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, cit.). Il Monastero di Camaldoli utilizzava un tragitto che dall’Eremo giungeva al Porto di Ponte a Poppi, presso lo sbocco del Torrente Sova. Infine, è utile confrontare detta Carta Geometrica con la Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese per dimostrare il progressivo avanzamento dei lavori, e dei rapporti forestali che dall’anno 1837 segna l’epoca della sua ultimazione, pare risalente al 1850, dalla esauriente titolazione. Anche dette mappe sono conservate presso il Nàrodni Archiv Praha e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana.
LA VIABILITÀ
L’ampia rete di percorsi naturali dell’intero sistema dei crinali, già nel Paleolitico (tra un milione e centomila anni BP) permetteva muoversi e di orientarsi con sicurezza senza richiedere opere artificiali, tanto da avere un ruolo cardine nella frequentazione del territorio: «[…] in antico i movimenti delle popolazioni non avvenivano “lungo le valli dei fiumi, […] bensì lungo i crinali, e […] una unità territoriale non poteva essere una valle (se non nelle Alpi) bensì un sistema montuoso o collinare. […] erano unità territoriali il Pratomagno da un lato e l’Appennino dall’altro. È del tutto probabile che in epoca pre-etrusca esistessero due popolazioni diverse, una sul Pratomagno e i suoi contrafforti e un’altra sull’Appennino e i suoi contrafforti, e che queste si confrontassero sulle sponde opposte dell’Arno […].» (G. Caselli, 2009, p. 50, cit.). Gruppi nomadi di pastori-raccoglitori-cacciatori Liguri (Apuani, Frinati, Mugelli, Clausentini), nei loro spostamenti giunsero sino a qui dalla Provenza attraversando le Alpi e percorrendo la dorsale appenninica, per poi arrestarsi in Casentino e nell’alta Val Bidente: «[…] circa tremila anni fa, tutto il centro Italia era accumunato da culture simili per costumi ed abitati, denominate come appartenenti ad un’unica civiltà appenninica. Probabilmente furono proprio tali popolazioni dedite alla pastorizia che, seguendo i loro greggi durante la transumanza, tracciarono i primi tratturi che univano i due versanti appenninici.» (M. Ducci, Di qua e di là dall’Appennino: antichi percorsi tra Casentino e Romagna, in: F. Trenti, a cura di, Bibbiena, 2015, p. 5, cit.). Risalgono all’Eneolitico (che perdura fino al 1900-1800 a.C.) i ritrovamenti isolati di epoca umbro-etrusca di armi di offesa (accette, punte di freccia, martelli, asce) attestanti una frequentazione a scopo di caccia o di conflitto tra popolazioni di agricoltori già insediati; afferma C. Beni «Nel 1883 trovai una bellissima punta di freccia di selce rossa proprio sulla vetta della Falterona.» (C. Beni, 1889, p. 9, cit.). Tra i siti, il ritrovamento in Campigna nella prima metà del XIX secolo, attestato dall’archivio archeologico Gamurrini e dalle memorie del Siemoni, di una sepoltura attribuibile al III millennio a.C. ed appartenente forse ad un capo tribù o un pastore-guerriero ligure corredata da una lancia con impugnatura carbonizzata e punta in selce disposta sulla destra dello scheletro, mentre i resti evidenziano che la mano sinistra stringeva un corno di capriolo. Recentemente (2020, grazie alla segnalazione da parte dei Carabinieri Forestali) sulle sponde dell’invaso di Ridracoli è stato rinvenuto un sito con abbondanti nuclei per la produzione di lamelle, costituiti da vari strumenti lavorati, schegge di lavorazione e lamelle stesse, che può far pensare ad una strutturata stazione preistorica, databile provvisoriamente al Paleolitico finale (facies Epigravettiana) o al seguente Mesolitico, fra i 15.000 e i 12.000 anni BP. È pertanto da ritenere che sulle sponde dei torrenti che oggi formano il lago si siano spinti cacciatori paleolitici alla ricerca delle prede che abitavano i rilievi appenninici circostanti, quali cervi, caprioli e cinghiali, ma anche l’orso, scomparso da circa un secolo, e i castori, scomparsi nel ‘600 (M. Ducci, 2020, p.12, cit.; https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/sulle-tracce-di-cacciatori-preistorici-nel-parco - controllato 18/6/2025). Anche le frequentazioni etrusche si sarebbero spinte fin qui come attesterebbe il ritrovamento casuale da parte di Siemoni di una statuetta in bronzo di VII-VI secolo a.C. con elmo e cimiero, probabile raffigurazione di divinità guerriera, riportato nella celebre Guida di C. Beni: «[…] è degno di particolare menzione […] il ritrovamento (Campigna c.s.) di una statuetta di bronzo rappresentante un guerriero con elmo a grande cresta, oggetto preziosissimo perché sta a indicare qual fosse l’armatura particolare nella regione Casentinese […]» (C. Beni, 1881, rist. anast. 1998, pp. 11-12, cit.). Non è nota la collocazione dei reperti citati. «Già dall’età etrusca arcaica (almeno dal secolo V a.C.). alla luce soprattutto delle scoperte degli ultimi decenni, la conca casentinese appare come un’area privilegiata di transito […]. Si trattava certamente di percorsi spontanei. […] Percorsi secondari sembrano risalire le valli dei torrenti Rassina e Archiano verso i valichi appenninici, dai quali scendono inclinate verso nord-est in direzione dell’Adriatico quelle romagnole del Savio (Sarsina-Cesena) e del Bidente (Galeata, l’antica Mevaniola e Forlimpopoli) abitate dagli Umbri» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.). Altri ritrovamenti a Rio Salso e S. Paolo in Alpe, anche con resti di sepolture. In epoca romana i principali assi di penetrazione si spostano sui tracciati di fondovalle, che tuttavia tendono ad impaludarsi e comunque necessitano di opere artificiali, mentre i percorsi di crinale perdono la loro funzione portante, comunque mantenendo l’utilizzo da parte delle vie militari romane.
Dal gruppo del Monte Falterona passava probabilmente una delle possibili varianti della Via Flaminia militare (o minor), fatta costruire dal Console Caio Flaminio nel 187 a.C., con lo scopo di rendere più veloce il collegamento tra Bologna e Arezzo, realizzata «[…] sfruttando tratti di percorsi etruschi preesistenti […]» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.) ed utilizzata dalle legioni romane per valicare l’Appennino al fine di sottomettere Celti, Liguri e Galli Boj che stanziavano nella pianura padana: «Per l’epoca romana si deduce dalle fonti letterarie, soprattutto Tito Livio, il transito abituale per il Casentino delle legioni dalla grande base stabile di Arezzo, importante soprattutto nei secoli III e II a.C. per le operazioni militari nella direttrice N-W di Bologna-Cremona-Piacenza, contro i Liguri e i Galli Boi.» (A. Fatucchi, La viabilità storica, in: AA. VV., 1995, p. 27, cit.). Si può aggiungere che … «[…] da Arezzo partiva la Flaminia minor, voluta nel 187 a.C. dal console Gaio Flaminio, una via secondaria, importante per il controllo militare degli Appennini e per collegare rapidamente Arezzo a Rimini. Sappiamo che passava per Bologna, attraversando il territorio fiesolano, e che utilizzava diversi passi appenninici, ma non ne conosciamo con certezza il tracciato. In Mugello ne sono state trovate diverse tracce, soprattutto attorno al Passo della Futa, ma per la porzione fra Arezzo e Fiesole sono state avanzate soltanto ipotesi. Appare poco probabile che il tracciato originario passasse per il Casentino, data la natura montuosa e la presenza di numerosi corsi d’acqua. Certo vi doveva esistere una direttrice accessoria, probabilmente parallela alla Flaminia minor, alla quale si ricongiungeva in Mugello. Il Casentino dovette risentire positivamente della presenza di questa via consolare secondaria.» (C.M. Dominici, L’archeologia casentinese d’epoca romana. Uno studio topografico, in: Giornale di Bordo di storia letteratura e arte, Serie III, n. 36/37, 2014, p.17, cit.). Secondo l’ipotesi prevalente la direttrice, ritenuta il più antico itinerario di valico, risalendo dal Casentino fino al Monte Falco, percorreva quella che oggi è nota come Pista del Lupo lungo la Costa di Pian Cancelli, transitava da Pian delle Fontanelle, così detta per la presenza di polle d’acqua, da Poggio Corsoio e dal Valico dei Tre Faggi, quindi discendeva verso Castel dell’Alpe, Premilcuore e Faenza per immettersi nella Via Aemilia. In alternativa da Poggio Corsoio si poteva raggiungere Forlì e Ravenna transitando dal crinale del contrafforte principale sul limite settentrionale della Valle delle Celle, con le vette emergenti dei Monte Ritoio e Guffone; questo itinerario era anche una delle Vie del Sale maggiormente utilizzate per il contrabbando. Lo stesso toponimo Campigna potrebbe avere un’origine romana, dal latino campilia (campus – ilia) ovvero un insediamento con principale funzione di approvvigionamento di una circoscrizione territoriale militare di età imperiale: «[…] in prossimità di Campigna doveva passare una strada militare romana che da Castel dell’Alpi, per la fonte dei Conti che esiste tuttora, conduceva a Stia. Secondo alcuni cronisti medioevali per essa sarebbero passati S. Ambrogio, arcivescovo di Milano, e poi nel secolo XIV il papa Martino V, quando tornava dal Concilio di Basilea […]» (D. Mambrini, 1935 – XIII, pp. 271- 272). Sicuramente questo territorio era noto ai romani sia per le foreste (come sostenuto da Dominici nella citazione sopra riportata), dalle quali si procuravano il legname per le necessità delle flotte di Classe, Rimini e Ravenna, sia per le sorgenti: alla fine del I secolo d.C. l’Imperatore Traiano fece costruire l’acquedotto che riforniva Ravenna e la flotta stanziata a Classe.
In età romana l’alta Val Bidente ricadeva sotto il controllo del Municipio di Mevaniola, situato presso Galeata, centro cittadino dotato di teatro e terme, cosiddetto per i rapporti con gli umbri di Mevania, l’odierna Bevagna. L’economia locale, prevalentemente pastorale, e le consuetudini religiose caratterizzavano la piccola Mevania già dalla protostoria in rapporto al Casentino con i pellegrinaggi ai santuari delle acque medicamentose sul Falterona. Tra IV e V secolo d.C. questo centro istituzionale viene a mancare, decaduto e abbandonato per la stasi dei mercati e l’insicurezza dei traffici successivamente alla guerra greco-gotica (535-553 d.C.) e alla calata dei Longobardi (568 d.C.). Tra la fine del V secolo e l’inizio del VI sec. d.C. il re goto Teodorico restaura l’acquedotto traianeo. Lo stato di guerra permanente porta alla creazione nella seconda metà del VI secolo di una larga fascia militarizzata - richiamata poi dalle fonti come Alpes Appenninae, voluta dai Bizantini quale sbarramento dei transiti appenninici verso la Toscana longobarda - e all’inizio di quella lunghissima epoca in cui l’intera l’area appenninica diventerà anche spartiacque geo-politico, assistendo al diffondersi di una serie di strutture difensive, anche di tipo militare/religioso o militare/civile, oltre che dei primi nuclei urbani o poderali, dei mulini, degli eremi e degli hospitales. Tra il VI ed il XV secolo, a seguito della perdita dell’equilibrio territoriale romano ed al conseguente abbandono delle terre, inizialmente si assiste ad un riutilizzo delle aree più elevate e della viabilità di crinale con declassamento di quella di fondovalle. Sotto il dominio dei Bizantini e degli Ostrogoti sorgono torri di altura per arrestare l’avanzata dei Longobardi in direzione di Ravenna e nell’alta Valle d’Arno, con scarso successo.
Uno dei percorsi forse più praticati nella Valle del Bidente fu la Strata petrosa Langobardorum: «La strada che percorreva la valle corrisponderebbe con la “strata petrosa Langobardorum” che conduceva ai valichi appenninici per i quali si scendeva alla Tuscia e sarebbe stata percorsa dal re dei longobardi, Grimoaldo, per dirigersi su Forlimpopoli, che venne da lui messa a ferro e fuoco fra il 661 e il 671. È in questa temperie che nacque Galeata, sotto il colle su cui sorgeva l’abbazia di sant’Ellero, fondata dal santo eremita sul finire del V secolo; quest’ultima costituì una delle prime comunità monastiche in Occidente. […] Al contempo il territorio era calato in quella fitta trama di pellegrinaggio che diverrà romeo con l’undicesimo-dodicesimo secolo, come documentano le fonti duecentesche: gli Annales Stadentes e l’Iter de Londinio in Terram Sanctam. La via bidentina, costellata da hospitales, che uniscono agli aspetti materiali, legati alle comunicazioni, gli elementi tipici della pietas religiosa medievale, si specializza come via romea al punto da assumere l’appellativo Romipetarum: via dei pellegrini diretti a Roma.» (C. Mambrini, Il territorio dell’alta Val Bidente tra Tardoantico e Alto Medioevo, in: F. Trenti, a cura di, Bibbiena, 2015, pp. 14-15, cit.).
Dopo la morte di Carlo Magno si insediarono signorotti di origine longobarda e franca spesso apparentati con aristocratici bizantini, come nel caso dei Conti Guidi. Il loro coinvolgimento nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini e il conseguente contrasto con la Repubblica di Firenze comportò la loro caduta e l’ascesa della dominazione fiorentina. Ormai sfumate da alcuni secoli le Alpes Appenninae, con l’acquisizione da parte della Firenze, comunale poi signorile, del controllo di un esteso territorio appenninico sul versante romagnolo, tra XIV e XV secolo si va a consolidare la Romagna Fiorentina, ma con la successiva formazione di uno stato interregionale governato dalla stessa dinastia dei granduchi di Toscana diviene preferenziale l’espressione Romagna Toscana soprattutto quale area di libera circolazione di uomini, merci e idee non più impedita dalla catena appenninica, ormai scemate le insidie invasive dal Nord.
Il quadro territoriale più omogeneo conseguente al consolidarsi del nuovo assetto politico-amministrativo cinquecentesco vede gli assi viari principali, di fondovalle e transappenninici, sottoposti ad intensi interventi di costruzione o ripristino delle opere artificiali cui segue, nei secoli successivi, l’utilizzo integrale del territorio a fini agronomici alla progressiva conquista delle zone boscate. In questo periodo si verifica una rinascita delle aree di fondovalle con un recupero ed una gerarchizzazione infrastrutturale con l’individuazione delle vie Maestre, pur mantenendo forte vitalità le grandi traversate appenniniche ed i brevi percorsi di crinale.
Sul contrafforte principale da Cima del Termine il Regesto di Camaldoli documenta una Via de Monte Acutum, probabilmente esistente già dal 1084, come peraltro «[…] conferma un’opinione espressa nel 1935 dal Mambrini circa l’esistenza di una strada percorribile fra i boschi di quel perfetto triangolo, il Monte Acuto, costantemente rilevato nella documentazione medievale come punto di confine fra la Romània e la Tuscia […].» (C. Dolcini, Premessa, in: C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, a cura di, 2010, pp. 7-8, cit.). Mambrini fa un altro riferimento a tale strada nel trattare del Castello di Riosalso: «Il cardinale Anglico così lo descrive nel 1371: “Il castello di Riosalso è nelle Alpi in una certa valle sopra un sasso forte. Ha una rocca ed una torre fortissima ed è presso – circa un miglio – alla strada che mena in Toscana.” […] La strada qui ricordata era sul crinale del monte sopra il castello e per Nocicchio, passando a destra di Montecucco, per Badia Prataglia conduceva in Casentino. Qua e là restano gli avanzi di questa strada.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 288, cit.). Nel Catasto toscano tale via diventerà la Strada che da Montecarpano va alla Badia a Pretaglia.
La sopracitata Via Maestra che vien dall’Eremo nel Catasto toscano riguardo al tratto di contrafforte fino al Passo della Bertesca viene riclassificata Strada che dal Sacro Eremo va a Romiceto (oggi sent. 207 CAI), per il tratto dal passo a Casanova dell’Alpe diviene Strada Maestra di S. Sofia e Strada che dalla Casanova va a Santa Sofia in riferimento al tratto oltre il Monte Moricciona compreso tra la Ripa di Ripastretta e il Passo del Vinco: quest'ultimo interessava il Monte La Rocca e raggiungeva il Passo della Colla, aggirava i Monti Pezzoli e Marino sul versante SE e scendeva a Poggio alla Lastra divenendo di fondovalle fino a S.Sofia.
Nel Settecento, chi voleva risalire l’Appennino da S.Sofia, giunto a Isola su un’arteria selciata larga sui 2 m trovava tre rami che venivano così descritti: per Ridràcoli «[…] composto di viottoli appena praticabili […]», per S.Paolo in Alpe «[…] largo in modo che appena si può passarvi […]» e per il Corniolo «[…] è una strada molto frequentata ma in pessimo grado di modo che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio […] larga a luoghi in modo che appena vi può passare un pedone […]» (Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, Numeri Neri, 1707, citato da: L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 82, cit.). Inoltre, «[…] a fine Settecento […] risalivano […] i contrafforti montuosi verso la Toscana ardue mulattiere, tutte equivalenti in un sistema viario non gerarchizzato e di semplice, sia pur malagevole, attraversamento.» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi, 1992, p. 32, cit.). La viabilità di crinale e traversale che doveva essere ritenuta di rilievo a metà ‘800 si ritrova cartografata nella schematica Carta della Romagna Toscana Pontificia. Un breve elenco della viabilità ritenuta probabilmente più importante nel XIX secolo all’interno dei possedimenti già dell’Opera del Duomo di Firenze è contenuto nell’atto con cui Leopoldo II nel 1857 acquistò dal granducato le foreste demaniali: «[…] avendo riconosciuto […] rendersi indispensabile trattare quel possesso con modi affatto eccezionali ed incompatibili con le forme cui sono ordinariamente vincolate le Pubbliche Amministrazioni […] vendono […] la tenuta forestale denominata ‘dell’Opera’ composta […] come qui si descrive: […]. È intersecato da molti burroni, fosse e vie ed oltre quella che percorre il crine, dall’altra che conduce dal Casentino a Campigna e prosegue per Santa Sofia, dalla cosiddetta Stradella, dalla via delle Strette, dalla gran via dei legni, dalla via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe, dalla via della Seghettina, dalla via della Bertesca e più altre.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 163-164, cit.). Lo stesso granduca conosceva personalmente quei luoghi: «Io visitai i paesi, percorsi le strade attuali, difficili, perigliose, per conoscerne ogni specialità. […] Cavalcando […] vidi nel fondo della valle del Bidente […] seguitai alla volta di Appennino […] e presi il crine. Da tramontana e levante era Romagna quasi sotto ai piedi […] La foresta dell’Opera sulla pendice precipitosa verso Romagna era manto a molte pieghe dell’Appennino, al lembo di quel manto apparivan le coste nude del monte […] Sulli spigoli acuti delle propaggini del monte si vedevano miseri paeselli con le chiese: San Paolo in Alpe, Casanova, Pietrapazza, Strabatenza; impercettibili sentieri conducevano a quelli, e lì dissero le guide i pericoli del verno, la gente caduta e persa nelle nevi, […] i morti posti sui tetti per non poterli portare al cimitero, e nelle foreste i legatori del legname sepolti nelle capanne.» (F. Pesendorfer, a cura di, pp. 176-177, cit.). Con l’avvento di Leopoldo II, venne intensificato l’ammodernamento della rete stradale tanto che a metà dell’800 la Romagna toscana risultava attraversata da una rete di strade rotabili piuttosto ampia e gerarchizzata. L’opera del Siemoni, iniziata nel 1938, apportò significativi miglioramenti alla viabilità forestale e non solo, con la realizzazione di arterie quasi rotabili verso l’Appennino e l’ampliamento della rotabile casentinese verso la Consuma con la costruzione di ponti nel fondovalle, al fine di spostare il traffico di legname su strada tramite appositi carri tirati da muli. Nel processo di miglioramento stradale di epoca lorenese riguardante in generale l’intera Toscana ma anche l’area romagnolo-casentinese fu determinante l’istituzione nel 1825 del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade. Comunque, se l’Appennino occidentale già nella prima metà del XIX secolo vide la realizzazione delle prime grandi strade carrozzabili transappenniniche (Forlivese 1829-1882, Faentina 1832-1836 e del Giogo con variante della Futa 1749-1762 ammodernata nel 1820-1830), nel versante orientale i collegamenti erano sostanzialmente gli stessi di epoca romana, tramite la Via Sarsinate che correva lungo la Valle del Savio, superava Bagno di Romagna in direzione del Casentino e di Arezzo valicando l’Appennino come Via Romea Germanica o Via Romea dell’Alpe di Serra o Via Teutonica o Via Romea di Stade tramite il Passo di Serra, distante in linea d’aria circa 3 km dal futuro Passo dei Mandrioli, o tramite la Via maestra romana o Strada di Pieve attraverso il Valico di Montecoronaro, nota anche come Strada di Verghereto o Sentiero di Romagna, nell’800 classificata Strada maestra provinciale pur essendo una mulattiera. Per l’apertura e/o superamento dei valichi tra la valle dell’Arno e le valli del Bidente e del Savio con carrozzabili occorrerà attendere il periodo compreso tra la metà del XIX secolo e i primi decenni del XX. La prima opera di questo periodo fu la costruzione dell’interprovinciale n.18 Tosco-romagnola o Strada dei Mandrioli (oggi Strada Regionale n.71 Umbro Casentinese nel tratto toscano e Strada Provinciale n.142 dei Mandrioli nel tratto romagnolo), contemporanea all’apertura del Passo dei Mandrioli (1870-1882), ma il tratto S.Piero in Bagno-Sarsina fu inaugurato solo nel 1899. Seguì nel 1900 l’avvio dell’interprovinciale n.23 Tebro-Romagnola attraverso Verghereto, terminata nel 1932, che nel 1938 assumerà la denominazione di Strada Statale n.3bis Tiberina fino all’abbandono del tratto montano con la costruzione della E45 ed alla sua parziale interruzione per i frequenti dissesti. La Strada Provinciale del Bidente risale agli Anni Venti e Trenta; risale infine al 1960 il completamento della Strada Provinciale n.9ter del Rabbi e del Cavallino che valica l’Appennino alla Colla dei Tre Faggi.
LA GIOGANA
Lungo lo spartiacque geografico corre un tracciato viario che non solo fu il principale percorso di crinale del territorio romagnolo ma, considerato nell’intero sviluppo fino a Poggio Tre Vescovi, fu anche il più naturale collegamento di tutta la penisola. In corrispondenza delle maggiori asperità si allontana dallo spartiacque posizionandosi su uno dei due versanti, più spesso quello toscano esposto più favorevolmente a Mezzogiorno, ma sostanzialmente si sposta per ragioni orografiche. Come sopracitato, nelle mappe storiche e nei documenti antichi questo tratto o parti di esso era detto Giogo o giogana o La Giogana, da jugum, termine utilizzato quindi nell'ossimorico significato di “congiungimento”, “unione”, “collegamento”, che in effetti evoca (in contrasto con l'apparente impedimento appenninico) quando si riferisce, p. es., allo strumento che collega una coppia di buoi. Nel vocabolario on-line Treccani, tra i tanti significati della voce “giogo”, l’ultimo paragrafo, il 6.a., recita “sommità di montagna lunga e tondeggiante” come interpretazione dei due versetti danteschi “ch'io fui d'i monti là intra Orbino / e 'l giogo di che Tever si diserra” (Inferno, XXVII 29-30), dove si potrebbe ritrovare il riferimento al Monte Fumaiolo o a tutta o parte della catena appenninica; viene inoltre citato il Foscolo “Che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!” (Dei Sepolcri, 165, 1807). Il paragrafo “b” recita: «Valico montano; il termine compare in toponimi alpini (per es., Giogo dello Stelvio), spesso con varianti dialettali (ladino dolomitico giou, giau), e in toponimi appenninici (per es., Giogo di Scarperia).» (https://www.treccani.it/vocabolario/giogo/ - controllato il 05/2025). Dante utilizza il termine anche nel Purgatorio: “Indi la valle, come ’l dì fu spento, / da Pratomagno al gran giogo coperse / di nebbia; e ’l ciel di sopra fece intento,” (V, 115-117); la terzina viene così interpretata: «'l'alpe di monte Appennino, che sono sopra l'Ermo di Camaldoli' (Anonimo), 'la giogaia appenninica o (in una interpretazione più puntualizzata) la giogaia di Camaldoli' (Mattalia)» (A. Lanci, Enciclopedia Dantesca (1970) - https://www.treccani.it/enciclopedia/giogo_(Enciclopedia-Dantesca)/ - controllato il 05/2025). Più recentemente venne descritto il «[…] giogo di Camaldoli, al di là del quale cessa la Comunità di Pratovecchio e sottentra dirimpetto a grecale quella transappenninica di Premilcore.» (E. Repetti, Dizionario geografico fisico e storico della Toscana, 1881-1883). Riassume il significato con molta precisione l’Intelligenza Artificiale (AI) introdotta di recente nelle aperture delle ricerche su Google: «Il 'giogo appenninico' si riferisce a una serie di valichi montani e rilievi che attraversano l'Appennino, particolarmente nel tratto tosco-romagnolo. In questa regione, il termine 'giogo' è utilizzato per indicare un passo montano, un crinale o un massiccio montano che separa due vallate o regioni diverse. In sintesi, il 'giogo appenninico' designa un insieme di punti geografici, valichi e rilievi montani che caratterizzano la dorsale appenninica e svolgono un ruolo importante per la morfologia della regione e per i percorsi di attraversamento» (Voce “giogo appenninico”, Google AI Overview - controllato il 05/2025).
Posto all’estremo occidentale del nostro tratto di Spartiacque il complesso del Falterona, oltre che snodo degli itinerari tra Romagna, Casentino e Mugello-Val di Sieve, ha costituito un luogo di antichissime frequentazioni: basti ricordare che il termine Falterona è ritenuto (A. Polloni, G. Caselli, G. Devoto) una probabile derivazione di falteria, faltera, dall’etrusco Faltru o Falter, con la stessa radice dei nominativi etrusco-latini Faltonius, Faltinius, Falterius, Faltius, oppure riferibile alla radice latino-etrusca fal, con il significato di altura o una forma rotonda che ha la funzione di coprire la volta celeste, o all’italico antico falto, scosceso, franato, con suffisso accrescitivo tipico dei monti, come Cimone, Aquilone, etc. In collegamento con il termine truna, “potere” o “principio”, si forma il termine Faltruna, ovvero “principio celeste”. All’aspetto ultraterreno assegnato alle alture dalla cosmologia etrusca anche riguardo i criteri fondativi delle strutture urbane, occorre aggiungere gli aspetti legati al culto delle acque d’alta montagna, rivestiti di sacralità come in tutte le società pastorali, corroborato dalla presenza sul versante meridionale, a circa 1400 m di quota, del noto Lago degli Idoli (c.d. dalla scoperta, nel 1838, nell’allora Lago della Ciliegieta, di una statuetta di bronzo cui ne seguirono oltre 600 insieme a migliaia di pezzi informi, punte di freccia, etc.) e, poco distante, delle sorgenti dell’Arno. Da notare che il Monte Falco storicamente non viene richiamato mentre compare spesso “la Falterona”. Così avviene nella descrizione di Emanuele Repetti: «Da quella sommità della Falterona fra il Poggio Mocali, Prato al Soglio e il poggio a Scali, sul giogo onde a Camaldoli si viene […]» (E. Repetti, Dizionario geografico fisico e storico della Toscana, 1881-1883). Carlo Beni nella prima edizione della sua Guida pare non averne contezza: «[…] quantunque la Falterona non sia un monte altissimo, tuttavia la sua posizione centrale gli apre dintorno un orizzonte e panorama vastissimi. […] (2) […]. La veduta abbraccia gran parte dell’Italia centrale avente per confine il Mare Adriatico, e il Mediterraneo, che da lontano appariscono come due grandi strisce d’argento. Le città della Romagna fino alla costa Adriatica, quelle di Arezzo e Firenze coi loro monumenti si distinguono perfettamente. Più lunge s’ergono il Monte Amiata, il Cimone, le Montagne di S. Pellegrino, l’Alpi Apuane […]. Discesa a levante la piramide della Falterona per un forte pendio, si trova subito la via del Sodone, che è la prosecuzione di quella di Montelleri, e che passato il Valloncino, porta a un bel prato coperto di finissima erba, chiamato il Sodo de’ Conti, ove comincia il possesso ex-granducale della Casa di Lorena. Questa foresta è ricca di selvaggina, e specialmente di cervi, che chiusi un tempo, e riacquistata poi la naturale libertà, si sono straordinariamente moltiplicati, tornando ad essere oggetto di lecita caccia.» (1881, pp. 54-55, cit.), ma la seconda edizione contiene una specifica integrazione al periodo citato: «Dal vertice triangolare della Falterona si scende verso levante per un forte pendio di fronte al quale s’erge un altro monte chiamato Monte-Falco, che gareggia in altezza colla Falterona.» (1889, p. 188, cit.). Probabilmente la formazione del toponimo nel XIX secolo non si era ancora sedimentata del tutto e solo l’inizio del turismo invernale portò a rievocare quel caratteristico profilo associato alle forme e alle frequentazioni del noto rapace frequentatore di un habitat favorevole alle sue necessità predatorie. Il toponimo M. Falco pare infatti che compaia per la prima volta nella Carta topografica d’Italia I.G.M. di primo impianto in scala 1:100.000 (per l’Emilia-Romagna rilevata negli anni 1877-95), mentre nella Carta storica regionale o Carta Topografica Austriaca del 1853, in scala 1:86.400, i toponimi montani dell’area sono limitati ai seguenti, così trascritti: M. Falterona, P.o Martino, Pog.o Palaio, Gabrendo. Solo il Falterona è riportato anche nella settecentesca PIANTA DELLA CONTEA D’VRBECH (da alcuni ritenuta riguardante la riconfinazione granducale del 1565, che conciliava le circostanti realtà comunali con la superstite enclave feudale), conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze (M. Massaini, 2015, cit.), dove tuttavia sono rappresentate le pendici del Falco interessate dagli Abeti di S. M. Nuova e dagli Abeti di S. Maria del Fiore.
Carlo Beni nelle edizioni della sua Guida, oltre che descrivere gli aspetti ambientali e archeologici del monte, ricorda la vivace tradizione della sua epoca di giungervi la notte per attendere l’alba, esposti a freddo ed intemperie, per cui nel 1881 propose al CAI di costruire una Capanna di ricovero «[…] che venne giudicato per uno de' più belli fra i Ricoveri alpini; tantochè dalla gente di quassù e della vicina Romagna viene fastosamente chiamato il Palazzo di Falterona. A questo Ricovero si riferisce direttamente la singolare e paurosa leggenda dell'anima di un peccatore impenitente lassù confinata ed errante, del diavolo sotto forma di una capra, di ombre, di rumori, di spiriti ecc., leggenda che da noi resa nota all'amico Onorevole Conte Tommaso De Cambray-Digny, fu da esso leggiadramente volta in poesia e pubblicata nell'Annuario della Sezione forentina del C. 11. I. dell' anno 1886, al quale rinviamo il lettore […]. Il Ricovero, costruito in piena muratura con rivestimento di bozze di pietra arenaria (macigno sereno), è posto sul pendio occidentale del monte a un tiro di fucile dalla sommità. È di figura rettangolare, misurando metri 11,20 per 8,20, metri 5 nel comignolo e 3:20 in gronda. Si compone di 4 stanze convenientemente mobiliate e di una soffitta: la prima stanza, col focolare, è accessibile a tutti; le altre (cucina, due camere e soffitta) sono riservate per gli alpinisti e i turisti, e sono chiuse con chiave depositata presso le Direzioni della Stazione Alpina di Stia e della Sezione di Firenze. Ci piacque poi chiamarlo Ricovero Dante e, come vedremo, non sine quare, ponendo sulla porta d'ingresso questa iscrizione: Presso le fonti dell'Arno / ispiratrici di divina poesia / auspice la sezione fiorentina / del Club alpino italiano / fu dai Casentinesi costruito / questo Ricovero a Dante intitolato / giugno 1883.» (C. Beni, 1889, pp. 180-181, cit.). La Guida del 1889 contiene anche una foto del ricovero tra la neve mentre posano dinanzi ad esso alcuni spalatori ed anche le cartoline postali dell’epoca lo ritraggono insieme a militari e cacciatori. La Carta d’Italia I.G.M. del 1894 ne documenta l’esatta quota a 1621 m a circa 100 m SO dalla vetta, mentre nella successiva edizione del 1937 compaiono ormai i 4 puntini simbolo dei ruderi.
Nel Catasto toscano tutto il tratto tra il Monte Falco e Giogo Seccheta, oggi agevolmente percorso dal sentiero 00GEA, era essenzialmente detto Crine dell’Appennino, probabilmente in quanto non era ritenuto di interesse viario, mentre dal Passo della Calla fino a Poggio Scali le Bozze di mappe catastali della Foresta Casentinese e Campigna, per tale area contenenti un rilievo più approfondito, individuavano un Raggio Segaticcio o Raggio Lungo presso Il Poggione, una Strada che va a Camaldoli fino a Poggio Scali e una Strada dell’Alpi che proseguiva oltre il Passo del Porcareccio. Una via bordonaia tra il Passo della Calla e Poggio Pian Tombesi è inoltre documentata nel ‘600. Si ritrova quindi una Via della Giogana che dal Casentino risale a Giogo Seccheta e giunge a Prato Bertone per poi scendere all’Eremo. Nel catasto antico più oltre non compare viabilità di crinale ma solo di valico, con l’attuale Gioghetto detto Fonte al Sasso, i toponimi La penna sul sito di Prato alla Penna, La giogana sul tratto di crinale orientale successivo, oggi attraversato dall’ampia pista del 00 CAI, e un antico Il Gioghetto al bivio verso Poggio Tre Confini nello scavallamento prima della discesa a Fangacci (toponimo all'epoca già formato) presso cui compare la Fonte dei Beventi o del Gioghetto. La prosecuzione è detta Via dall’Eremo in Romagna, diretta al Sodo di Rombicetina sul luogo del Passo della Crocina presso Poggio dello Spillo, mentre un luogo detto La Crocina si trova sul picco occidentale del poggio verso il Monte Penna già detto Poggio delle Ripe Bianche. Nelle Bozze di mappe catastali questo tratto è detto Strada di legni che va alla Bertesca a testimoniare l’utilizzo anche per l’esbosco. La Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese documenta perfettamente questo sviluppo del tracciato viario. Strada vicinale della Giogana è la denominazione catastale che oggi conserva il tratto escursionistico compreso tra il Passo della Calla e Prato alla Penna noto come La Giogana, con l’aggiunta o della Bordonaia o dei Legni per i tratti a ciò specificamente dedicati sui rispettivi versanti.
Come detto, anche La Giogana fu sicuramente frequentata già in era paleolitica e dai primi gruppi pre-italici durante le loro migrazioni e in epoca romana era percorsa o attraversata anche da vie militari, attestato da reperti, pur avendo perso la viabilità di crinale una funzione portante. Il tracciato è rimasto in funzione fino alla prima metà del secolo scorso come via di comunicazione anche automobilistica ma, in ulteriore considerazione dell’elevata altitudine e della scarsità di sorgenti, non ha mai registrato la presenza di insediamenti, salvo alcuni più recenti e specializzati con finalità turistiche nel tratto a monte di Campigna. Già da epoche storiche boscaioli che trasportavano legname a dorso di mulo o conduttori di grossi traini di legname vi transitavano per raggiungere i passi montani; fino al XIX secolo fu inoltre interessata dalla transumanza, pratica talmente diffusa da dover essere regolamentata da parte delle amministrazioni demaniali, secondo regole rimaste invariate dal medioevo alla liberalizzazione dell’ultimo scorcio del XVIII secolo, stabilendo gli itinerari e istituendo le dogane, a fini di controllo e fiscali: «Pastori e bestiame che andavano a passare l’inverni in Maremma avevano certe strade prescritte dall’Appennino fino in Maremma, dette strade doganali. […] Nell’entrare in Maremma vi erano altre dogane dette Calle: a queste bisognava presentarsi, far contare il bestiame e pigliar le polizze. Terminata la stagione della pastura bisognava presentarsi alle medesime Calle, far riscontrare il bestiame e riportarlo con un 10 per cento di aumento […]» (Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, 1774, in: P. Marcaccini, L. Calzolai, La pastorizia transumante, in: N. Graziani (a cura di), 2001, p. 114, cit.), inoltre «[…] i pascoli maremmani di “dogana” erano aperti e chiusi, ufficialmente, […] il giorno 29 settembre […] l’apertura e 8 maggio la chiusura.» (M. Massaini, 2015, p. 73, cit.). Il bestiame, spesso affidato in soccida a pastori specializzati, affluiva nel fondovalle dell’Arno in modo minore dalle alte valli del Bidente e del Savio ma soprattutto dalla montagna di Camaldoli per proseguire per Siena e la Maremma, le pasture Maretime. «Ma non mancava naturalmente bestiame vaccino liberamente pascolante sulle più alte pendici. Conosciamo, per questo aspetto, non soltanto quello di proprietà dei montanari, ma anche le vacche di certi proprietari ecclesiastici come il monastero di Camaldoli […]. E sappiamo, più in generale, che lungo tutta la giogaia, sull’uno e sull’altro versante, tanto i privati che quanto i signori feudali avevano greggi numerose […]» (G. Cherubini, L’area del Parco tra Medioevo e prima età moderna, 1992, in: G.L. Corradi, 1992, p.20, cit.). Praticamente la foresta era diventata, con grave danno, una grande stalla all’aperto (G. Chiari, 2010, cit.), d'altronde, da sempre, «[…] quel settore dell’Appennino che ha al suo centro la valle del Casentino, e che si estende a tutto il Montefeltro e il Mugello, […] corrisponde con precisione all’area dei pascoli estivi di quell’economia basata sulla transumanza che dà un senso economico e culturale al territorio geografico dell’Etruria storica.» (G. Caselli, 2009, p. 22, cit.). «L’allevamento ovicaprino era l’utilizzo più redditizio del suolo, molto più dei cereali, per l’ampia gamma dei suoi derivati: latte e formaggi, lana, pelli indispensabili per la pergamena dei libri prima dell’invenzione della stampa. I proventi della transumanza, anche se non regolamentata come nella civiltà romana nel centro-sud della penisola, o dall’oculata amministrazione della città-stato di Siena nel medioevo, dove ne nacque la più antica banca d’Italia, il Monte dei Paschi (cioè dei pascoli) in Casentino, conca privilegiata dal passaggio dei transumanti, perché più ricca di acqua, dettero ricchezza e potere ai feudatari e alle popolazioni.» (A. Fatucchi, pezzullo in 4a, in: F. Trenti, a cura di, Bibbiena, 2015, p. 24, cit.).
Come accennato, La Giogana attraversa o lambisce anche la memoria degli antichi possedimenti dell’Opera del Duomo di Firenze, che si estendevano da Poggio Corsoio a Cima del Termine, confinando (con dispute) ad Ovest con i possedimenti dello Spedale di S. Maria Nuova di Firenze e ad Est con quelli del Monastero di Camaldoli. Sul versante toscano di Poggio Sodo dei Conti, presso il Monte Falco, si estendeva fino al crinale la Contea di Urbech in base ai confini stabiliti nel 1561 da Cosimo I de’ Medici, che intendeva «[…] togliere ogni giurisdizione dei conti d’Urbech su Stia […] residuo di vecchi e arcaici diritti medievali […] “per motivi di ordine pubblico”.» (M. Massaini, 2015, p. 100, cit.). Dall’atto stilato dal cancelliere si rileva che per la ridefinizione dei confini fu necessario ispezionare l’intero tracciato posizionando appositi segnali, spesso consistenti in cippi lapidei detti “termini”. Il tratto di confine orientale diretto al crinale seguiva «[…] il fiumicino che passa sotto la chiesa di Monte Mezzano. […] La delimitazione della contea, seguendo il torrente citato, arrivava fino al crinale dell’Appennino. Il punto esatto fu evidenziato da due segni di croce su un grosso faggio, che si trovava a 350 braccia dalla sommità, quindi, da questo […] la demarcazione andava dritta al crinale (quinto termine). Seguendo il crinale a sinistra, verso l’attuale Passo della Calla, la delimitazione proseguiva «[…] fino “… ai termini e chonfini che sono fra li omini di Porciano e li Chonti d’Orbeco da una, e li omini di Rincine e Fornace dall’altra …”. Qui ci sarà il sesto termine.» (M. Massaini, 2015, pp. 100-101, cit.). I corsi d’acqua citati paiono corrispondere al Fosso di Monte Mezzano e al suo confluente Borro delle Fogne, che risale verso lo Spartiacque presso il Poggione, dove comprensibilmente non si rintracciano cippi risalenti a cinque secoli addietro, anche perché probabilmente rimossi dopo pochi anni. Infatti, a seguito di numerosi ricorsi, nel 1563 viene annullato l’atto del 1561 ridimensionando notevolmente il territorio della contea e tra l’altro si ristabilisce il confine da Montelleri al crinale presso il Falterona, che da qui seguiva la «[…] “… via della Cavata, overo Bordonaia e continuando per la detta via su la giogana per spazio di un terzo di miglio, o più o meno, infino alla dirittura del fossato dove comincia el fiume della Loia …”.» (M. Massaini, 2015, p. 104, cit.). Questo punto del crinale è facilmente individuabile nel sito di Sodo dei Conti, nei pressi della stazione radio militare, dove nasce il Fosso di Mandria d’Orso cui segue il Fosso dell’Orticheto, ramo del Torrente Oia che costituisce quindi confine orientale della contea, dove Ducci e Maggi nella loro opera (p. 29, cit.) hanno individuato un cippo con incisione FC (Foresta Casentinese) le cui caratteristiche fanno presumere una datazione pre-ottocentesca, risalente forse all’epoca dell’acquisizione (1785) della Foresta di Monte Corsoio, fino ad allora appartenente all’Opera di S. Maria Nuova. La Carta Geometrica mostra da questo punto un’area boscata che scende nel versante toscano corrispondente alla sopracitata Faggeta Granducale, confinante con la contea. Da una relazione del 1663 conservata nell’Archivio dell’Opera del Duomo: «[…] partimmo di Campigna e si andò a far la visita della faggeta di SAS et il confino dei Signori Conti di Urbech, andammo alla Stradella e preso il Giogo verso ponente si arrivò ai prati dei Signori Conti e si scese per una lunga e precipitosa strada che ne leva il nome dal luogo detto Poggio di Rovineto […] et si vedde molti faggi tagliati nella macchia di SAS et seguitando per detta faggeta che si era smarrito la via et tra le traverse de faggi tagliati et de rotti si durò gran fatica a condursi alla Fonte del Rovineto e Giovannella ci disse che era in dubbio chi appartenesse e di chi fosse se de Signori Conti o di SAS .... che i danni de faggi erano circa un miglio vicino alla giogana. Da detta fonte si traversò a sinistra per la detta macchia si andò per alla volta del Giogherello e si attraversò per parecchi ronchi che sono drento detta faggeta di SAS […] e si arrivò al Giogherello e si vedde faggi belli assai e senza alcun danno e poi si ritornò alla Stradella […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 311, cit.). Al Sodo dei Conti oggi si attraversa la Riserva Naturale Integrale di Monte Falco-Poggio Piancancelli con le sue praterie di vetta dove vegetano rare formazioni erbacee d’alta quota mentre il faggio cresce sulle pendici nodoso e contorto mantenendo dimensioni arbustive a causa dei forti venti. Nei prati di Poggio Sodo dei Conti, anche presso il sentiero transitabile, è facile notare la Viola di Eugenia (Viola eugeniae Parl. subsp. Eugeniae); numerose altre specie rare o rarissime per la Romagna o qui raggiungenti il limite del loro areale di distribuzione, di solito sono localizzate tra le rocce pertanto inaccessibili ma possono sconfinare anche ai bordi delle praterie e del sentiero battuto, per cui un occhi attento può riconoscerle, come p.es., ben cinque specie di Sassifraghe o lo Sparviere del calcare o Ieracio villoso (Hieracium villosum Jacq.), rarissimo nel Parco è noto solo per le rupi di Monte Falco ma è capitato di trovarlo in qualche passaggio impervio del sentiero che lo attraversa.
Stradella è il toponimo anticamente citato varie volte tra il XVII e il XIX secolo apparentemente per indicare un luogo specifico sul Giogo, come nella citazione sopra riportata ma dall’esame delle citate Bozze di mappe catastali esso si trova scritto accanto ad un lungo fabbricato rettangolare posto nella selletta tra Poggio Lastraiolo e il Monte Gabrendo oggi nota come Prati della Burraia. Non è nota l’esistenza del fabbricato all’epoca delle citazioni documentali più antiche, comunque per estensione e per come menzionato avrebbe potuto riguardare anche il luogo dell’insediamento. Il sito costituiva la tappa sul crinale della Gran via dei legni che discendeva al Porto di Badia a Poppiena a Pratovecchio seguendo la dorsale Monte Giogarello-Monte Tufone. Anche Rombai e Sorelli ritengono che a inizio Ottocento la «[…] principale via dei legni [fosse quella proveniente da, ndr.] Le Burraje […]» (La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p.95, cit.). Già il Repetti nel segnalare i miglioramenti alla viabilità forestale nell’epoca del Siemoni pare privilegiare il tragitto da Stradella, benché nominasse il vicino Sodo de’ Conti essendo l’altro toponimo in disuso: «Fra le nuove strade aperte in cotesto Appennino per il traino degli abeti, e che entrano nel territorio di Pratovecchio, due sono le principali, cioè, quella che dall’abetina di Campigna, rimontando la valle del Bidente di Ridraccoli [Corniolo, ndr.], passa il giogo dell’Appennino al Sodo de’ Conti, luogo dove entra a confine con questa di Pratovecchio la Comunità di Premilcore, nel di cui territorio d’allora in poi attraversano le vie de’ legni, che una diretta per Gaviserri e l’altra per Casalino […] le quali strade riunite si dirigono sulla ripa sinistra dell’Arno sotto Pratovecchio, piazzale del porto di Poppiena.» (1841, p. 668, cit.).
Poiché le Bozze di mappe catastali che documentano il fabbricato sono antecedenti all’arrivo di Siemoni è da ritenere che il boemo nel 1853 non compì grosse ristrutturazioni ma apportò delle migliorie al fabbricato (come attesta una pietra incisa con tale data conservata all’interno e venuta in luce nel corso dei moderni restauri) mentre aggiunse un piccolo edificio posto ad Est della stalla con l’abitazione del custode, il forno ed i rinomati locali per la lavorazione del latte: per usufruire del diretto apporto idrico venne razionalmente costruito sopra la fonte, già presente nel catasto, come confermerebbero alcuni resti di murature e il raffronto con un’interessante foto del 1929 di Pietro Zangheri che documenta tali edifici e due cartoline risalenti agli Anni Quaranta/Cinquanta dove compaiono anche un capanno minore posto tra i due edifici e tre capanni posti sul margine dei prati, distanziati tra essi (le cartoline furono edite dalla Cartolux di Torquato Nanni Jr., le figlie ricordano che negli Anni Trenta e Quaranta il padre andava in giro per la Romagna a fotografare). Il complesso prese il nome di Burraia dei Prati o la Burraia, ed è così citato anche da Carlo Beni nella sua Guida del Casentino : «Dal Sodo de’ Conti la via comincia a discendere dolcemente in direzione di levante, e dopo breve cammino sempre sul crine del monte, si giunge ai bei prati della Stradella (metri 1429), in mezzo ai quali sorge un capannone di pietra, detto la Burraia, conosciuta pel suo buon latte e squisitissimo burro. Più sotto si vede la gran fattoria di Campigna circondata a nord da una bellissima foresta di abeti, mentre al di sopra della Stradella si innalza il poggio Caprenno, che gareggia in altezza con quello della Falterona. Dal lato nord-est di poggio Caprenno per un sentiero sassoso si scende alla Calla […].» (1881, pp. 55-56, cit.). Qui si recò in visita nel 1854 Leopoldo II e lasciandone descrizione nelle sue Memorie: «L’indomani varcai l’Appennino alla nuova mia cascina della Stradella, dimora per li uomini e le mucche nell’estate soltanto, il più elevato luogo abitato di Toscana, ove è rifugio ai viandanti presi dalle procelle o dalle nevi nella via che è breve, ma perigliosa, da Casentino nelle Romagne.» (F. Pesendorfer, a cura di, 1987, p. 419, cit.). Dell’insediamento antico oggi rimane solo l’edificio della ex-stalla, fino al 1947 utilizzato come stazione radio militare (probabilmente installata negli Anni Trenta-Quaranta in concomitanza con gli eventi bellici), così come i due capanni minori e i tre capanni di cui alle cartoline sopracitate, due in legno ed uno in muratura, evidentemente casermette realizzate nella stessa epoca ed utilizzate dai militari presenti per servizio e/o esercitazioni; le casermette, di cui una utilizzata negli Anni Cinquanta dallo Sci Club di Stia, sono documentate ancora esistenti all’epoca della costruzione del Rifugio Città di Forlì (1974) ma successivamente sono state demolite. Nel 1951 è stato ammodernato, funzionando dapprima come colonia antitubercolare, poi colonia estiva. Divenuto proprietà della Regione Emilia-Romagna, dal 1974 è gestito dalla Sezione CAI di Stia ed è noto come Casone della Burraia o Rifugio La Burraia.
L’impianto sciistico della Burraia è nato ai primi del ‘900 quando Carlo Beni, nativo di Stia, a seguito di esperienze sciistiche in Svizzera, decise di diffondere anche qui la cultura di quello sport e la produzione di sci in legno di frassino, ma solo dal 1950 l’area fu interessata dall’infrastrutturazione turistica postbellica e vide la luce lo Sci Club di Stia, promotore della realizzazione del comprensorio sciistico Fangacci/Burraia, che agli inizi degli Anni Sessanta contava 3 impianti meccanici di risalita, 3 piste di discesa che si snodavano a valle dalla cima del Monte Gabrendo e i due rifugi Chalet e La Burraia. Tuttavia, fu fortunatamente evitato lo «[…] scempio urbanistico minacciato nelle due località di Campigna e Badia Prataglia.» (F. Clauser, 2016, p. 72, cit.), diretto … «[…] ad ottenere una ben più alta e deleteria incidenza di strade, ville e negozi all’interno della foresta (richiesta della creazione di un villaggio turistico in Campigna).» (P. Bronchi, 1985, p. 109, cit.). La prima pista sciistica dal Gabrendo ai Prati della Burraia risale agli anni 1952-55, cui seguì l’impianto di risalita collegato alla prima stazione invernale del luogo, oggi Chalet Burraia, struttura nata negli Anni Trenta come servizio per escursioni appenniniche; fece seguito nel 1958 l’impianto Fangacci/Sodo dei Conti. Lo skilift del Gabrendo è stato poi abbandonato e definitivamente smantellato nel 2016 con riqualificazione dell’area. Nei primi Anni Sessanta anche a Campigna un modesto skilift consentiva di sciare lungo la pista che scende a Villaneta. Altri rifugi tutt’ora operanti ed edificati come servizio sia degli impianti sciistici che del turismo montano sono il CAI Città di Forlì posto al margine dei prati, edificato nel 1974 in corrispondenza di un fabbricato documentato dalla Carta Geometrica della Regia Foresta con il toponimo Capanna, e il Rifugio La Capanna, da cui parte lo skilift che raggiunge il crinale nei pressi di Sodo dei Conti a circa 300 m dall’innesto della Pista del Lupo, quale ammodernamento dell'impianto del ’58. Altri impianti sciistici odierni sono le piste di fondo e lo snow park dei Fangacci, presso il quale si trova il moderno Rifugio di Beppe (attrezzato per le grigliate al coperto).
Entrambi gli oronimi del tondeggiante Monte Gabrendo, già Poggio Caprenno, sono descrittivi del suo utilizzo pascolivo, che probabilmente interessava gran parte della sua superficie e di cui è rimasta una vasta prateria che occupa parte della sua sommità e della sella che si prolunga nei Prati della Burraia, già detta Stradella: «GABRENDO, Monte (Falterona), […] è anche scritto GLABRENDO e […] Glabredinus. Alteraz. di lat. med. rustico glabretum = luogo glabro < lat. glaber, -a, -um […], ital. glabro, tosc. gabbro (terra) sterile […].» (A. Polloni, 1966-2004, p. 131, cit.).
Il Passo della Calla «[…] è il varco più basso dell’Appennino, per cui passa la mulattiera che da Stia conduce nella vicina Romagna.» (C. Beni, 1881, p. 56, 57, cit.). Il termine calla anticamente aveva il semplice significato di varco, come concordano due autori, P.L. della Bordella: «[…] ”Calla, id est stretta via”, “calles”, in latino significa propriamente viottoli stretti fatti dal callo … de’ piè degli animali, onde dichiamo ‘calle’ … […]» (C. Landino, Purgatorio, IV, 22, cit. da: P.L. della Bordella, 2004, p. 208, cit.), e G. Caselli: «[…] sono certo che deriva dal teutonico KALLA, un apposito passaggio in una siepe dove si contano le pecore per far pagare la dogana. […] ovvero: luogo dove si “chiamano” (kall), o contano le bestie che vanno o vengono dai pascoli.» (G. Caselli, 2009, pp. 144, 193, cit.). L’uso del termine venne “istituzionalizzato” con gli statuti comunali e statali quattro-cinquecenteschi: infatti, prima dell’abolizione della dogana dei Paschi e della liberalizzazione della transumanza (1778) una serie di “passi” o “calle” di dogana, assoggettati ai vincoli del regime mediceo-granducali, vennero disposti a raggiera a sud dell’arco montano e sullo stesso, lungo percorsi di transito: «[…] sicuramente dal varco della Calla, il cui significativo toponimo indica – come quello del Sodo alle Calle, presso l’altro punto di valico del Giogo Seccheta – un evidente tracciato di transumanza lungo una direttrice in cui venivano in parte a coincidere vie dei pastori, “vie dei legni” e vie di altro uso pubblico (“via da Stia per Campigna e S. Sofia”).» (L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in: G.L. Corradi e N. Graziani - a cura di, 1997, p. 51, cit.). La Calla è ancora detta un’ampia area delle pendici SE del Monte Gabrendo, ricadente nel versante toscano, dove probabilmente si ammassava il bestiame in attesa della conta.
Quanto rimaneva dell’antica dogana è stato demolito dall’Anas in occasione della realizzazione dell’ampio piazzale e sul suo sedime è stata costruita la casa cantoniera, abbandonata anch’essa e ormai ridotta a rudere alla data di passaggio di competenze alla Regione Toscana con la riclassificazione delle strade. Messa all’asta dalla Regione nel settembre 2017, il nuovo proprietario ha dato corso alla ristrutturazione finalizzata all’uso bed and breakfast (è prevista una dotazione di 10 camere articolate fra i due piani e la mansarda, con sala per le prime colazioni al piano terra). Nel passo sorgono il Rifugio CAI La Calla e la struttura in legno del Ristorante I FAGGI della stessa proprietà dell’ex cantoniera. Vi si trova inoltre la Madonna della Foresta, maestà ricavata in una grande sezione cava di tronco d’albero, il Monumento a Dante Alighieri (NEL CUORE DELLA FORESTA SPESSA E VIVA / SUL DORSO DELL’ITALIA BELLA / E NEL RICORDO DELLA DIVINA POESIA / VADA IL PENSIERO AL NOME IMMORTALE / DI / DANTE), e il Memoriale Pio Campana medaglia d’argento della Resistenza.
In base alla Carta Geometrica delle Regie Foreste sul Passo della Calla confluivano alcune Strade dette dei legni per il trasporto dei medesimi, tra cui l’Antica via dei Legni riportata dalle Bozze di mappe catastali e oggi corrispondente al sentiero 241 CAI, ad avvalorare il prevalente di interesse ad uso forestale della viabilità locale, ma i catasti davano conto anche del valore come strada di comunicazione dell’asse principale di valico, indicato come Strada romagnola, o Strada della Calla, o Strada di Campigna o infine come Castagnina, in quanto conducente ai castagneti di comunità. Per scendere dal passo a Campigna Karl Siemon, forse anche “per le comodità granducali”, fece sistemare e lastricare il tratto di mulattiera, oggi segnalata come “antica mulattiera granducale” tanto da poter essere ricordata come Mulattiera del Granduca. Tra gli Anni Venti e Trenta verrà costruita la rotabile transappenninica tra S.Sofia, Stia e il Casentino attraverso il passo: «La nuova strada S. Sofia – Stia, bellamente pianeggiando sotto il Corniolo, attraversa il Bidente che viene dalle Celle e poi inizia l’ascesa del monte verso Campigna poco più su dal luogo donde si diparte, a sinistra, la mulattiera che mena a S. Paolo in Alpe ove, fino al secolo XVI, era un eremo agostiniano.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 270) L’inaugurazione della futura Strada Provinciale del Bidente (SP 310 in Toscana e SP 4R in Emilia-Romagna) risale al 27 ottobre 1932 e per conoscere lo stato della viabilità a cavallo dei due secoli è interessante esaminare la Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1894, che mostra il tratto tra il passo e Campigna rappresentato con la simbologia corrispondente alle Strade a fondo naturale, senza manutenzione regolare, non sempre praticabili, mentre nel versante toscano la Strada carreggiabile risalente da Stia è rappresentata fino al fabbricato oggi noto come Aia delle Guardie, posto in prossimità della Fonte di Calcedonia, cosiddetto come probabile lascito toponomastico del luogo noto in quanto anticamente sede delle guardie addette alle mansioni di controllo della transumanza, mentre il fabbricato è relativamente recente in quanto riportato in cartografia a partire dalla Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1894. Gli altri tratti di entrambi i versanti sono rappresentati con la simbologia della Mulattiera, ovviamente strade realizzate e tenute per il passaggio di carovane di muli o cavalli. Nella successiva mappa del 1937 si nota che la nuova provinciale è stata completata nei tratti Stia-Campigna e S.Sofia-Faltroncella, sulle pendici del Monte della Maestà, mentre non è rappresentato il restante tratto romagnolo fino a Campigna, a dimostrazione del maggiore legame del capoluogo con la Toscana piuttosto che con la Romagna, legame sciolto dal punto di vista amministrativo solo nel 1923 con il decreto di annessione alla Provincia di Forlì. Oltre all’asfaltatura, risalente agli Anni ’60, la nuova provinciale, specie nel tratto alto toscano è stata assoggettata a modifiche di tracciato, lasciando tratti oggi riutilizzati dalla sentieristica. Di interesse per la conoscenza delle caratteristiche della viabilità di montagna della prima metà del XX secolo è l’ampio tratto inghiaiato e in parte selciato che dal bivio presso la Fonte di Calcedonia raggiunge, con una successione di ripidi tornanti che intersecano i resti dell'antica Strada Romagnola, l’area del passo presso il rifugio; oggi è riutilizzato come viabilità forestale e in parte dal sentiero 80 CAI.
Come accennato, per il pellegrinaggio diretto all’Eremo di Camaldoli e per l’escursionismo, La Giogana (anche come parte della GEA, dell’Alta Via dei Parchi, della Transparco, de Il Cammino di S.Antonio, del Cammino di S. Vicinio, del Cammino Dantesco, del Sentiero delle Foreste Sacre ed altri, che con i loro loghi e targhette colorate affollano il percorso) inizia dal Passo della Calla presso il Memoriale Pio Campana e dopo pochi metri transita alta sul retro dell’ex cantoniera destinata al riuso turistico. La risalita si attenua a Pian delle Carbonaie, ampia sella e radura erbosa, residuo delle attività evocate dall’oronimo, noto almeno dall’800, ma anche area di “imposto” e di transito del legname come mostrato dalle Bozze di mappe catastali con la Strada Antica via dei Legni che da qui si distaccava, oggi corrispondente al Sentiero delle Cullacce, che oggi si inoltra sul versante settentrionale verso l’area omonima, ma escluso dai percorsi escursionistici. Sul versante romagnolo si rasenta il confine della parte orientale della Riserva Biogenetica Statale di Campigna, che si estende su circa 1200 ettari di territorio fino al Monte Falco, ed è infatti compresa tra un’altitudine di 1650 m s.l.m. e 850 m s.l.m. La formazione geologica prevalente della Riserva è costituita dall’arenaria oligocenica con alternanza di strati compatti e strati di scisti limoso-argillosi molto friabili, immersi dal versante romagnolo verso quello toscano così da determinare la ripida e a tratti scoscesa orografia della foresta, in questo tratto caratterizzata principalmente da habitat forestali a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica) e abete bianco (Abies alba). Sul versante toscano si stacca il Sentiero di Scodella, ampia pista che si dirige verso la nota ed omonima Riserva, rasentandone il confine inferiore: rispetto a tali percorsi Pian delle Carbonaie si può ritenere “passo” appenninico di esbosco. Secondo la cartografia escursionistica il sito di PIAN CARBONAIE ricade nel versante settentrionale mentre nella Carta Geometrica della Regia Foresta Pian delle Carbonaje è trascritto sul versante opposto.
Dalla selletta La Giogana risale ripida per circa 750 m fino a circa +70-90 m, così intersecando il primo evidente rilievo di questo tratto dello Spartiacque, ovvero Il Poggione, già Poggio Seghettino (toponimo in uso nel XIX sec.), articolato in almeno tre cime riconoscibili, poste in sequenza sul crinale e distanziate tra esse di circa 500 m, inoltre differenziate per l’altitudine di m 1407, 1432 e 1424. La prima cima che si incontra corrisponde a quella minore ed è nota ai frequentatori grazie alla tabella, benché erroneamente collocata ed utile solo con approssimazione in quanto riporta la quota 1424, mentre la quota corretta di tale sito è 1398 m ed è adiacente alla cima dei 1407 m. Nella Carta d’Italia I.G.M. l’oronimo compare accanto al simbolo del triangolo della quota geometrica e topografica disegnato sulla cima dei 1424 m (qui doveva essere correttamente posto il segnacolo). La cima maggiore dei 1432 m si trova in posizione intermedia tra le altre due. Dalle tre cime del Poggione si diramano altrettante lunghe dorsali: quella che si dirama dalla cima 1432 presto si suddivide nella Costa delle Cullacce e nella Costa Poggio del Ballatoio, dalla cima 1407 si dirama la Costa Poggio Termini, mentre dalla cima 1424 la Costa di Campàmoli si dirama nel versante toscano. Nell’osservazione da remoto dal versante romagnolo della morfologia del Poggione appare evidente solo la cima più elevata, inoltre si nota anche una piccola sella di collegamento (attraversata dal Sentiero delle Cullacce) tra la cima minore ed un evidente poggetto che si protrae verso settentrione, costituendo apparente esordio della Costa Poggio Termini. Le prime due dorsali caratterizzano l’alta Valle di Campigna separando le profonde incisioni dei due rami del Fosso della Ruota e del Fosso delle Cullacce, ma l’anfiteatro orientato a Maestrale determinato dal distacco della Costa di Poggio Termini, costituisce bacino idrografico del Fosso della Corbaia. In particolare, il ramo occidentale del Fosso della Ruota ha origine dalle pieghe tra la cima minore e la maggiore del Poggione, il ramo orientale del fosso ha origine da una piega della cima maggiore, mentre il Fosso delle Cullacce ha origine dalla piega tra la cima maggiore e quella intermedia.
Subito dopo la terza cima di 1424 m del Poggione un tratto di crinale si sviluppa per circa 700 m secondo uno skyline regolare e pressoché orizzontale che si mantiene intorno ai 1415 m di quota, per cui in passato è divenuto noto come Raggio Lungo, o Raggio Seghettino nelle Bozze di mappe catastali (come sopra accennato), benché mostri l’evidente rialzamento di un poggetto da cui si stacca la sella di collegamento con il successivo rialzamento di Poggio Pian Tombesi. Dal verbale di una visita del Cancelliere dell’Opera del 1656: «Una parte delle travi chieste si troverebbe da fare nelle Coste di Campigna fuori della Bandita […] referissero se i legni vi siano il che si tiene di si, se possin cavarsi il che non se ne dubita mentre si voglia far nuova strada e sopratutto se la migliore strada fusse come si crede per il Raggio Lungo alla Calla e di li alla Stradella come già era, e finalmente che spesa sarà il fare tale strada […] sarebbe di grossa spesa perché la detta strada costerebbe più di 150 scudi qualcosa. Spesa che non dimeno non sarebbe stimata grave da chi consideri che fatta che ella sia si potranno per tale strada cavare da quella abetia tutti li altri legni richiesti e poi ogni anno in futuro ogni sorta di legni quadri che occorra.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 285-286, cit.). In un programma di “Appalto di vie” da costruire e mantenere in funzione per il quinquennio 1688-1692 viene elencata questa bordonaia, su cui dovevano convergere tre vie maestre da Ricopri e dintorni: «Fare […] da tutto Ricopri e suoi contorni al Poggio e bordonaia di Raggio Lungo […] tre diverse strade maestre […] che introduchino nella Maestra o bordonaia da farsi in […] Tutto il Poggio di Raggio Lungo sino alla Calla di Giogo.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 366, cit.). Questo tratto di crinale fino a Pian Tombesi divide la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino dalla Riserva Biogenetica Statale della Scodella. Quella di Sasso Fratino è la prima Riserva Naturale Integrale istituita in Italia secondo la classificazione dell’U.I.C.N. (Unione Internazionale Conservazione della Natura). Dal 7 luglio 2017 le faggete vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna comprese nella Riserva di Sasso Fratino e una vasta area circostante comprendente le Riserve Biogenetiche Casentinesi e altre aree all’interno del Parco Nazionale, per un totale di circa 7.724,28 ha, fanno parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, andando a rappresentare uno dei più estesi complessi forestali vetusti d’Europa. Per l’Italia si tratta della prima iscrizione di un patrimonio naturale espressamente per il suo valore ecologico di rilievo globale. Approfondite indagini nell’area, che rappresenta complessivamente il sito di maggiori dimensioni tra quelli designati in Italia ed uno dei più estesi complessi forestali vetusti d’Europa, hanno portato alla scoperta di faggi vecchi di oltre 500 anni, tra i più antichi d’Europa, aspetto che fa entrare Sasso Fratino nella top ten delle foreste decidue più antiche di tutto l’Emisfero Nord. Questi faggi sono quindi coevi di Cristoforo Colombo e Leonardo da Vinci e al limite della longevità per le latifoglie decidue. Oltre al valore naturale, il faggio è una specie dall’alto valore simbolico e culturale, storicamente legata allo sviluppo dei popoli europei (l’etimologia del nome si riferisce ai frutti eduli, dal greco phagein = mangiare). Per quanto piccola (circa 70 ettari) la Scodella, riserva compresa tra un’altitudine di 1175 e 1465 m s.l.m., è interessante dal punto di vista naturalistico in quanto è, insieme alla Riserva Integrale Regionale della Pietra (con la quale confina), una delle aree a minore influenza antropica tra quelle attualmente esistenti sul versante toscano, completamente occupata da vegetazione forestale autoctona (soprattutto nella parte a monte) composta da Faggete eutrofiche pure (è presente l’habitat 9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum tutelato dalla Direttiva UE Habitat), con sporadiche piante di abete bianco e rimboschimenti di conifere eseguiti tra il 1880 e il 1885.
Come il Raggio Lungo, anche Poggio Pian Tombesi presenta un profilo allungato e singolari caratteristiche morfologiche in entrambi i versanti. Panoramicamente suggestivo il versante settentrionale prossimo alla verticale, “graffiato” da una serie di canaloni detti Ripe di Pian Tombesi, dove i ghiacci invernali tendono a ritardare lo scioglimento ed il filtraggio pressoché perenne degli strati rocciosi costituisce importante contributo al costante alimento del reticolo idrografico del Fosso delle Cullacce. Il poggio termina con un costone che si prolunga in direzione NE dividendo i bacini idrografici dei Fossi delle Cullacce e della Porta e le stesse ripe dette La Porta. Un’improvvisa incisione della linea di crinale segnala la presenza, sul versante toscano, del singolare Vallone di Pian Tombesi, geosito classificato di rilevanza locale, delimitato da una parete parallela al crinale, segnata dall’affioramento di tre spessi banconi arenacei separati da livelli marnosi evidenziati da fasce di vegetazione, che si rialza di 15-20 m e ne accentua la profondità. Lungo più di 100 m e largo tra 30 e 50 m con superficie di circa mezzo ettaro e fondo dell’avvallamento intorno ai 1415 m di quota, è probabilmente conseguente a lentissimi e profondi movimenti gravitativi, tipici dei territori carsici, che superiormente hanno causato lo sdoppiamento delle creste e la formazione della depressione chiusa e allungata, cosparsa da grossi e suggestivi blocchi arenacei ricoperti di muschi e licheni. La sottostante Fonte di Zanzara o della Zanzara è probabilmente alimentata dall’assorbimento idrico della depressione. In antico già detto Piano de Tombesi (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 312, cit.), il contrasto orografico del sito pare essersi sedimentato nella formazione del toponimo, costituito appunto dall’opposizione terminologica tra il “piano” del vallone ed i “rialzi” della cresta e dei massi erratici ivi dispersi, come derivazione dai termini latini tumba, ae e tumulus, con il significato di rialzo, tombolo, monticello, sebbene normalmente da riferire a terreni pianeggianti. Ma Tombesi era anche il cognome di tal Gorlino da Ravenna, condottiero vissuto a cavallo tra i secoli XV-XVI.
Poco oltre Pian Tombesi verso Oriente La Giogana lambisce la Riserva Integrale Regionale La Pietra, separata dalla stretta fascia crinalizia di terreno fino a Poggio Porcareccio dalla Riserva di Sasso Fratino. La Riserva La Pietra (anticamente Pian della Pietra), istituita a tutela di un lembo dell’antica Faggeta Granducale, si estende sul versante toscano fino a Poggio Acerone per 274 ettari di faggeta a fustaie transitorie con acero di monte, fustaie adulte di abete bianco, cerro e altre latifoglie nobili ed è visibile marginalmente oltre che dalla Giogana anche percorrendo la pista forestale Aia delle Guardie-Aia di Dorino (percorso Mtb n.8). È classificata Geosito di rilevanza locale per i rilievi a forma di tondeggiante cupola che si alzano dalla copertura forestale, in particolare il rilievo maggiore cui deve la denominazione, che si presenta come una sorta di panettone smembrato in 2 parti, prevalentemente rivestite da bosco tranne le pendici meridionali, dove affiorano le stratificazioni arenacee. Le porzioni rocciose che formano la “Pietra” potrebbero essere state dislocate nella posizione attuale a causa di fenomeni gravitativi del tipo frana di scorrimento e scivolamento in blocco in corrispondenza delle superfici di strato. Un movimento iniziale avrebbe causato lo smembramento di una massa in due blocchi che la successiva erosione avrebbe modellato in modo selettivo determinando l'attuale morfologia. Altri grossi massi sparsi in prossimità potrebbero costituire accumuli legati ad antichi movimenti franosi di crollo databili al periodo precedente alla crescita dell'attuale compagine forestale.
Mentre il crinale si innalza verso i 1500 m, tra Poggio Pian Tombesi e Poggio Scali appena sotto la cresta si rasenta la Pseudo dolina di Poggio Scali, Geosito classificato di rilevanza locale costituito da una caratteristica depressione a forma di imbuto profonda circa 20 m e dimensioni 40x15 m che ricorda una dolina, allungata in direzione perpendicolare a quella del crinale; gli affioramenti rocciosi delle pareti mettono in luce le arenarie della Formazione Marnoso Arenacea e sono attraversati da un fitta maglia di fratture, mentre sulla parete meridionale si apre una cavità naturale con 3 ingressi tra loro comunicanti. La morfologia è analoga a quella del Vallone di Pian Tombesi ed è originata da scivolamenti profondi delle masse rocciose indotte dalla forza di gravità lungo faglie e superfici di strato che, evolvendo molto lentamente, causano, lungo i crinali, l'apertura di avvallamenti e depressioni.
«[…] giunti dopo pochi passi al Canal del Pentolino, un nuovo spettacolo si presenta allo sguardo: un profondo abisso, alla cui estremità rumoreggia un torrente, rupi sospese, precipizi fiancheggiati da folte macchie, e questo selvaggio orrore temperato dalle più pittoresche creazioni della natura! Io credo che nelle nostre montagne non possano desiderarsi luoghi più belli.» (C. Beni, 1881, p. 56, cit.). Nel tratto forse più stretto del crinale (circa m 2,60) e a 1475 m di quota, un varco panoramico si apre sul vuoto di un crepaccio affiancato da un poggio che ne accentua la profondità, laddove l’erosione delle marne e il conseguente crollo dei banchi arenacei crea sul versante settentrionale dello Spartiacque quei canaloni quasi verticali con roccia affiorante in cui percolano i profondi fossi delle Ripe di Scali, tra cui il noto Canale del Pentolino, appartenente alla stretta ramificazione di origine del Fosso di Poggio Scali. Il toponimo Pentolino è dovuto al nome con cui in Romagna si indica il fiore del mirtillo nero, per la caratteristica forma di piccola pentola del fiore maturo mentre in fase di fruttificazione assume un aspetto a calice che bene corrisponde alla morfologia del canalone.
L’improvviso scorcio panoramico precede le pendici occidentali di Poggio Scali dove sorge la Madonna del Fuoco, maestà eretta a protezione dagli incendi, oggetto di particolare venerazione da parte dei pellegrini (recita la lapide: LA MADONNA DEL FUOCO / TORNA OGGI IN QUESTI LUOGHI / DONDE SCESE COL MAESTRO LOMBARDINO / PER BENEDIRE LA MONTAGNA / DEI FORLIVESI CHE IN CITTÀ LA VENERANO / DA CINQUE SECOLI / ED I PASSANTI CHE QUI L’ONORANO / IL CAI DI FORLÌ NEL 50° DI FONDAZIONE /11 SET 1977). La Festa della Madonna del Fuoco, patrona della città, si tiene a Forlì il 4 febbraio. Sulle pendici orientali del poggio, sul filo dei 1500 m di quota, presso un pannello descrittivo delle caratteristiche del sito, si stacca un percorso di antichissima frequentazione, forse anche una tra le vie militari romane, che dal crinale piega a settentrione discendendo lungo la sella di Pian del Pero sul contrafforte secondario e, superato S.Paolo in Alpe (come detto, frequentato almeno già dal 1900-1800 a.C.), si dirige verso Forlì. Vi corrisponde un tratto di sentiero nell’antichità più recente noto come Via del Giogo di Scali, riportato nelle Bozze di mappe catastali come Strada del Poggio Scali e nel Catasto toscano come Via di Scali, specificamente descritto come via che da Poggio Scali scende a Santa Sofia passando per S. Paolo in Alpe nel sopracitato contratto di vendita del 1857 con cui le foreste passarono dall’Opera del Duomo di Firenze alle Reali Possessioni. Tra le vie dei legni è pure confermata all’inizio del XX secolo dal Direttore generale delle Foreste, al Ministero di Agricoltura, A. Sansone, nella relazione sullo stato delle foreste demaniali (cit.) come via del Poggio, che da S. Sofia, per S. Paolo in Alpe e Pian del Pero, sale a Poggio Scali.
Dalla sua ripidezza, quasi una scalata (dai 1104 della sella di Pian del Pero in 1,1 km in linea d’aria si risale di 400 m), è probabilmente derivato il toponimo del rilievo (dal latino scala, -ae), infatti nel 1791 era detto Poggio della scala. Per curiosa omonimia, il commissario granducale Giorgio Scali visitò il sito nel 1630. Il percorso oggi è vietato al transito in quanto interno alla Riserva di Sasso Fratino: «In pratica in un luogo come Sasso Fratino non si può, in nessun modo, entrare autonomamente e la descrizione di un itinerario al suo interno non può entrare in alcuna guida naturalistica o escursionistica.» (N. Agostini, D. Alberti, eds, 2018, p. 53, cit.). Per la descrizione del tratto terminale che risale da Pian del Pero occorre pertanto rileggere la pagina di una vecchia guida: «È l’unico sentiero che permette l’attraversamento dell’Oasi integrale di Sasso Fratino. Molto ripido, a forte dislivello, non è segnalato ed è del tutto sconsigliato d’inverno dato il forte innevamento che lo nasconde completamente. In caso si perda l’orientamento, dato che sia a destra che a sinistra del sentiero vi sono scarpate e rive scoscese, è consigliabile tornare indietro seguendo le proprie tracce sulla neve. Dal rifugio si scende alla sella omonima poi si inizia a salire a ridosso del costone su di un sentierino poco visibile e ricoperto di foglie, per poi deviare decisamente a destra (20 min.) e in corrispondenza di un canaletto di scolo ripiegare a sinistra a riportarsi sul costone precedente che si risale con alcuni ripidi tornanti. Si ripiega ancora a destra per un lungo tratto per poi risalire il pendio, avendo alla propria destra una scoscesa scarpata, con una serie di innumerevoli tornantini (qui compaiono frequenti segni di vernice bianca sbiadita) che riportano il sentiero, con un largo semicerchio, sul costone che unisce Pian del Pero a Poggio Scali (1 ora) da cui si può intravvedere in mezzo ai rami il Lago di Ridracoli. Qui il sentiero si ripiana un attimo per riprendere a salire in diagonale sotto il costone e portarsi rapidamente al crinale (1 ora e 20 min.) sulla strada della Giogana. (Sent. Segnalato, N° 1). Si prende a destra dove in alto e completamente spoglio dagli alberi è posto il cocuzzolo di Poggio Scali (1 ora e 25 min.).» (cfr.: O. Bandini, G. Casadei. G. Merendi, 1986, pp. 129-130, cit.). P. Bronchi nella sua pubblicazione ricorda come soprattutto nel ‘600: «[…] anche gli anfratti selvaggi di Sasso Fratino erano allora frequentati […] infatti la Selva […] era contigua alla strada da Scali per S. Paolo in Alpe e Valbona […] non era divenuta ancora una zona marginale della Foresta, se è vero che si veniva da Lonnano, villaggio vicino a Pratovecchio, oltre che da Ridràcoli per far funzionare una sega ad acqua nella zona di Sasso Fratino.» (1985, p. 77, cit.). Anche nella prima metà del ‘700: «Da Ridràcoli e da Ragginopoli (presso Lierna) o da Lonnano (tramite il Passo del Porcareccio ), si percorreva questa via per raggiungere, su concessione del Provveditore dell’Opera, la sega idraulica dell’Asticciola (adiacente a Poggio Scali), la Fossa dei Preti, la motta di Sasso Fratino.» (M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, p. 121, cit.). Nel 1721 si notava che in due decenni erano stati abbattuti tutti i grandi abeti delle zone assegnate: «[…] è molti anni che vi tagliano e l’hanno scerpa tutta [pur] essendo tutta macchia scomoda per la trattura di travi […] per essere paese impraticabile per vie […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 73-74, cit.).
Nonostante indicazioni contrarie per la delicatezza del sito, attraversato dal confine della Riserva di Sasso Fratino, incisive tracce raccontano di intense frequentazioni che risalgono fino sulla sommità prativa di Poggio Scali, che conserva ancora i resti di una trincea della linea gotica. Di particolare interesse sono comunque le viste panoramiche che offre specie nelle limpide giornate invernali, escludendo la vista dell’Adriatico citata in tutte le guide ma ormai impedita dalla crescita della faggeta (tuttavia, in caso di eccezionali nevicate ed aria limpida, il rialzamento temporaneo di quota ancora la rende ancora possibile, in attesa dell’ulteriore crescita della faggeta). A riguardo sono interessanti alcune citazioni: «Proseguii la camminata sul crinale del monte, o giogo, […] sinché giunsi ad uno dei punti più belli, Poggio della Scala. Da qui la veduta è stupefacente per quanto consente di spaziare; […] Da una parte l’occhio scorre sulle terre della Romagna, il Sasso di Simone e un lungo tratto della costa adriatica; dall’altra spazia […] quasi all’intero territorio della Toscana […]. Dietro questa vista s’estende il mare Tirreno. Il poeta italiano Ariosto fa riferimento proprio a questo luogo: Come Appennin scopre il mar Schiavo e Tosco, / Dal giogo ove a Camaldoli si viene.» (Sir Richard Colt Hoare*, Da Arezzo al Monte Falterona attraverso il Casentino, 1791, in: A. Brilli, 1993, pp. 19-20, cit.); * banchiere inglese appassionato di antichità pubblicò A Classical Tour through Italy and Sicily, Londra, Mawman 1815, contenente il resoconto del soggiorno toscano del 1791. I versi ariosteschi che precedono quelli della citazione sono: “Di monte in monte e d’uno in altro bosco / giunsero ove l’altezza di Pirene / può dimostrar (se non è l’aer fosco) / e Francia e Spagna, e due diverse arene”. A proposito di panorami e di commentatori dell’Ariosto scrive un illustre (tra l’altro) escursionista: «Qualche interprete […] ha indicato nel Falterona la cima dell’Appennino, da cui si scorgerebbero le sponde (arene) opposte del mare Adriatico (detto Schiavo, perché bagna la Schiavonia o Slavonia) e del mare toscano. Ma questa interpretazione è senz’altro sbagliata. Anzitutto perché, a voler essere precisi, il Falterona non si trova nel giogo che porta a Camaldoli. D’altra parte, stando sul Falterona nessuno può vedere i due mari. L’orizzonte a oriente, ad esempio, è chiuso dal Monte Falco e dall’alta catena della Burraia culminante nel Monte Gabrendo. La gente del posto quindi, e tutte le Guide locali hanno pensato di risolvere la questione sostituendo al Falterona proprio Poggio Scali. Sennonché gli escursionisti, arrivati in cima a Poggio Scali magari proprio con l’intento di verificare le notizie diffuse da voci tanto autorevoli, provano tutti una delusione cocente. […] Non è visibile il Tirreno, perché coperto dalla catena delle Alpi Apuane e dalle colline del Chianti; mentre l’Adriatico si nasconde dietro un impedimento nuovo […] che, volendo sarebbe facilissimo eliminare […] una corona di cespugli di lussureggianti faggi […] sfoltire un po’ questi cespugli? […] aggiornare […] le cartine? […] la poesia è cosa troppo seria per pretendere di interpretarla alla lettera.» (F. Pasetto, 2008, p. 205, cit.). Le faggete vetuste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e in particolare la Riserva di Sasso Fratino, come già detto, sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: «Il faggio più vecchio, con un diametro di 90 cm, dovrebbe avere almeno 520-530 anni. È quindi coetaneo di Michelangelo e Leonardo ed è probabilmente nato prima della morte di Lorenzo de’ Medici. Si trova in località Poggio Scali, a 1464 m di quota, sul versante romagnolo, come tutta la Riserva Integrale di Sasso Fratino. Durante i primi secoli di vita il faggio ha subito la competizione, con almeno tre fasi di soppressione e rilascio, fino a circa 250 anni fa, quando è entrato nello strato dominante. Ha mostrato incrementi sostenuti (più di 2 mm all’anno di diametro) fino a circa 60 anni fa, quando l’incremento si fa via via minore. Nell’area circostante sopravvivono tre suoi fratelli di 400-450 anni. Sebbene di aspetto vetusto, il faggio nel complesso sembra godere di ottima salute!» (N. Agostini, D. Alberti, S. Bassi, Foreste Sacre patrimonio dell’umanità. La Riserva Integrale di Sasso Fratino ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dell’Unesco, in: Storie Naturali, n.10, Maggio 2018, p.22, cit.).
Tra la vegetazione del poggio va segnalato in particolare il Botton d'oro (Trollius europaeus L. subsp. Europaeus), ranuncolacea tipica dei prati montani dell’Italia centro-settentrionale ma rarissima nel Parco delle Foreste Casentinesi, con questa unica stazione però in regressione, pertanto monitorata e tutelata ed ormai visibile solo in lontananza in quanto recentemente inserita per qualche decina di metri all’interno del confine della Riserva Integrale: «I prati derivano da vecchi seminativi abbandonati dai coloni, ed erano, in un passato più o meno lontano, sicuramente coperti da bosco. Viceversa le praterie di altitudine, quali la Burraia, Poggio Scali, Prato al Soglio, Casette di Giogo, situate presso il crinale dell’Appennino, possono essere interpretate come formazioni naturali o seminaturali. Queste sono costituite in prevalenza da un tappeto di erba capecchina (Nardus stricta L.) con numerose altre specie erbacee (Poa, Festuca, Orchis, Ranunculus, Lotus, Trifolium, Scilla, Campanula, etc.) che hanno un certo interesse fitogeografico. È compito dell’Amministrazione forestale […] di conservare e migliorare questi ormai sporadici ecosistemi seminaturali, che stanno sempre più rarefacendosi in questa zona del nostro Appennino.» (M. Padula, Problemi di conservazione degli ecosistemi forestali con riferimento all’Appennino tosco-romagnolo, in: Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, Anno XII-Vol.XVIII–1978, e A. Silvestri, 1981, p. 76, cit.).
Superata la quota massima di Poggio Scali il tratto di Spartiacque orientale digrada mediamente in modo leggermente più dolce rispetto a quello occidentale; infatti, la sezione O ha uno sviluppo lineare di 3,9 km a partire dai m 1296,7 del Passo della Calla con una pendenza media del 5,7%, mentre la sezione E ha uno sviluppo di 4,9 km fino ai m 1250 di Prato alla Penna con una pendenza media del 5,5%. Dal Passo del Porcareccio il crinale fino a Cima del Termine costituisce confine della Riserva Naturale Badia Prataglia che si estende per circa 2.420 ettari con due importanti complessi forestali, la Foresta della Lama da un versante e la Foresta di Fiume d’Isola dall’altro versante, dove sono presenti i seguenti habitat tutelati dalla Direttiva UE Habitat: 9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum, che costituiscono l’aspetto preponderante, 9210 Faggete degli appennini con Taxus e Ilex, sul limite ecologico e latitudinale della sua distribuzione sull’Appennino romagnolo, in associazione con le Faggete dell’Appennino con Abies alba ed altre. Il Passo del Porcareccio, stretto tra il poggio omonimo e Poggio Acerone è attraversato da un itinerario assai rilevante per gli spostamenti e i collegamenti commerciali, oltre che per la transumanza e la pastorizia sulla direttrice S.Sofia-Ridràcoli-La Seghettina-Costa Poggio Piano-La Posticcia-Passo del Porcareccio-Stia ben tracciata anche nei tratti montani, salvo il tratto in sx del Fosso della Fonte del Porcareccio rappresentato nelle Bozze di mappe catastali ma di cui rimangono scarse tracce, mentre permangono resti del tratto adiacente alla pista proveniente dal Passo Sodo alle Calle. In particolare, il tratto casentinese nel Catasto toscano viene distinto in un tratto basso, detto Strada dei Legni, e in un tratto alto, detto Strada Romagnola e nelle Bozze di mappe catastali Via del Pian dell’Acerone, lungo la quale, a 750 m dal passo, si trova un cippo elegantemente inciso con l’antico emblema della Comunità Monastica Camaldolese raffigurante due colombe che si abbeverano ad un solo calice, espressione della comunione di vita comunitaria ed eremitica coniugata dalla congregazione camaldolese che, architettonicamente, si realizza nella compresenza nella stessa struttura, sia dell’eremo che del monastero. La Carta Geometrica della Regia Foresta documenta che era posto a segnare il confine tra il territorio granducale e quello del Monastero camaldolese di Pratovecchio. Il cippo segna approssimativamente anche il punto di confine inferiore della Riserva La Pietra. Nella vallecola stretta tra le pendici dei Poggi Porcareccio e Acerone sgorga perennemente la Fonte del Porcareccio, che si ritrova dopo un breve tratto in ripida discesa dal passo omonimo. È alimentata dalle acque meteoriche filtrate dalle permeabili Arenarie del Falterona fino al sottostante strato di Scisti Varicolori che le conduce verso l’esterno. Risistemata a cura dell’A.S.F.D. nel 1975, recentemente la falda sta soffrendo di intasamenti, con tendenza al prosciugamento estivo dovuto anche all’assorbimento della sovrastante ceppaia di Faggio, per cui è stata affiancata una precaria tubazione suppletiva. Nell’area circostante, classificata Geosito di rilevanza locale e costituita da una radura prativa in falso piano, le acque si disperdono formando un esteso impaludamento dovuto alla presenza di argille, con formazione di una torbiera e sviluppo di specie floristiche tipiche degli ambienti umidi. Nell’ambito del Programma LIFE e del progetto WetFlyAmphibia (conservazione di anfibi e farfalle di aree umide e loro habitat nel Parco delle Foreste Casentinesi), presso la fonte è stata realizzata una vasca abbeveratoio per anfibi. Le specie interessate dal progetto sono l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata) e il Tritone crestato (Triturus carnifex). In tale occasione è stata anche risistemata l’area e la fonte stessa è stata nuovamente restaurata.
Il Passo Sodo alle Calle, o Calle al Trebbiolo oggi detto anche La Scossa, con i suoi 1334 m di quota rappresenta la maggiore incisione intermedia dello Spartiacque; infatti, ha da sempre costituito un crocevia per numerosi itinerari che si sono modificati o aggiunti nel tempo, tanto che oggi si possono contare nel numero di otto. Oltre a quello principale della Giogana vi convergeva, forse indirettamente, quella via della Seghettina di cui al sopracitato atto di acquisto leopoldino del 1857 che, evidentemente, riguarda la Strada che dalla Seghettina va a Stia così documentata dal Catasto toscano (nel catasto moderno ancora riportata come Strada vicinale Seghettina-Ridracoli nonostante l’invaso): essa iniziava dal Ponte alla Forca sul Torrente Bidente (prima che venisse sommerso). Presso la Seghettina vi era un bivio che divideva la Strada del Crine del Poggio tracciata sul crinale dalla Strada che dalla Seghettina va a Stia più di fondovalle. La prima strada proseguiva sulla Costa Poggio Piano e convergeva sulla Strada che da Campo Ominacci va a Stia (poi Strada vicinale La Scossa-Campominacci) che attraversava l’anfiteatro di Sasso Fratino a Quota 900 giungendo fino al Passo Sodo alle Calle lambendo la Posticcia già Prato di Matteino (se ne ritrova un lungo tratto tra il guado del Fosso della Fonte del Porcareccio e il passo); la pista moderna che si stacca dal passo ha parzialmente alterato i luoghi correndo di lato o sulla sede viaria preesistente, però una muraglia trasversale ne interrompe bruscamente la massicciata sorreggendone l’affaccio sul confine della Riserva di Sasso Fratino, oltre il quale si nota la prosecuzione dell’antica via, comunque consentendo di datare l’opera all’epoca dell’istituzione della riserva e motivare il blocco di un infausto progetto. La Strada che dalla Seghettina va a Stia discendeva dapprima verso il Fosso degli Altari guadandolo e poi seguiva uno dei suoi rami di origine, il Fosso delle Segarine, fino alla sua area sorgentifera del Bagnatoio da cui convergeva sul passo tramite un’antica strada bordonaia; sicuramente permane anche il tracciato interno alla Riserva. Inoltre, la Pianta Geometrica della Regia Foresta Casentinese informa su un tracciato stradale tra Pian delle Malenotti (presso Acuti) e il vallone del Bagnatoio, ancora oggi percorribile ed evidenziante alcuni resti di massicciata, che pare conforme alla “vecchia strada bordonaia de legni quadri” di cui al documento del 1652 di seguito riportato: «Alla quinta parte [delle selve dell’Opera del Duomo] si passa per il Piano delle Malenotti e questa si nomina col vocabolo degli Aguti e dell’Abetuccia. Ell’è una valletta non molto grande dove son molti faggi mescolati con pochi abeti e questi corti e nodosi: perciò la giudichiamo luogo da non ne fare capitale per legni tondi per la piccolezza del luogo e per la mala qualità degli abeti. Egli è ben vero che quando ve ne fussero ne caverebbero con non molta fatica per essere vicini al Giogo e massime se abbandonando la vecchia strada bordonaia de legni quadri se ne facesse una nuova più alta tirandoli appiè del Porcareccio.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 269, cit.). Dal moderno tornante del sito di Acuti di cui alla citazione iniziava pure una pista di esbosco che raggiungeva la Giogana a circa 250 m dal passo, probabilmente da riconoscersi in quella Strada delle Pulci ricordata da P. Bronchi (1985, p. 131, cit.), poi detta Strada vicinale Stia-La Lama, così soprannominata dagli addetti al traino del legname, vuoi per la noiosità del lungo tragitto in salita (dal detto “fare le pulci”), vuoi per le ricorrenti molestie inflitte da tali parassiti, infestanti un luogo allora pascolivo fino ad obbligare a bruciare capanne e rifugi dei boscaioli. Si tratta di un tracciato ritenuto esistente fin dai tempi dell’Opera che guadagna rapidamente quota ed ancora presenta tratti di muri a retta e resti dell’antico selciato (ormai sempre più compromesso da frane e dissesti), probabilmente da individuare in quella via di cui, nello stesso documento del 1652, si auspica che “se ne facesse una nuova più alta tirandoli appiè del Porcareccio”. Questa strada è ben riconoscibile nelle Bozze di mappe catastali, per cui è possibile farla risalire quantomeno alla prima metà del XIX secolo, se non antecedente come ipotizzato. Peraltro, il suo arrivo in Giogana con il tornante rivolto verso Giogo Seccheta appare il più idoneo per raggiungere la via dei legni che prende origine da quel giogo, tuttavia non sarebbe stato più preso in considerazione da Siemoni; infatti non compare nella Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese e sarebbe stato sostituito da una pista risalente da Pian delle Malenotti (v. poi). Questo tratto stradale pare inoltre corrispondere a parte dell’antica Via Romana, ricordata in due carte del Regesto di Camaldoli, che qui sarebbe giunta come itinerario camaldolese: «L’antichità di questa via è ricordata in due carte del Regesto Camaldolese. Nella prima, del 1027, viene citata discendente dalla giogaia delle Alpi tra la Toscana e la Romagna, passando per la foresta dell’Eremo di Camaldoli […]. Nel secondo documento del 1047, che conferma tutti i beni agli eremiti di Camaldoli da parte del Vescovo Teodaldo, viene citata come via “Romana”. L’atto stabiliva i confini sul crinale di un grosso appezzamento di terra. Questo andava dal fosso chiamato Tellito, cioè quello di Camaldoli, fino alla via citata come “Romana” e il giogo che divideva la Romagna dalla Toscana. […] Di lì passo Papa Pasquale II di ritorno dalla Lombardia. […] Quel passaggio fu ricordato in una testimonianza, molti anni dopo, in un processo tra il Vescovo di Arezzo e quello di Siena celebrato tra il 1177 e il 1180. Nell’occasione fu interrogato il presbitero Homodeus, che […] disse che vide lo stesso Papa Pasquale presso Camaldoli, di ritorno dalla Lombardia […]. Questo documento conferma anche la continuità del percorso della via che […] il Papa aveva scelto, anche per rivedere i suoi luoghi natali di Galeata, ritornando dal nord Italia verso Roma. […] vidi io stesso, sotto il Giogo di Seccheta nel versante romagnolo, tra il crinale e la curva degli Acuti, la via romana che saliva verso lo spartiacque.» (G. Innocenti Ghiaccini, 2018, pp. 29-30, cit.). L’autore afferma che il documento originale personalmente consultato contiene la descrizione del percorso. Le antiche frequentazioni sono comunque testimoniate da reperti. È rimasto famoso il rinvenimento di Siemoni, avvenuto nel 1839 nel piantare un’abetina nei pressi del passo (la citata Posticcia?), di una stipe votiva etrusca del III secolo a.C. oltre a varie armi e monete, tra cui il Quinipondio o Quincussis, ovvero il nominale maggiore della serie fusa ruota/ancora, dal valore di cinque assi, moneta di oltre settecento grammi di cui si conoscono solo tre esemplari: oltre a questo, conservato al Museo Archeologico di Firenze insieme ad un secondo esemplare rinvenuto nel 1838 in Falterona, un terzo esemplare fu trovato nel Settecento a Stroppiello, vicino a Arezzo ed è conservato nel museo cittadino. Oltre a tale viabilità storica sul passo convergono: sul versante toscano, una S.F. La Scossa-Poggio Acerone, interrotta da una grossa frana e forse mai conclusa, che comunque termina come sentiero presso il citato cippo camaldolese ed appare documentata, insieme all’inesauribile fonte detta le Tre Fonti posta presso l’inizio, nella Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1937 (la fonte comparirebbe anche nelle Bozze di mappe catastali); una pista forestale che scende a Poggio Segaticcio tramite Capanna la Maremmana attraversando la valle di Pian del Varco (si riunisce poi alle Via dei Legni proveniente da Giogo Seccheta), ma anche questa è già documentata sia nelle Bozze di mappe catastali sia nella Carta Geometrica della Regia Foresta; infine una pista che si stacca dal sito del rimosso e da tempo precario riparo del passo, raggiunge una zona di reimpianto di conifere poi si fa sentiero innestandosi con difficoltà a monte di Battilocchio sul 76 CAI diretto a Giogo Seccheta, mantenendosi sempre alta nella valle di Pian del Varco.
Al Passo Sodo alle Calle fa seguito l’inarcamento di Giogo Seccheta che si allunga per 7-800 m mentre il crinale si innalza di 50 m, preludendo al definitivo declinare dello Spartiacque verso Prato alla Penna. Da qui fino a Poggio Tre Confini il crinale separa la Riserva Naturale Biogenetica di Badia Prataglia dalla Riserva Naturale Biogenetica di Camaldoli; estesa su circa 1110 ha, ricade interamente nel versante toscano, dove preponderano le Faggete dell’Asperulo-Fagetum (habitat 9130) ed è presente l’habitat 9260 Boschi di Castanea sativa costituito da ex-castagneti sia da frutto sia cedui, solitamente molto vecchi e per lo più in fase di abbandono, con esemplari di grandi dimensioni, elemento di diversificazione ambientale importantissimo, in quanto habitat insostituibile per molte specie animali. A Giogo Seccheta, dove esisteva un “termine” (cippo) comunale tra Poppi, Pratovecchio e Bagno di Romagna, si trovava pure il limite tra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore gestita dall’Opera e i R.R. Padri Eremiti di Camaldoli ed i rapporti tra essi riguardavano spesso sconfinamenti nell’uso dei pascoli e dei boschi posti su confini in quel tempo assai labili e poco conosciuti e sovente le parti dovevano rimettersi all’arbitrio «[…]di persone vecchie et experte dei luoghi[…]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 28, cit.). Le prime dispute riguardanti il confine degli antichi possedimenti camaldolesi, che lungo il crinale si spingevano fino a Calle al Trebbiolo come evidenziato da un documento del 1350 (v. più avanti), risalgono al 1711 ma rimasero in sospeso non avendo il Monastero esercitato atti di possesso, infatti si replicarono nel 1776 ora estendendosi anche alle zone di Giogo Seccheta, Prato Bertone e della Fonte de’ Beventi (oggi Passo dei Fangacci), dove la via dei legni che seguiva d’appresso il crinale e segnava il confine tra le due proprietà spesso si spostava in luoghi più idonei al transito con evidenti conseguenze per entrambe le parti. Risale al XVIII secolo un interessante schizzo planimetrico delle aree controverse conservato nell’Archivio dell’Opera, già pubblicato da Gabbrielli-Settesoldi (p.35, cit.) e recentemente digitalizzato (676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 65-66, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=175979&ua=276 – sull’argomento v. soprattutto M. Ducci, G. Maggi, 2022, cit.). A Giogo Seccheta si innestava uno dei principali tracciati per l’esbosco, caposaldo della generale opera di miglioramento della viabilità avviata da Siemoni a partire dal 1838, ricordata anche da Repetti: «Fra le nuove strade aperte in cotesto Appennino per il traino degli abeti, e che entrano nel territorio di Pratovecchio, due sono le principali, cioè, quella che dall’abetina di Campigna, rimontando la valle del Bidente di Ridraccoli [Corniolo, n.d.r.], passa il giogo dell’Appennino al Sodo de’ Conti, luogo dove entra a confine con questa di Pratovecchio la Comunità di Premilcore, nel di cui territorio d’allora in poi attraversano le vie de’ legni, che una diretta per Gaviserri e l’altra per Casalino finché entrambe si riuniscono al Fiumicello. Un’altra strada nuova parte dalle Lame sul rovescio pure dell’Appennino di Bagno, sale al giogo Secchieto dove fanno capo diverse altre diramazioni provenienti dall’Appennino di Premilcore per scendere nel Casentino lungo la costa dello sprone che divide le acque del torrente Staggia da quelle del Fiumicello, e la Comunità di Stia dal territorio di Pratovecchio. Entrambe le quali strade riunite si dirigono sulla ripa sinistra dell’Arno sotto Pratovecchio, piazzale del porto di Poppiena.» (E. Repetti, 1841, p. 668, cit.). Il tratto iniziale di questa via dei legni correva tra il crinale e Pietra Baroncia, luogo citato nei documenti antichi come corrispondente a Battilocchio (presso l’innesto con la S.P. n.72 di Lonnano e Prato alle Cogne), ed è composto da un’ampia pista forestale spesso affiancata da vari canaloni corrispondenti alle variabili degli antichi tracciati di trascinamento del legname. Per la sua realizzazione Siemoni dovette aprire una disputa con i camaldolesi, che sostenevano attraversasse la proprietà del monastero (come effettivamente si appurò), conclusa successivamente, come risulta dall’atto notarile del 1857 relativo all’acquisto delle foreste dell’Opera da parte di Leopoldo II. Dall’atto si apprende che la disputa si risolse ricorrendo, tra il 1855 e il 1856, all’apposizione di 91 “termini di pietra” numerati sia sulla Giogana tra Poggio Tre Termini (Poggio Tre Confini) e Giogo Seccheta sia sul crinale che dal giogo si distacca. Il posizionamento dei cippi, che non vennero tutti impiantati, fu riportato in una mappa allegata alla Relazione della Confinazione e apposizione di Termini fra R. Foresta di S.ta Maria del Fiore e R.R. Padri Eremiti di Camaldoli (cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, pp. 82-85, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 266-267, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276): «Dopo lunghe dissertazioni si riconobbe che il crinale era il vero confine tra la proprietà granducale e quella camaldolese, ma fu deciso comunque di impiantare i cippi lungo la viabilità, per poter conservare l’antico uso di trascinare lungo questa i carichi di legna provenienti dal territorio granducale anche attraverso il territorio dei monaci.» (M. Ducci, G. Maggi, 2022, p. 22, cit.). I cippi avevano su una faccia l’incisione L.II.1853 e sull’altra l’emblema camaldolese del calice: «I Termini sono di Pietra della specie dell’arenarie alti B. 1,00 in circa sopra terra, larghi B. 0,50 e grossi B. 0,30 in circa, di figura circolare nella estremità superiore. Da una vi sono scolpiti L. II. 1853 indicante Leopoldo Secondo, e dall’altra parte il Calice stemma della Religione Camaldolense. / Sono collocati alla media profondità di B. 1.25mi, secondochè lo permetteva la natura del suolo ed intorno ad essi i soliti Testimoni consistenti in frantumi di terre cotte di stoviglie e colaticci provenienti dalla fornace del cristallo / E sono inoltre numerati per mezzo dello scalpellino incominciando dal N° 1 fino al N° 90.» (Confinazione ed Apposizione di Termini fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la tenuta Forestale di ragione dei RR PP Eremiti di Camaldoli, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, p. 90, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 280-281, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). «Purtroppo, a differenza del crinale dove i cippi si sono mantenuti, anche se in piccola parte (17 dei 60 posti nell’Ottocento), in questo tratto sono tutti scomparsi, o […] forse fu solo progettato il loro inserimento, ma qualcosa può averne impedito il collocamento effettivo.» (M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, pp. 163-164, cit.). A tutt’oggi Giogo Seccheta è caratterizzato da una radura prativa di circa 1 ha, in parte ancora utilizzata come di imposto del legname tagliato nel versante toscano (l’adiacente versante romagnolo è invece tutelato dalla Riserva Badia Prataglia); vi si riconosce altresì l’impronta lasciata dai resti del pietrame di un capanno ad uso dei boscaioli e la traccia dell’antica Giogana come descritto da Beni che devia sulla sua sx dentro la faggeta: «[…] la via all’altezza di Giogo Seccheta, si biforca nuovamente, e passando a sinistra presso una capanna sbocca in un amenissimo prato tutto fiancheggiato da folte macchie, detto Prato al Soglio […] le cui severe e pittoresche bellezze ricordano l’alpestre natura della Svizzera, così vaga nei luoghi ove discende nelle valli, e dove si unisce agli orizzonti delle montagne» (C. Beni, 1881, pp. 56-57, cit.). Tale descrizione differisce dalla pista carrabile oggi utilizzata, probabilmente aperta da Siemoni, di cui rimangono tracce corrispondenti alla rappresentazione della Carta Geometrica della Regia Foresta, quando giungeva da Pian delle Malenotti tramite Prato al Soglio, peraltro già esistente all’epoca del viaggio dell'illuste escursionista, per cui rimangono incertezze circa la sua descrizione. Riguardo l’aspetto lessicale si può precisare che se forse prevale l’utilizzo del toponimo Seccheta, spesso ricorre anche … «GIOGO SECCHIETA […] < sicculetum (sicculus) < siccus + etum […] = luogo di rami secchi o seccia (stoppia).» (A. Polloni, 1966-2004, p- 289, cit.).
Prato al Soglio, una delle rare praterie naturali o seminaturali di altitudine del crinale appenninico insieme a Poggio Scali, la Burraia, Casette di Giogo e i vaccinieti di Poggio Sodo dei Conti, è: «[…] un amenissimo prato tutto fiancheggiato da folte macchie, detto Prato al Soglio […] le cui severe e pittoresche bellezze ricordano l’alpestre natura della Svizzera, così vaga nei luoghi ove discende nelle valli, e dove si unisce agli orizzonti delle montagne» (C. Beni, 1881, p. 57, cit.). Esteso per circa 1,4 ha, è posto ad un dislivello inferiore di 40 m rispetto a Giogo Seccheta e fu altresì oggetto di controversia tra confinanti, come da documenti del 1663 e 1667: «[…] arrivati a Prato al Soglio si vidde senza difficultà che, secondo che dicono tutti, che quanto acqua pende sia dell’Opera io posso dire “de visu” che il detto prato è tutto della Opera perché l’acqu a cala verso le macchie dell’Opera tutta […]» «[…] E passando avanti nell’istesso modo che il nostro confino camminava con la faggeta del nostro Ser.mo Padrone continuava i sopra citati Padri di Camaldoli nel qual luogo avemmo campo di riconoscere un Prato chiamato al Soglio per il quale di tutti i tempi ci sono state dispute a chi veramente esso appartenga perciò per detto dai nostri conduttori essendo da altra parte bene informati che in luogo ancora che l’acqua pende in Romagna là è la nostra tenuta con ciò Camaldoli di questo ne è sempre stato in possesso […]» «[…] si giunse al Prato al Soglio dove fu detto da alcuni conduttori che detto prato è stato accresciuto dai Padri di Camaldoli in pregiudizio dell’Opera il che è cosa di poco momento et anticamente posseduto da loro vi si fece poca riflessione.» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 313, 322, 329, cit.). Presso il bordo prativo del versante romagnolo riconquistato dalla faggeta, corrispondente al confine regionale, si notano i resti di una trincea della linea gotica, mentre 4 cippi superstiti dei 9 impiantati nell’800 (numerati 68-70-72-74, per l’esatto posizionamento cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, cit.), di cui uno ancora in buono stato di conservazione, attestano che anche qui sono prevalse le ragioni dei camaldolesi. Il toponimo Soglio deriva dal latino solium, i, ed è un «Elemento toponomastico comunissimo in terra tosco-romagnola […]. In romg. Soia, è soglio o posta di stalla […]» (A. Polloni, 1966-2004, p. 297, cit.); concorda G. Caselli (cit.) nell’attribuirvi lo stesso significato di posta di stalla o soglio o abbeveratoio, anche naturale, per animali al pascolo.
La quota di Prato al Soglio si mantiene sostanzialmente costante fino al vicino Prato Bertone (già Prato di Bertone e Pog.o del Prato di Bertone nella Carta Geometrica della Regia Foresta) ma è assente l’area prativa, comunque il toponimo riconferma quale fosse l’utilizzo, nel passato, di ampie aree della Giogana. Il sito è noto per la presenza del bivio che velocizza la discesa all’Eremo di Camaldoli (sentiero 68 CAI) utilizzando un tracciato antico, ma se, come sopraddetto, in base alla cartografia dell’epoca pare che almeno fino a metà del XIX secolo la viabilità di crinale qui si interrompesse ed esistesse solo quella di valico di Fonte al Sasso (attuale Gioghetto) e di Prato alla Penna, dove giungeva dall’Eremo la Via della Bertesca (sent. 74 CAI), comunque un via dei legni più o meno prossima al crinale garantiva il transito per l’esbosco. Nella Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1893 compare rappresentata o ormai realizzata la mulattiera che da P.ta di Prato Bertone prosegue sul crinale. Per un lungo tratto fino a discendere verso Gioghetto si trovano superstiti alcuni dei cippi leopoldini (numerati 64-55-51-45, per l’esatto posizionamento cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, cit.), di cui il 51 ben conservato, mentre pare sia scomparso il cippo 46 o 47, che alcuni anni fa giaceva spezzato sulla scarpata sopra strada (non citato da Ducci e Maggi).
Con il successivo valico del Gioghetto, già Fonte al Sasso, si raggiunge la quota più bassa dello Spartiacque fino a Prato alla Penna (di poco superiore solo rispetto al Passo dei Fangacci, m 1234,5 contro m 1229,3). Oggi è il crocevia dove si innestano il sentiero 70 CAI che scende all’Eremo e il tratto di inizio Novecento della Via degli Acuti, cosiddetta in quanto si stacca dal tornante del sito omonimo (è rappresentata per la prima volta nella Carta d’Italia I.G.M. rilevata nel 1937). Questo itinerario di valico, pur essendo ritenuto un importante percorso storico, tuttavia non compare nella citata mappa riproducente i possedimenti dell’Opera al 1637, dove figurano come già specificato le Rivolte, la Via del Rovino, la Via Maestra che vien dall’Eremo diretta alla Croce di Guagno (Passo della Crocina) e il Raggio di S.Paolo cui fa seguito la Via di Giogo di Scali. Forse da qui si staccava la via de’ Mal Passi citata in una relazione del 1652 per scendere alla Lama. La sua prima rappresentazione cartografica per il versante romagnolo risale alle Bozze di mappe catastali datate 1808-1830, che essendo ritenute di probabile impianto napoleonico andrebbero addebitate all’inizio del periodo. Nella loro incerta grafia da lavoro sono comunque molto precise e documentano una tortuosa Strada della Lama, oggi ricordata anche come Via delle Svolte, che dalla Docciolina si inerpica verso il crinale transitando presso La Cava dei Frati. Mappe coeve o di poco successive sono quelle del Catasto toscano, datate 1826 per il versante romagnolo, però imprecise e prive di informazioni utili per la parte prossima al crinale, mentre riguardo il versante toscano sono datate 1824 e vi si trova rappresentata la via che da Fonte al sasso scende all’Eremo, raggiunto sul lato orientale, pertanto coincidente solo nella parte alta con il sentiero 70 CAI. Si trovano invece delle corrispondenze con il ramo levantino della Strada Vicinale di Fonte al Sasso rilevata dal catasto moderno, che infatti si sviluppa a Levante dell’Eremo; l’altro ramo derivato dalla biforcazione della vicinale corrisponde al 70 CAI. Una rappresentazione accurata dell’intero itinerario tra La Lama e l’Eremo, completato dalle vie fino a Camaldoli da un versante e fin quasi a Ridràcoli dall’altro versante, si rinviene nella Carta Geometrica della Regia Foresta, da confrontare per la completezza toponomastica con la Pianta Geometrica della Regia Foresta. Nelle mappe si nota l’antica via risalire da La Docciolina con una fitta sequenza di stretti tornanti che toccavano La Cava dei Frati fino al valico, privo di toponimo, come sopra già specificato, ma qui con la chiarezza grafica della mappa. A Fonte al Sasso, luogo conosciuto anche come il Termine, fu apposto il cippo 36 quale soluzione della controversia sopracitata, e nella relazione riguardante la Confinazione e apposizione di Termini, sul punto si legge: «[…] 36° Termine presso la strada che dal Sacro Eremo, varcata la Giogana si dirige alla Lama ed in Romagna, ove nell’Anno 1718 era già stato collocato un termine di Pietra […]» (Confinazione ed Apposizione di Termini fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la tenuta Forestale di ragione dei RR PP Eremiti di Camaldoli, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, p. 93, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 283-284, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). Le due edizioni di impianto della Carta d’Italia I.G.M. confermano l’assetto infrastrutturale storico descritto per entrambi i versanti, anche se con diversa simbologia e conseguente classificazione dei percorsi. Di interesse è anche il sopracitato schizzo del XVIII secolo che, pur impreciso nella planimetria tanto da non essere del tutto sovrapponibile con la cartografia moderna, si accompagna alla documentazione storica nel fornire informazioni interessanti sulla localizzazione storica dei luoghi topici, ed in particolare di un Gioghetto antico, alternativo rispetto a quello oggi noto, oltre quanto già esposto sulle aree controverse. Nello schizzo si nota che la Via che va al Gioghetto dall’Eremo risale verso NE avvicinandosi alla Via sopra la Giogana presso Prato alla Penna, ivi ricompreso tra le stesse vie. L’unione tra esse avviene invece al Gioghetto e la prosecuzione fino a Beventi è detta Via Bordonaia. Più oltre, sul Giogo, compare la Via del Giogo di Rombiceto. Il disegno grafico trova piena corrispondenza con le descrizioni documentali, tra cui una relazione del 1652: «È la Lama in un piano a cui verso il Giogo sovrasta un altissimo monte che si dice la Penna con una spiaggia che si dice i Beventi luoghi tutti coperti per lo più di faggi […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 269, cit.) e il “Contratto livellario” del 1818 tra l’Opera e il Monastero di Camaldoli con l’illustrazione dei confini e in particolare dal punto ventiseiesimo: «[…] ventiseiesimo, […] Proseguendo sempre verso levante per il crine l’Opera tiene in proprio le acque che scorrono in Romagna […] seguitando per i vocaboli d’alture del Prato di Bertone e sopra l’Eremo, si giunge al luogo detto Fonte al Sasso e percorrendo sempre l’appennino continuano a confinare i Reverendi Monaci di Camaldoli con i vocaboli di alture di Prato agli Aceri, ed altura sopra i Prati alla Penna e della Duchessa fino al Gioghetto, da questo scendendo alla fonte dei Beventi, o fonte del Gioghetto, s’incontra un termine nella strada che conduce in Romagna e seguitando la direzione di questo si sale ad un braccio dell’Appennino ove con altro termine confinano i Comunisti di Serravalle; ventisettesimo, da questo punto ossia termine i Reverendi Monaci di Camaldoli seguitando il crine dei Beventi, di Monte Cucco, dei Segoni, seguitando l’istesso crine fino alle Rivolte […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, pp. 465-466, cit.). Inoltre, al citato atto notarile del 1857 relativo all’acquisto delle foreste dell’Opera da parte di Leopoldo II è allegato il seguente testo di un … «Antico documento dell’anno 1350 comprensivo la descrizione del Sacro Eremo: = incominciando dalla parte di mezzogiorno, luogo detto Montecornio (oggi Montecorniolo … e proseguendo da Montecotozzo dirigitur ad locum dictum Giogacciolo (oggi Gioghetto e poggio tre termini) et de ditto loco ad Iugum Alpium (Giogana) […]» (Della Confinazione ed Apposizione di Termini di pietra fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la Foresta di proprietà Camaldolese in Casentino, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, p.86, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 274-275, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276).
Riguardo la storicità di un itinerario che dalla giogaia a monte dell’Eremo si dirigeva attraverso la valle dell’Archiano fino a Soci e al fondovalle dell’Arno come tratto di un’antica Via Romana non ci sono dubbi. «Un tracciato romano molto razionale è riconoscibile anche nel bacino dell’Archiano, per Partina, Camaldoli e la valle del Bidente, anche perché documenti dei secoli XI e XIV menzionano una “Via Romana” sul crinale a monte di Camaldoli, che sarebbe alquanto difficile da spiegare nel senso di Via Bizantina, o di via che conduce a Roma.» (A. Fatucchi, 1995, p. 27, cit.). Una mappa dei territori camaldolesi allegata ad un documento del 1776, benché nella sua approssimazione, rappresenta efficacemente il tratto di via che passando da Poggio Cotozzo raggiunge il Gioghetto sul Giogo dell’Alpe a Oriente dell’Eremo definendola Via Romana (cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, pp.52-53, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 63-64, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). La mappa riporta i confini camaldolesi del 1444 descritti in una pergamena più antica rilegata con il documento del 1776: «[…] Confini, si tengono e posseggono immediatamente per detto sacr’Eremo e casa di Camaldoli cominciando a Casa la Cerreta, al fossato, che viene dalla fonte di Lombardorio, et per detto fossato sale a detta fonte, sino alla via Romana, salendo per la schiena di monte Cotozzo al Gioghetto, seguendo a man sinistra a gioghi dell’Alpe […] confinazione fatta per li Magnifici Signori officiali di Monte della città di Firenze l’anno 1444.» (M. Ducci, G. Maggi, 2022, p.50, cit.). Peraltro, «Nel documento di donazione dell’Eremo da parte del Vescovo Teodaldo, datato 1027 si parla di una strada che scende dal giogo appenninico nei pressi del monastero, nel 1350 la strada sembra già spostata a lambire il territorio a Est del monastero, come concesso da un decreto di Enrico VI del 1189, che assecondava il desiderio espresso dai monaci di non disturbare i loro insediamenti entro un raggio di un miglio. La strada tracciata nella pianta del 1444 la troviamo ricordata con lo stesso percorso anche in un documento del 1407 degli Annales Camaldulenses.» (M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, p. 149, cit.).
Secondo la tradizione storico-religiosa, la Giogana veniva valicata dalla Via dei fedeli di S. Romualdo tramite il Gioghetto oggi noto, come ribadiscono due autorevoli narratori. P.L. della Bordella: «[…] per salire all’Eremo (Campo Amabile), i pellegrini romagnoli, S. Ambrogio di Milano e Leopoldo II Granduca di Toscana, percorrevano la via dei fedeli di San Romualdo che da Santa Sofia, per Ridracoli, la Seghettina e la Lama, sale al Gioghetto per ridiscendere al sottostante Eremo.» (2004, p. 190, cit.) e F. Pasetto: «[…] ricordiamo, in particolare, il Gioghetto, attraverso il quale il ravennate san Romualdo scese a Campo Amabile […]» (2008, p. 207, cit.). In effetti, tracciati viari storici, prevalentemente di crinale, da S.Sofia raggiungevano la giogaia inoltrandosi nelle valli del Bidente. Dal Ponte di Ridràcoli la strada principale risaliva il fiume della Lama, o fiume Obbediente, come era anticamente classificato il Bidente di Ridràcoli, correndo per lunghi tratti accanto all’alveo fluviale, poi sommersi per il riempimento dell’invaso tra il Ponte a Ripicchione, posto sul sito della diga e il Ponte alla Forca. Dal ponte si risaliva subito alla Seghettina, dove iniziavano gli itinerari di crinale e fondovalle delle varianti della Via della Seghettina, come già descritto. Rimane da definire con completezza un percorso antico nel fondovalle della Lama, area peraltro soggetta ad impaludamenti che nel tempo è stata fortemente modificata a seguito delle trasformazioni necessarie per la modernizzazione delle vie di esbosco del legname, per la parte a monte compiuta in particolare da Siemoni in epoca ottocentesca e, per la parte a valle, con la costruzione della Ferrovia del Cancellino a inizio ‘900, trasformata in carrabile negli Anni ’30. Grazie alla viabilità riportata nella Carta Geometrica della Regia Foresta si può seguire anche il possibile percorso tra la Seghettina e La Lama, con la via che prima scendeva ad attraversare agevolmente a guado il Fosso degli Altari poi ad superare il meno agevole Fosso della Lama su un probabile ponticello ligneo in prossimità dello sbocco del Fosso dei Pianelli, ancora documentato dalla Carta d’Italia I.G.M. del 1894 come pedanca, ancora esistente fin circa agli scorsi Anni ’60 ma poi scomparso. Successivamente il tragitto transitava dalla località Comignolo proseguendo in destra idrografica fino a La Lama, dove giungeva attraversando il Fosso dei Forconali con un ponte in muratura, documentato dalle due edizioni della Carta d’Italia I.G.M. del 1894 e del 1937.
Ricordando che sia il toponimo Giogo sia i diminutivi Gioghetto, Giogarello, Gioghicciolo erano piuttosto diffusi, la documentazione citata lascia aperte le ipotesi per la collocazione di un luogo della tradizione storica camaldolese.
Dal Gioghetto la linea di crinale inizia la lieve risalita verso Prato alla Penna, accompagnata dal complesso forestale della Foresta della Lama della Riserva Naturale Badia Prataglia e dalla Riserva Naturale di Camaldoli, incontrando luoghi dai toponimi desueti come Piano agli Aceri e Poggiofoco o Poggio di Fuoco, dove furono rispettivamente apposti i termini 33 (scomparso) e 31 (superstite), mentre presso la sbarra di Prato alla Penna si può ancora vedere il cippo 26, ancora posizionato «[…] ove termina il Prato alla Penna […]» (Confinazione ed Apposizione di Termini fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la tenuta Forestale di ragione dei RR PP Eremiti di Camaldoli, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, p. 92, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 282-283, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). Prato alla Penna, c.d. già in antico per la prossimità con il Poggio alla Penna, oggi Monte Penna, è una prateria artificiale che costituiva area di “imposto” dove accatastare provvisoriamente il legname tagliato, essendo rare le praterie primarie data la modesta altitudine della montagna, che non impedisce l’estendersi della foresta benché ostacolata dal vento, a parte le praterie naturali o seminaturali e i vaccinieti come sopracitato. Nel prato stagionalmente fiorisce l’Asphodelus macrocarpus, Asfodelo mediterraneo, Porraccio. È la tappa finale della Giogana come percorso escursionistico, oltre che accesso per i mezzi autorizzati alla pista che corre ininterrotta almeno fino al Passo Sodo alle Calle, attrezzata con un piccolo parcheggio e completata con pannelli informativi. Posto sul confine regionale, l'area prativa di fatto costituisce valico per la S.P. n. 69 dell’Eremo che, tramite il Passo dei Fangacci, reca a Badia Prataglia. La strada, realizzata nei primi decenni del XX secolo (appare ultimata nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937), non è mai stata asfaltata nel tratto emiliano-romagnolo al fine di limitarne l’utilizzo in area tutelata.
Da Prato alla Penna si diparte la prosecuzione dello 00 GEA CT, segnalata da una moderna maestà, ma per le modifiche apportate ai luoghi con la costruzione della strada provinciale si trova corrispondenza con la viabilità storica solo a circa 200 m, ad una quota superiore di 30-40 m. In base al settecentesco schizzo planimetrico riguardante le aree controverse (di cui sopra), sul crinale correva la Via sopra la Giogana e ad essa si univa presso il Gioghetto (collocato a circa 700 m da Prato alla Penna e più in alto di circa 100 m) la Via che va al Gioghetto proveniente dall’Eremo ma, di fatto, le due vie correvano piuttosto ravvicinate. Una rappresentazione esatta si ha grazie alla descrizione dei luoghi contenuta nell’’ottocentesca Relazione della Confinazione e apposizione di Termini e mappa allegata redatta su base ormai catastale, grazie alle quali si viene a conoscere la precisa posizione del Gioghetto, segnalato come passo dal 13° Termine e come luogo del crinale dal 6° Termine; inoltre la relazione acclara lo sdoppiamento tra un percorso di crinale (viottolo), forse riservato alle attività di esbosco e la via pubblica. In particolare, il verbale di messa in opera di ogni singolo cippo a partire da Poggio Tre Confini, ivi detto di tre Termini, dopo i primi quattro specifica: «[…] è collocato il / 5° Termine all’incontro d’un viottolo praticato sul crinale. Proseguendo nel medesimo sempre sul crinale luogo detto Gioghetto […] dopo altre B. 50,00 nella quale lunghezza sulla sinistra è praticato il viottolo suddetto […] Seguendo per il viottolo, ed insieme sul crinale dopo B. 55,00 è posto il / 8° Termine […] Proseguendo termina il crinale, ed incomincia una discesa […] 11° Termine alla destra del quale incontra una cava di pietra di recente aperta sulla strada, detta dei Fangacci e della Bertesca. […] E proseguendo nella stessa direzione fino all’incontro della strada che dal sacro Eremo, traversando il crine conduce alla Bertesca per i Fangacci […] 13° Termine […] E qui pure il luogo ha lo stesso vocabolo di Gioghetto. Proseguendo nella medesima direzione per il crinale ove incontrano vestige d’antica strada […] 16° Termine E lasciando a destra il crinale che precipita verso Romagna, abbandonando la direzione della Giogana […] 21° Termine presso la base d’un faggio di antica segnata nel suo fusto, alla cui sinistra ricorre una antica strada che scende a Prato alla Penna […] al principio del prato alla Penna è stato collocato il / 24° Termine […] dopo B. 86,00 […] E dopo altre B. 80,00 ove termina il Prato alla Penna è posto il / 26° Termine. […]» (Confinazione ed Apposizione di Termini fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la tenuta Forestale di ragione dei RR PP Eremiti di Camaldoli, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, pp. 91-92, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 280-281, c. 281-282, c. 282-283, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). Il confronto con la cartografia odierna acclara che il sito del Gioghetto di cui al cippo 13 corrisponde al bivio tra i sentieri 00 GEA e 68, oggi tabellato come Cava dei Frati e quota 1358 m (ma la cava è da collocare circa 90 m più a monte, sulla dx del cippo 11), mentre riguardo alla viabilità se è evidente l’individuazione della strada detta dei Fangacci e della Bertesca proveniente dall’Eremo, pare che essa non coincida con le vestige d’antica strada documentate nel proseguire verso Prato alla Penna sul crinale costituente confine, quindi corrispondenti ad un antico percorso forestale. Da notare inoltre che all’epoca Prato alla Penna risulta estendersi per 166,00 braccia, tra i cippi 24 e 26, ovvero ca. 68 m, corrispondenti alle dimensioni odierne pari ad una superfice calcolabile intorno ai 4200 mq. Dalla posizione dei cippi rilevata nell’opera di Ducci e Maggi tuttavia risulta che l’area prativa originaria è stata pienamente attraversata dalla provinciale, con esecuzione di una scarpata prima inesistente, per cui la superficie erbosa si è oggi ridotta a ca. 3500 mq (calcolati digitalmente sulla vista satellitare).
Salvo un breve tratto iniziale, la sentieristica odierna nella risalita utilizza senza incertezza il tracciato di Via della Bertesca, ma avvicinandosi al rimboschimento del crinale si confondono i canaloni della via e dell’esbosco. Presso il Gioghetto (Cava dei Frati) si nota la divergenza tra i canaloni diretti verso Prato alla Penna, mentre in direzione opposta è evidente il bivio tra la larga pista/mulattiera che valica e scende al Passo dei Fangacci e il sentiero che sale a Poggio Tre Confini mantenendosi sul crinaletto, accompagnato dai cippi superstiti che Ducci e Maggi hanno individuato nei nn. 12-5-4-3.
Poggio Tre Confini oggi è un po’ radura e un po' rada faggeta priva di tracce del passato o manufatti, salvo il segnacolo identificativo e un cumulo di sassi che giace sulla probabile sommità, altrimenti non ben definita. Non esiste più … «Il 1° Termine antico […] già sull’altura del crinale, conosciuta per le denominazioni di Poggio dei tre Termini–Poggio di Palestrina-Gioghetto- etc. statovi apposto nell’anno 1829, quale forse di triplici confini fra le Comunità di Poppi a Tramontana, di Bibbiena a Levante, e di Bagno in romagna a Nor Est.» (Confinazione ed Apposizione di Termini fra la R. Foresta di S.ta Maria del Fiore in Romagna e la tenuta Forestale di ragione dei RR PP Eremiti di Camaldoli, in: M. Ducci, G. Maggi, 2022, pp. 90-91, cit. e 676 Estimi dei vari territori e altre carte relative alla tenuta della Marinese e alla R. Foresta di S. Maria del Fiore, secc.XVIII-XIX, c. 280-281, in: https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/archividigitali/riproduzione/?id=176079&ua=276). Dal poggio non pare agevole scendere alla zona di Fangacci salvo che per attività di esbosco, mentre la pista mostra modesta pendenza e notevoli tratti a canalone che conservano il vecchio selciato bordato dell’ampiezza di ca. 2 m, evidenziante lo stato della strada dei Fangacci e della Bertesca prima dell’allargamento che l’ha resa carrabile.
Oltre Poggio Tre Confini inizia la serie di disallineamenti dello Spartiacque che terminano dopo il complesso di Cima del Termine, già Terminone, per cui solo con il superamento dell’incisione del Passo dei Mandrioli riprende l’orientamento principale NO/SE verso Monte Zuccherodante e Poggio Tre Vescovi. In particolare, il tratto di crinale tra Poggio allo Spillo e Cima del Termine slitta mediamente sul NE evidenziando la piega iniziale e finale e le anse intermedie del Passo della Crocina e del Terminone. Osservando lo sviluppo appenninico complessivo di quest’area si nota che in allineamento allo slittamento Poggio Spillo-Cima Termine si trovano una serie di creste e rilievi, tra cui il Monte Penna, Poggio Cornacchia e altri picchi minori fino al piano inclinato in contropendenza della Posticcia di Matteino, che riconnette tale allineamento con Poggio Porcareccio. A seguito di tale assetto orografico si creano i valloni contrapposti dei Fossi degli Acuti e dei Fangacci che nel convergere verso lo stacco (una profonda sella) tra il Penna e il Cornacchia rinvigoriscono il Fosso della Lama - «[…] origini delle acque […] del Fiume Lama che va in quello di Santa Sofia e prende altre acque sino di là dalla Fonte al Sasso.» (F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino e Monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla parte della Casa-Nuova in Romagna, 1788, BNCF, G.F. 164, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p.50, cit.; N. Graziani, 2001, vol. II, p.875; cit.) - generando peraltro quelle condizioni morfologiche che si riveleranno indispensabili per il transito. I disallineamenti sono forse esito del citato parziale sovrascorrimento dell’unità Cervarola-Falterona e della Falda Toscana sulla Marnoso-Arenacea, comportante l’affioramento della Linea di Monte Falco, tra l’altro tra i Passi del Porcareccio e dei Fangacci. Peraltro, la particolare morfologia del Monte Penna - Geosito di rilevanza locale la cui asimmetria rispecchia l'andamento degli strati, evidenziati nella parete scoscesa per la giacitura a reggipoggio mentre quella retrostante si raccorda alla zona di crinale per la coincidenza del pendio con le superfici di strato - potrebbe essere dovuta a dislocazioni recenti lungo faglie subverticali tali da creare il risalto strutturale rispetto alle aree circostanti. Inoltre, nella valle del Fosso dei Fangacci si nota un Geosito puntuale di rilevanza locale costituito da un affioramento della suddetta Linea di Monte Falco, appartenente alla zona frontale di uno dei sovrascorrimenti principali dell'alto Appennino romagnolo, dove si evidenziano le deformazioni associate al fronte dell'accavallamento, in particolare una piega a ginocchio (anticlinale) con fianco verticalizzato-rovesciato.
La morfologia della sella dei Fangacci, da cui hanno origine le opposte ramificazioni dei Fossi dei Fangacci e di Fiume d’Isola, è determinata dalla continuità del versante di Poggio Tre Confini con le prime pendici di Poggio allo Spillo, modellate dalla piega dello Spartiacque. In questo contesto si inserisce l’incisione della S.P. n.69 dell’Eremo, particolarmente evidente nel tratto tra Prato alla Penna e il Passo dei Fangacci.
Fino al Sei-Settecento l’area della sella era nota con i toponimi Beventi e Fonte dei Beventi, evidentemente guadagnati per la ventosità che vi si incalanava. Nel 1605 Beventi era un “luogo da aggirare e seminare abeti”; nel 1652 un funzionario dell’Opera relaziona di “una spiaggia che si dice i Beventi luoghi tutti coperti per lo più di faggi non d’abeti” posta sopra La Lama verso i crinale; nella citazione soprariportata relativa al contratto del 1818 tra l’Opera e i camaldolesi si accenna al “crine dei Beventi” e alla “Fonte dei Beventi o del Gioghetto”, ma solo nel 1824, nella specifica mappa del Catasto toscano (Sezione A, Foglio 2o) oltre alla Fonte del Gioghetto compare il toponimo Fangacci ed occorre attendere la fine del secolo e l’emissione del Foglio 107 II della Carta d’Italia I.G.M., rilevato nel 1893, per trovare trascritto il toponimo P.so dei Fangacci, quando la nuova Strada ordinaria a fondo artificiale (futura provinciale) ancora non lo raggiungeva, fermandosi all’Eremo. Nel catasto antico la strada che dall’Eremo giungeva al passo è detta Via della bertesca e quella che proseguiva fino al Passo della Crocina (detto Sodo di Rombicetino) è la Via dall’Eremo in Romagna, ma era detta anche strada dei Fangacci e della Bertesca che nelle Bozze di mappe catastali diviene Strada di legni che va alla Bertesca, a segnalarne l’utilizzo promiscuo. In base alle mappe antiche il percorso tendeva ad avvicinarsi al crinale tra Poggio allo Spillo e La Crocina, probabilmente coincidendo con le tracce di cui si nota la presenza. Inoltre, nella Pianta dimostrativa di una porzione della tenuta della Badia a Prataglia di proprietà del Sig. Filippo Biondi di Bibbiena, risalente al 1846 (cfr.: M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, 2024, p. 173, cit. e https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp), anche il tratto che attraversa il Passo dei Fangacci era detto Strada dei Legni forse ricomprendendo la via che ancora vi giunge da Badia Prataglia tramite Vetriceta. In alto si affiancava una Via delle terre rosse diretta verso l’Aia di Guerrino. Al passo giungeva inoltre da Mezzogiorno, versante di Serravalle, la Via dei nespoli (oggi 66 CAI) mentre una via di esbosco segnata nelle mappe di metà e fine ‘800 in sx del Fosso dei Fangacci consentiva di raggiungere La Lama da Badia Prataglia: un primo tratto dal rifugio fin quasi all’attraversamento del fosso è poi divenuto parte del noto Sentiero degli Scalandrini (227 CAI), con la celebre cascata, mentre rimangono consistenti tracce del restante percorso abbandonato che va ad immettersi nella Strada degli Acuti mantenendosi in sx idrografica.
L’area del Passo dei Fangacci oggi si presenta molto ampia anche per l’utilizzo come ”imposto” del legname, consuetudine presumibilmente storica, oltre che attrezzata per la sosta turistica, con la Fonte dei Fangacci risistemata dal CFS. Nel 1950 è stata edificata la capanna sociale Rifugio CAI Onorio Mellini – Fangacci, non custodita, dotata di cucina, servizi igienici, acqua, camino, stufa e gruppo elettrogeno, in grado di ospitare fino a 14 persone. Divenuto Rifugio Fangacci di proprietà dell'Arma dei Carabinieri del reparto di Biodiversità di Pratovecchio, dal 2020 è gestito in esclusiva da Fitness Tuscany come rifugio autogestito con 9 posti letto. Dal passo scende alla Lama il noto Sentiero degli Scalandrini (227 CAI), con la celebre cascata.
Il sentiero 00 GEA, nonché AVP-23, CSAFC-021 e CSVFC-002, oltrepassata l’Aia di Guerrino e il bivio per il Monte Penna prosegue verso il Passo della Crocina sulla traccia del percorso antico variamente detto Via della bertesca, Strada che va alla bertesca, Via dall’Eremo in Romagna, Via dei legni. Il toponimo Aia del Guerrino compare per la prima volta nella Carta d’Italia I.G.M. del 1937, quando già esisteva la S.P. dell’Eremo e probabilmente riguardava uno spiazzo derivato dalle risistemazioni dello svincolo stradale, in origine utilizzato come aia carbonile o per attività forestali; oggi è attrezzata come area sosta dove, fino a pochi anni fa, spiccava la maestosa coppia di un esemplare di Abete bianco accanto ad un Faggio. Uno svincolo moderno conduce alla Fonte di Guido, risistemata nell’ambito del Programma LIFE relativo al progetto WetFlyAmphibia come la Fonte del Porcareccio. Anche la zona del successivo bivio con la pista verso il Monte Penna pare essere stata oggetto di modifiche rispetto al passato in quanto il percorso principale pare aggirasse sulla sx la bancata arenacea che oggi si presenta gradonata mentre il percorso per il monte correva più basso, per poi risalire nella faggeta.
Proseguendo nella risalita si ripercorre prevalentemente il tracciato antico sul versante meridionale di Poggio allo Spillo (ma in base alle mappe tendeva ad avvicinarsi al crinale, probabilmente in coincidenza di evidenti tracce), attraversando il complesso forestale della Foresta di Fiume d’Isola della Riserva Naturale Badia Prataglia; il poggio evidenzia due picchi che a metà ‘800 erano differenziati nel già accennato Poggio delle Ripe Bianche, riguardante quello occidentale oggi anonimo, e in Poggio dello Spillo.
Il Passo della Crocina costituisce il termine sul Giogo del tragitto definibile Giogana, nonché valico utilizzato fin dalle più antiche frequentazioni dell’Appennino. Come accennato, anticamente era detto Croce di Guagno o Guagnio o Crocina di Bagno, toponimo formato come contrazione da “guadagno” (guagno era una voce normale nel Duecento con tale significato), qui nel senso di guadagnare, raggiungere il passo dopo l’impervia salita, benché intrighi l'assonanza guagno/Bagno (di Romagna). Un'altra ipotesi si può formulare basandosi alcuni dei significati attribuiti al similare toponimo del comune pugliese di Guagnano, che ricondurrebbero all’etimologia francese di termini introdotti dagli invasori come gagner, ovvero guadagnare dalla redditività dei terreni, oppure come gagnage, che ha come sinonimo pâturage (pascolo), nel senso di suolo guadagnato per il pascolo (tipico di queste aree montane). Altre assonanze si potrebbero ritrovare in termini come l’italico gualdus, derivante dal latino medievale waldus, a sua volta dal longobardo wald, bosco o selva, o dall’italiano sguancio, guancia, derivante dal latino medievale guanza e dal gotico wango, con eventuale riferimento ad aspetti morfologici. Oltre che nella sopracitata mappa del 1637 il termine si trova in una relazione del 1663: «[…] si venne per la strada del Poggio tra la Bertesca e Valdoria et il Pozzone et arrivati alla Croce di Guagnio e pigliato il Giogo tra il confino de reverendi padri di Camaldoli e l’Opera di Santa Maria del Fiore si seguitò detta giogana […]» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, 1977, p. 315, cit.). In merito alla conoscenza e alla descrizione dei luoghi dell’Appennino tosco-romagnolo ha grande importanza la Raccolta delle principali vedute degli Appennini del Mugello, Casentino e Romagna osservati dai punti più favorevoli sì dalla parte del Mare Mediterraneo, sì dall’opposta dell’Adriatico «[…] relativa alla Romagna granducale e al Casentino prodotta dai “pittori paesaggisti” Antonio Fedi e Francesco Mazzuoli – sotto la direzione del matematico Pietro Ferroni – nel 1788-89, durante i lavori di progettazione della Strada di Romagna da Firenze ai porti dell’Adriatico per l’Appennino tosco romagnolo. […] tipica del vedutismo pittorico di matrice rinascimentale – come dimostrano le numerose, suggestive scene di vita e le gustose figurine antropomorfe […]» (M. Sorelli, L. Rombai, Il territorio. Lineamenti di geografia fisica e umana, in: G.L. Corradi, a cura di, 1992, p. 39, cit.). In particolare, nella Veduta dell’Appennino e Monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla parte della Casa-Nuova in Romagna, del Mazzuoli, compresa in tale raccolta (1788, BNCF, G.F. 164 - Cfr. G.L. Corradi, a cura di, 1992, pp. 50-51, cit. e N. Graziani, 2001; p. 875, cit.), tra le cime e i valichi individuati compare tra l’altro la Cima dell’Alpe detta la Croce o Crocina di Bagno.
In base alla cartografia storica (Catasto toscano, Carta Geometrica della Regia Foresta e Carta d’Italia I.G.M.) almeno fino alla fine del XIX secolo la viabilità di crinale principale si interrompeva tra il Passo della Crocina e il Passo di Massella (benché la mappa del 1637 riportasse il Giogo ininterrottamente dalle Rivolte di Cima del Termine alla Via del Giogo di Scali di Poggio Scali), mentre nel tratto si trova rappresentata solo viabilità di valico classificata come Mulattiera e Sentiero per soli pedoni. Secondo il Catasto toscano al passo giungeva da Badia Prataglia unicamente la Via della fonte del prete (diversa dall’odierno 64 CAI), in ultimo sviluppandosi pressoché complanare sul versante di Poggio Rovino. Consistenti tracce sul crinale tra Poggio allo Spillo e il passo fanno ipotizzare un percorso pre-ottocentesco più alto o un’alternativa per l’esbosco; peraltro, nel Catasto toscano sul sito del Poggio delle Ripe Bianche è scritto il toponimo La Crocina e sul passo il già segnalato toponimo Sodo di Rombicetina («rumicetum = “terra a rovi” (rombici), dal lat. rumex –icis, romice lapazio […]» A. Polloni, 1966-2004, p. 265, cit.), con probabile riferimento al percorso oltre il valico detto Strada che dal Sacro Eremo va a Romiceto. L’identificazione del passo fin dall’antichità con un agiotoponimo, ovvero riflettente il culto cristiano, e la necessità di sacralizzare materialmente il luogo con il suo simbolo (una piccola croce sorretta da un mucchio di sassi è sempre presente, periodicamente sostituita e variamente realizzata), può essere dovuta al fatto che l’itinerario costituiva collegamento tra le due aree eremitiche di Camaldoli e di Pietrapazza/Strabatenza, aspetto consolidato dall’odonomastica (toponomastica stradale) di inizio ‘800 che alla suddetta Via dall’Eremo in Romagna vede far seguito in Romagna la Via Maestra che vien dall’Eremo, la Strada che da Camaldoli va alla Bertesca e la Strada che dall’Eremonuovo va a Pietrapazza.
Sintetizzando, nella Valle del Bidente di Pietrapazza-Strabatenza nel … «1082 […] il priore di Camaldoli Rodolfo riceveva in dono […] un appezzamento di terra boschiva per costruirvi un romitorio. Il luogo, detto Cortina di Metato Vecchio, era situato all’estremo nord-ovest della valle bidentina […]. I Camaldolesi volevano impedire l’espansione dell’abbazia di Prataglia verso la pianura romagnola. L’eremo fu poi spostato nella prima metà del sec. XII alle falde del crinale tosco-romagnolo, e fu detto Eremo Nuovo.» (E. Agnoletti, 1996, pp. 187 e 285, cit.). Più precisamente: «[…] Pasquale II […] aveva 4 fratelli, cioè Vizo, Baldo, Tederico e Marchesello. Questi primi tre nomi ossia Guizo (che vale Vizo) Baldo e Tederico del fu Crescenzio sono ricordati in un atto del marzo 1082, stipulato dal notaro Arnolfo in Galeata, col quale essi vendono un pezzo di terra in Strabatenza, in vocabolo Cortina di Metato Vecchio, territorio della pieve di S. Pietro in Galeata, diocesi di Forlimpopoli, a Rodolfo priore di Camaldoli per costruirvi la chiesa e le celle.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 231, cit.). In seguito, bolle papali del 1105 e del 1113 ed atti notarili documentano l’esistenza di un Eremo di S. Pietro de Faiolo o dell’Alpe di Cortina: «Quivi fu l’Eremo di San Pietro detto dell’Alpe di Cortina od anche Eremo nuovo di Fajolo o della Faggiola, le cui estese possessioni alpestri arrivavano fino alla sommità della Falterona e facevano parte della Faggiuola di Strabatenza e sulle quali, come sull’Eremo, godeva il giuspatronato l’Abbazia di Galeata.» (E. Rosetti, 1894, rist. anast. 1995, p. 229 cit.). Questi documenti ed altri accertano la compresenza di due eremi camaldolesi, il romitorio documentato dal 1082 e l’Eremo Nuovo di Pietrapazza, riguardo il quale il seguente documento del XIII secolo non lascia dubbi: «[…] D. Angelo, priore dell’Eremo Nuovo, […] con atto rogato nel chiostro di detto eremo dal notaro Chiaramonte da Monteguido, l’8 settembre 1251, dà in enfiteusi alcuni pezzi di terra a Benincasa di Marzo di Riosalso […]. Questo rogito fu stipulato nel chiostro del monastero dell’Eremo Nuovo di Pietrapazza.» (D. Mambrini, 1935 – XIII, p. 288, cit.)
Per approfondimenti fotografici si rimanda alle schede toponomastiche relative ad acque, rilievi e insediamenti citati.
AA. VV., Dentro il territorio. Atlante delle vallate forlivesi, Forlì, 1989;
AA. VV., Il Casentino, Firenze – Ponte a Poppi 1995;
AA. VV., Il luogo e la continuità. I percorsi, i nuclei, le case sparse nella Vallata del Bidente, Catalogo della mostra, Forlì 1984;
AA.VV., Indagine sulle caratteristiche ambientali suscettibili di valorizzazione turistico-culturale delle vallate forlivesi. Repertorio, Forlì 1982;
AA. VV., La lettura del territorio. Storia, percorsi e insediamenti delle vallate forlivesi, Forlì 1986;
AA.VV. Le faggete vetuste del Parco Nazionale, “Crinali” – Anno XXIV n.46 – Agosto 2017, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Santa Sofia 2017;
AA.VV., Paesaggi d’Appennino, Cesena 2008;
E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Rufina 1996;
N. Agostini, D. Alberti (eds), Le Foreste Vetuste, Patrimonio dell’Umanità nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Pratovecchio-Stia 2018;
A. Anceschi, Geografia degli antichi Stati emiliani, I confini dell’Emilia-Romagna e dell’alta Toscana, Sassuolo 2018;
S. Bassi, N. Agostini, A Piedi nel Parco, Escursioni nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Forlì 2010;
I. Becattini, Dalla Selva alla Cupola. Il trasporto del legname dell’Opera di S. Maria del Fiore e il suo impiego nel cantiere brunelleschiano, Berlino-Firenze 2015. In
C. Beni, GUIDA ILLUSTRATA DEL CASENTINO, Tipografia Niccolai, Firenze 1881 (1^ Ediz.), rist. anast. Brami Edizioni, Bibbiena 1998;
C. Beni, GUIDA ILLUSTRATA DEL CASENTINO, Luigi Niccolai, Firenze 1889 (2^ Ediz.);
C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi (a cura di), AL TEMPE DEL COROJJE - Poderi e case rurali nel territorio parrocchiale di Bagno di Romagna - Immagini e storie di altri tempi, Bologna 2010;
A. Bottacci, P. Ciampelli (a cura di), La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, RCCB Pratovecchio, Pratovecchio-Stia 2018;
A. Brilli (a cura di), Viaggio in Casentino. Una valle nello specchio della cultura europea e americana 1791-1912, Città di Castello 1993;
P. Bronchi, Alberi, boschi e foreste nella Provincia di Forlì e note di politica forestale e montana, Forlì 1985.
G. Caselli, Il Casentino da Ama a Zenna, Accademia dell’Iris - Barbès Editore, Firenze 2009;
F. Clauser, Romanzo Forestale – Boschi, foreste e forestali del mio tempo, Firenze 2016;
G. Chiari, La Foresta Casentinese nel periodo di proprietà privata dal 1900 al 1914 - con un breve cenno alle ferrovie forestali, MPAAF-CFS Ufficio Biodiversità, Pratovecchio 2014;
G. Chiari, La Lama. Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Stia 2010;
G.L. Corradi (a cura di), Il Parco del Crinale tra Romagna e Toscana, Firenze 1992;
G.L. Corradi e N. Graziani (a cura di), Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana, Firenze 1997;
P.L. della Bordella, Pane asciutto e polenta rossa, Stia 2004;
M. Ducci, Sulle tracce di cacciatori preistorici nel Parco, Crinali – Anno XXVI n°49 – Agosto 2020;
M. Ducci, G. Maggi, Termini di pietra, appunti per la ricerca dei confini del territorio granducale e del monastero di Camaldoli nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Stia 2022;
M. Ducci, G. Maggi, B. Roba, “Le vive travi” e i loro cammini nel Parco e nella storia, Cesena 2024;
L. Fabbroni, SULLA STRUTTURA GEOLOGICA DELLA ROMAGNA TOSCANA, Firenze 1854, rist. anast. Milano 1978;
U. Foscolo, Dei Sepolcri, 1807;
A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV° al XIX°, Roma 1977;
N. Graziani (a cura di), Romagna toscana, Storia e civiltà di una terra di confine, Firenze 2001;
G. Innocenti Ghiaccini, Le Vie Romee nella storia del Casentino. Gli spedali e le chiese per i pellegrini, Bibbiena 2018;
D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna 1935 – XIII;
M. Massaini, Alto Casentino, Papiano e Urbech, la Storia, i Fatti, la Gente, Pratovecchio-Stia 2015;
G. Mini, LA ROMAGNA TOSCANA, Castrocaro 1901, rist. anast. Milano 1978;
F. Pasetto, Itinerari Casentinesi in altura, Stia 2008;
F. Pesendorfer, Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859), Firenze 1987.
Plinio il Vecchio, Naturalis historia, III, 77-78 d.C.;
Polibio di Megalopoli, Historiae, II, II sec. a.C.;
A. Polloni, Toponomastica Romagnola, Firenze 1966, rist. 2004;
E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Volume IV, Firenze 1841;
E. Rosetti, La Romagna. Geografia e Storia, Milano 1894, rist. anast. Castel Bolognese, 1995;
A. Sansone, Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato – 1° luglio 1910/30 luglio 1914, Roma 1915;
A. Silvestri, Romagna da salvare, Forlì 1981;
F. Trenti, a cura di, Alto Medioevo Appenninico - Testimonianze altomedievali fra Casentino e Val Bidente, Catalogo della mostra presso il Museo Archeologico del Casentino 'Piero Albertoni', Bibbiena, 2015;
P. Zangheri, La Provincia di Forlì nei suoi aspetti naturali, Forlì 1961, rist. anast. Castrocaro Terme 1989;
Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali, Anno XII-Vol.XVIII, Sassari 1978;
Giornale di Bordo di storia letteratura e arte, Serie III, n. 36/37, 2014
Monti e boschi, rivista mensile del Touring Club Italiano, n.6, giugno, Milano 1962;
Storie Naturali, n.10, maggio, Bologna 2018;
Carta Escursionistica scala 1:25.000, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Firenze 2020;
Parco nazionale delle foreste casentinesi. Carta dei sentieri 1:25.000, N.20, Cesena 2019;
Itinerari Geologico-Ambientali nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Regione Emilia-Romagna, Parco delle Foreste Casentinesi, Firenze s.d.;
Link: https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp?fondoid=37_45 (controllato a giugno 2025);
Link: http://duomo.mpiwgberlin.mpg.de/STUDIES/study003/Becattini-Dalla-Selva-alla-Cupola.pdf (controllato a giugno 2025);
Link: https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/ (controllato a giugno 2025);
Link: https://www.google.it/books/edition/_/kGw5AAAAcAAJ?hl=it&gbpv=1 (controllato a maggio 2025);
Link: https://www.id3king.it/index2.htm;
Link: www.mokagis.it/html/applicazioni_mappe.asp. (controllato a giugno 2025);
Link: https://www.treccani.it/enciclopedia/giogo_(Enciclopedia-Dantesca)/ (controllato a maggio 2025);
Link: https://www.treccani.it/vocabolario/giogo/ - (controllato a maggio 2025).
Testo di Bruno Roba - La Giogana è facilmente raggiungibile dal Passo della Calla lato Romagna tramite la S.P.n.4 del Bidente e lato Toscana tramite la S.P.n.310 del Bidente, inoltre tramite la S.P.n.69 dell’Eremo con area di sosta a Prato alla Penna tranne in inverno per chiusura al traffico. La sentieristica CAI consente il raggiungimento attraverso svariati itinerari di accesso.
Le seguenti foto sono state scattate da Bruno Roba, che ha anche inserito i testi, qui riprodotte su autorizzazione dell’autore.
00a1 – 00a2 – 00a3 – Il sistema orografico appenninico è sinteticamente e ottimamente rappresentato nelle mappe della granducali del XIX secolo; di seguito, particolari in corrispondenza della parte tosco-romagnola dalla nitidissima Pianta geometrica della Toscana accresciuta d'indicazioni con imperiale e reale privilegio di Angeli, dalla capostipite e primeggiante Carta geometrica della Toscana di Inghirami e dalla Carta Geometrica della Toscana di Segato (conservate presso il Nàrodni Archiv Praha -Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, nn. 368 e 419a, Autorizz. NACRX0063I4I Prot.NA-3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabili sui portali CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp e https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html - Licenza CC BY 4.0).
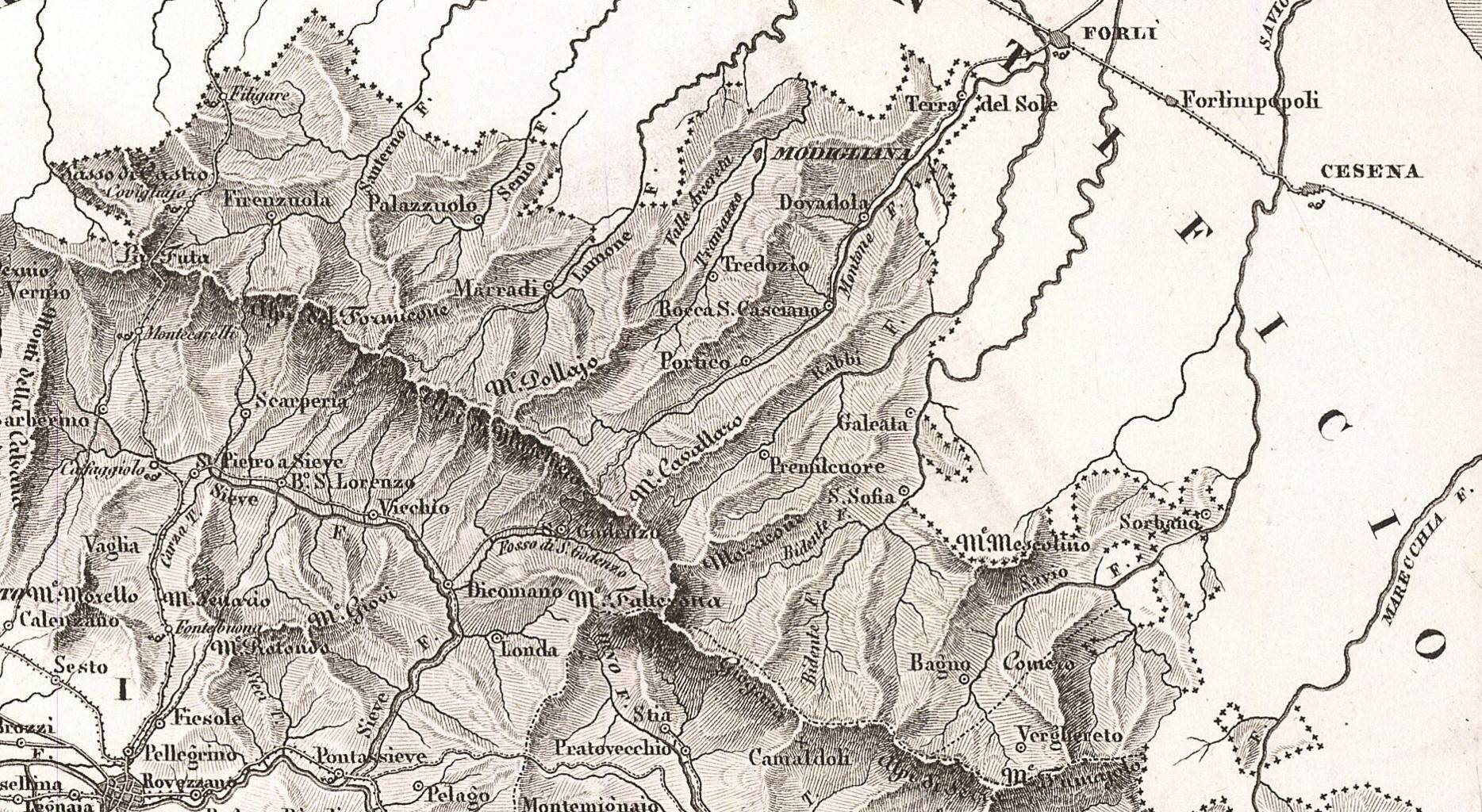
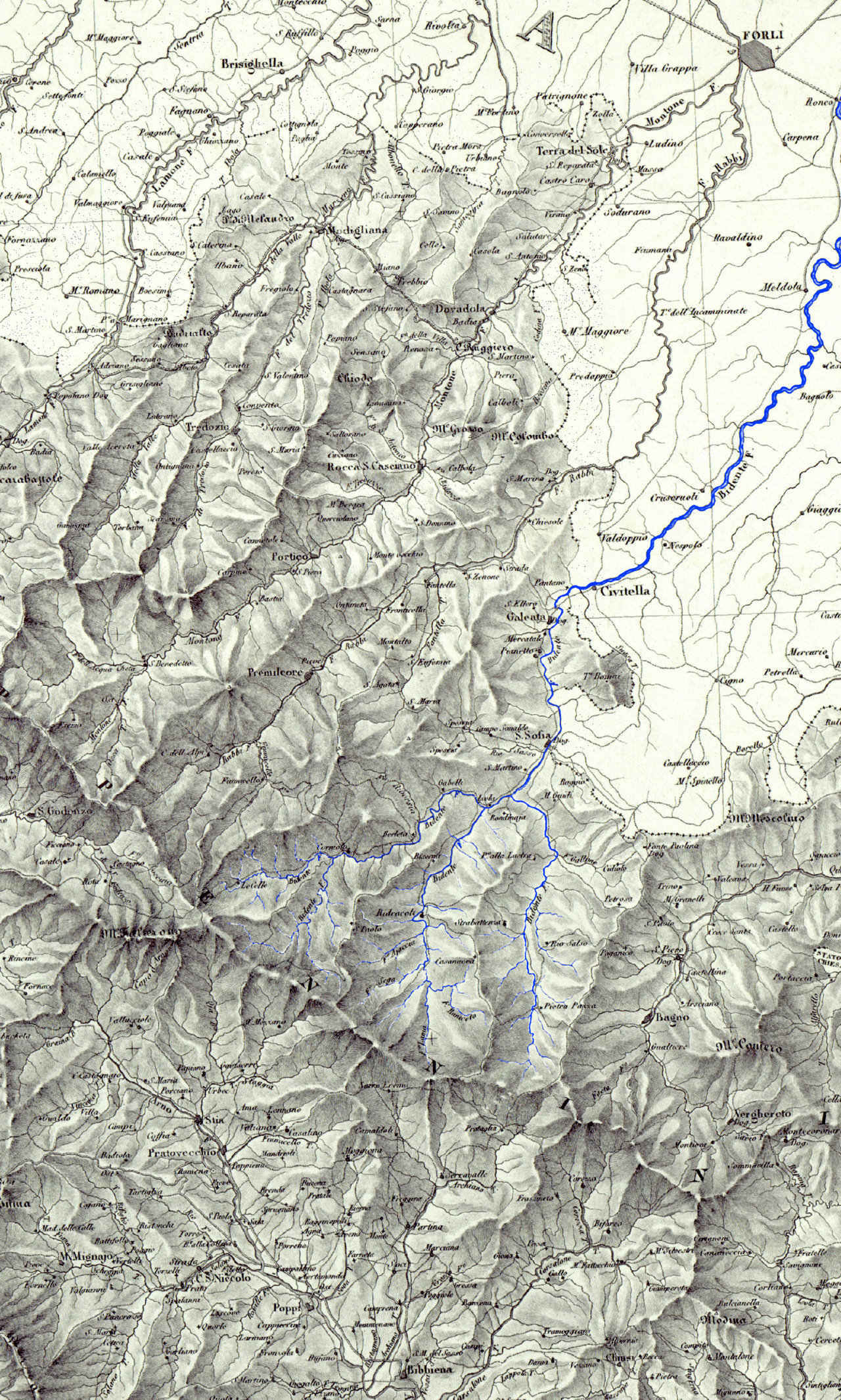
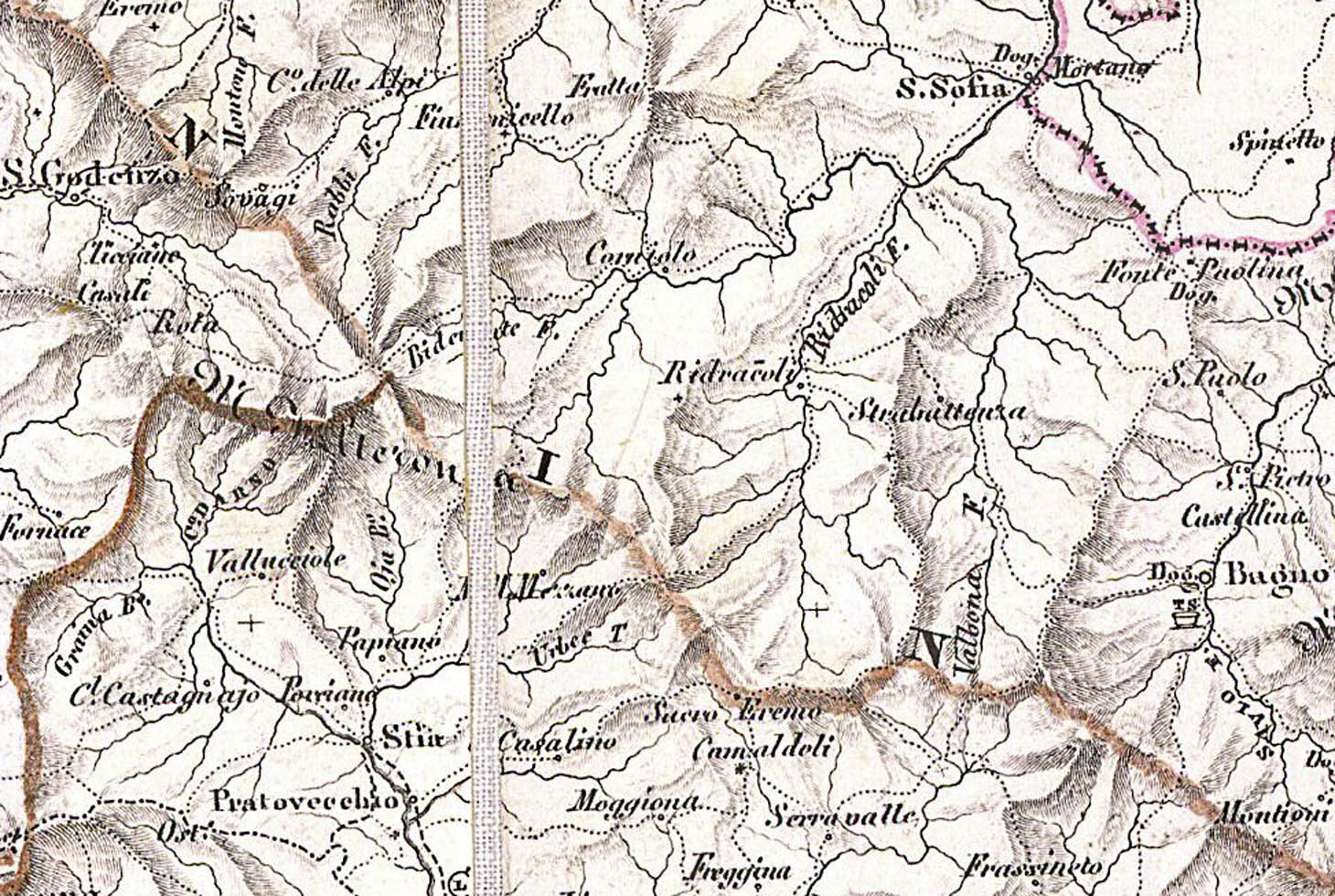
00b1 – 00b2 – Schema cartografico del sistema orografico della Provincia di Forlì-Cesena secondo la descrizione di Zangheri e rappresentazione schematica della parte di sistema relativo alle valli del Bidente, dove sono evidenziate le linee dei contrafforti ed i principali rilievi.
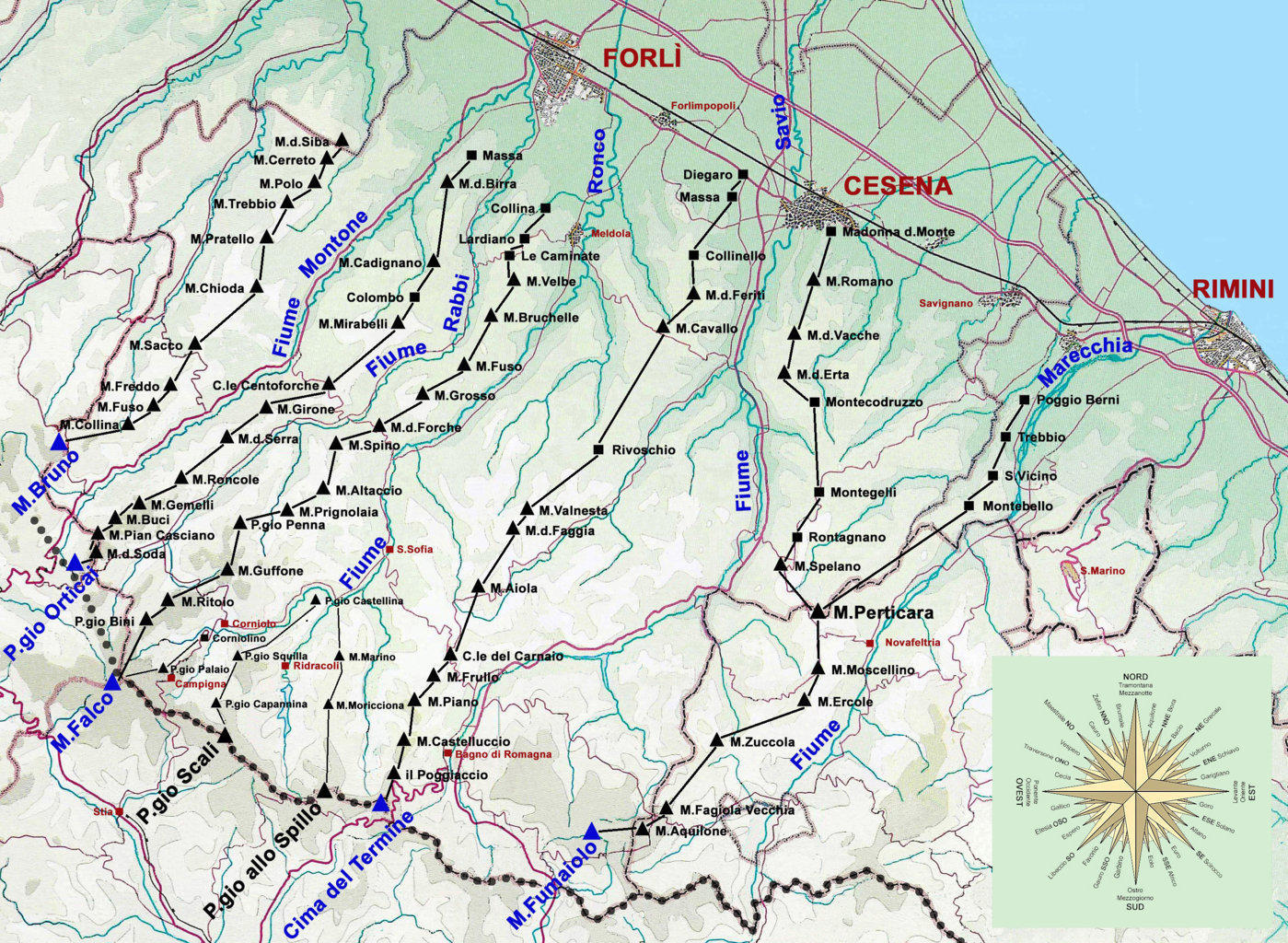

00b2 - Schema delle principali Riserve Naturali attraversate dalla Giogana.
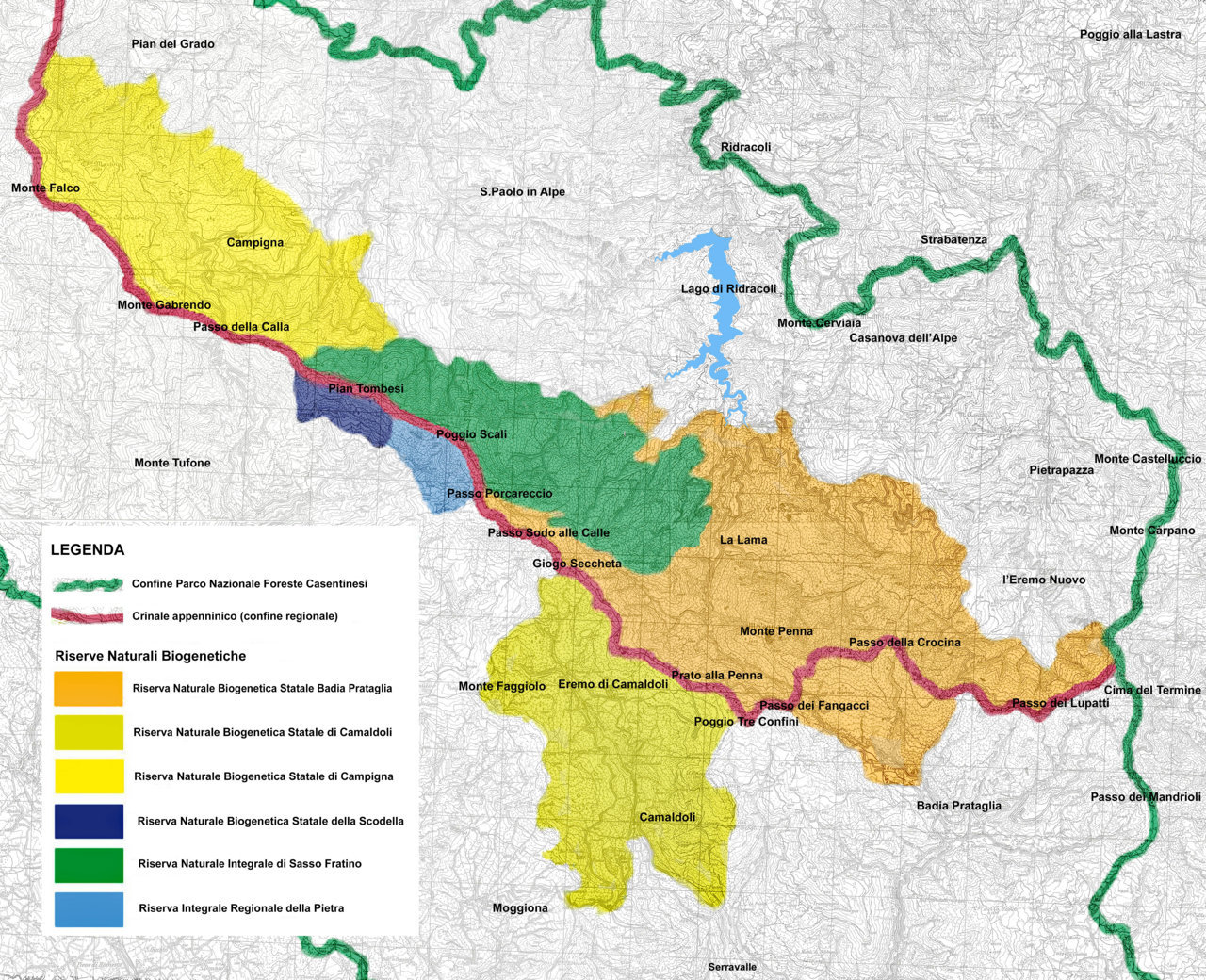
00c1 – Particolare di una delle più antiche rappresentazioni cartografiche dell’Appennino tosco-romagnolo da una mappa francese del 1648 riguardante l’intero Estats del l’Eglise et de Toscane (pubblicata in A. Anceschi, 2018, p. 28, cit.), quindi poco particolareggiata, eseguita secondo lo stile pittorico misto planimetrico-prospettico con le zone montane disegnate secondo l’approssimativo metodo dei “mucchi di talpa”; vi compare la scritta Monte da cui nasce il fiume Bedese che scorre rasentando Soffia (S.Sofia).
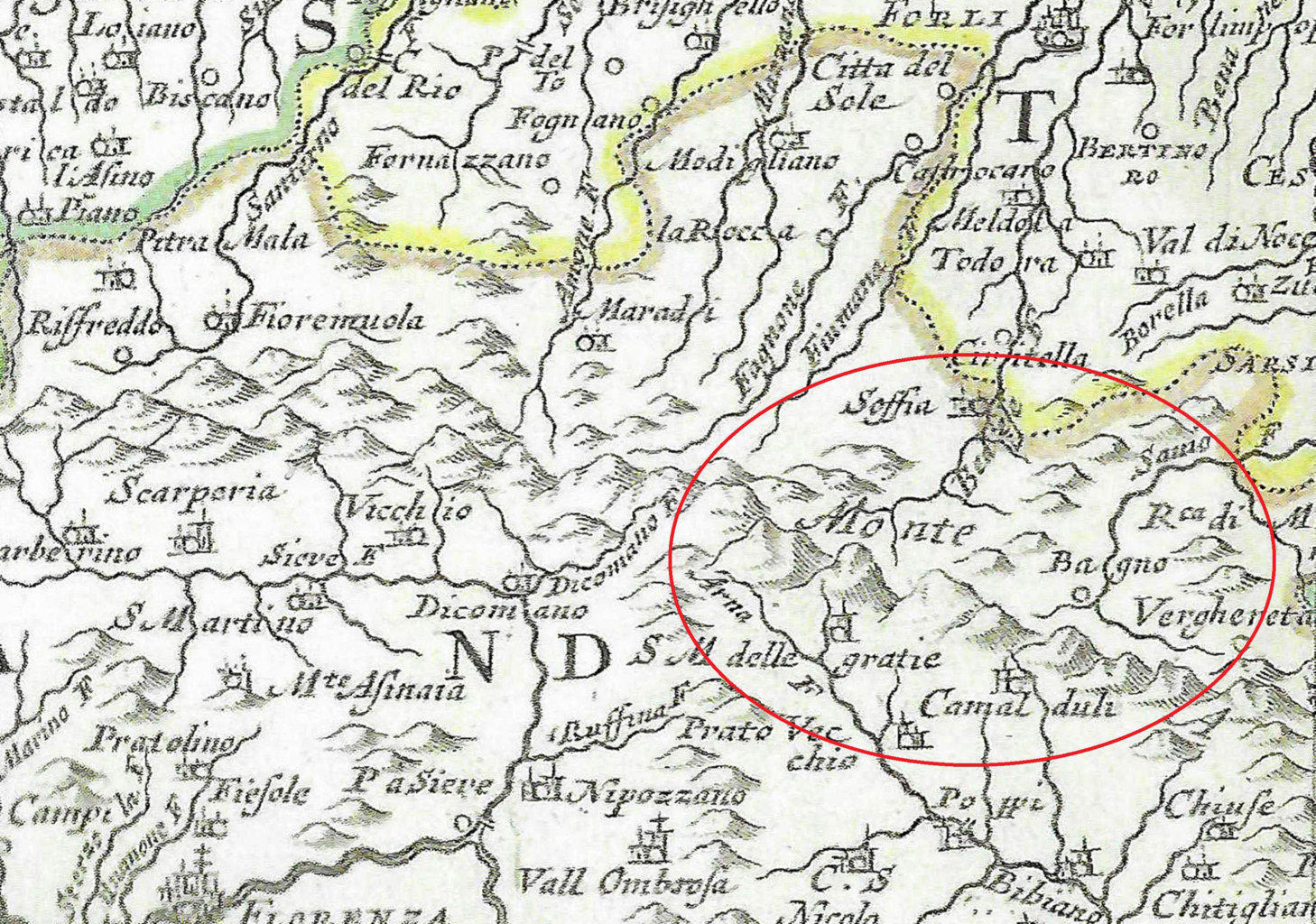
00c2 – 00c3 - Mappa riproducente i possedimenti dell’Opera al 1637 ed allegata con modifiche ad una relazione del 1710 del provveditore Gio. Batta Nelli, custodita nell’Archivio dell’Opera dove, nella sua approssimazione, forse per la prima volta compare una rappresentazione della corrispondente porzione dell’Appennino, con la viabilità di valico e la toponomastica allora in uso (Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, autorizzazione del 10/07/2025. V. anche A. Gabbrielli, E. Settesoldi, p. 20, cit. e A. Bottacci, P. Ciampelli, p. 35, cit.) e ridisegno interpretativo della toponomastica.

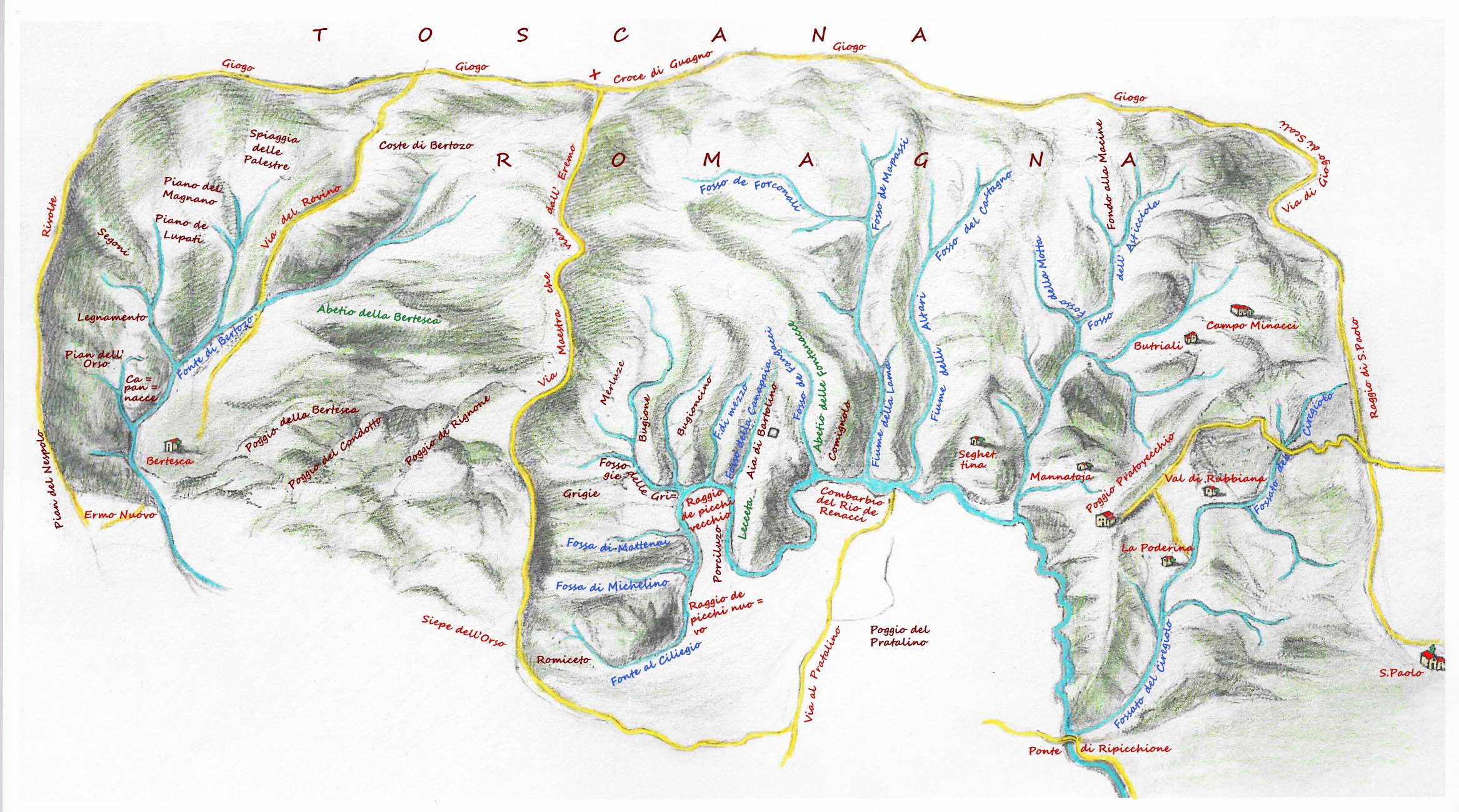
00c4 – 00c5 – Particolari da due mappe granducali settecentesche (conservate presso il Nàrodni Archiv Praha - Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, nn. 241 e 150, Autorizz. NACRX0063I4I Prot. NA- 3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp - Licenza CC BY 4.0) che inquadrano con vario schematismo la catena appenninica; la Descrizione delle provincie del Casentino e del Mugello, della Romagna, del granducato di Toscana, etc., carta ufficiale con stemma lorenese del 1776, è forse una delle rare mappe dove, con grossolana ed approssimativa rappresentazione dello spartiacque e modesta resa dello sfumo orografico, compaiono i toponimi La Giogana, La Falterona e Alpi di Serra; nella mappa del 1780 Il Granducato di Toscana diviso in tre provincie, l’orografia a sfumo di ottima resa del tratto appenninico segnala il Falterona e le Alpi di Serra.
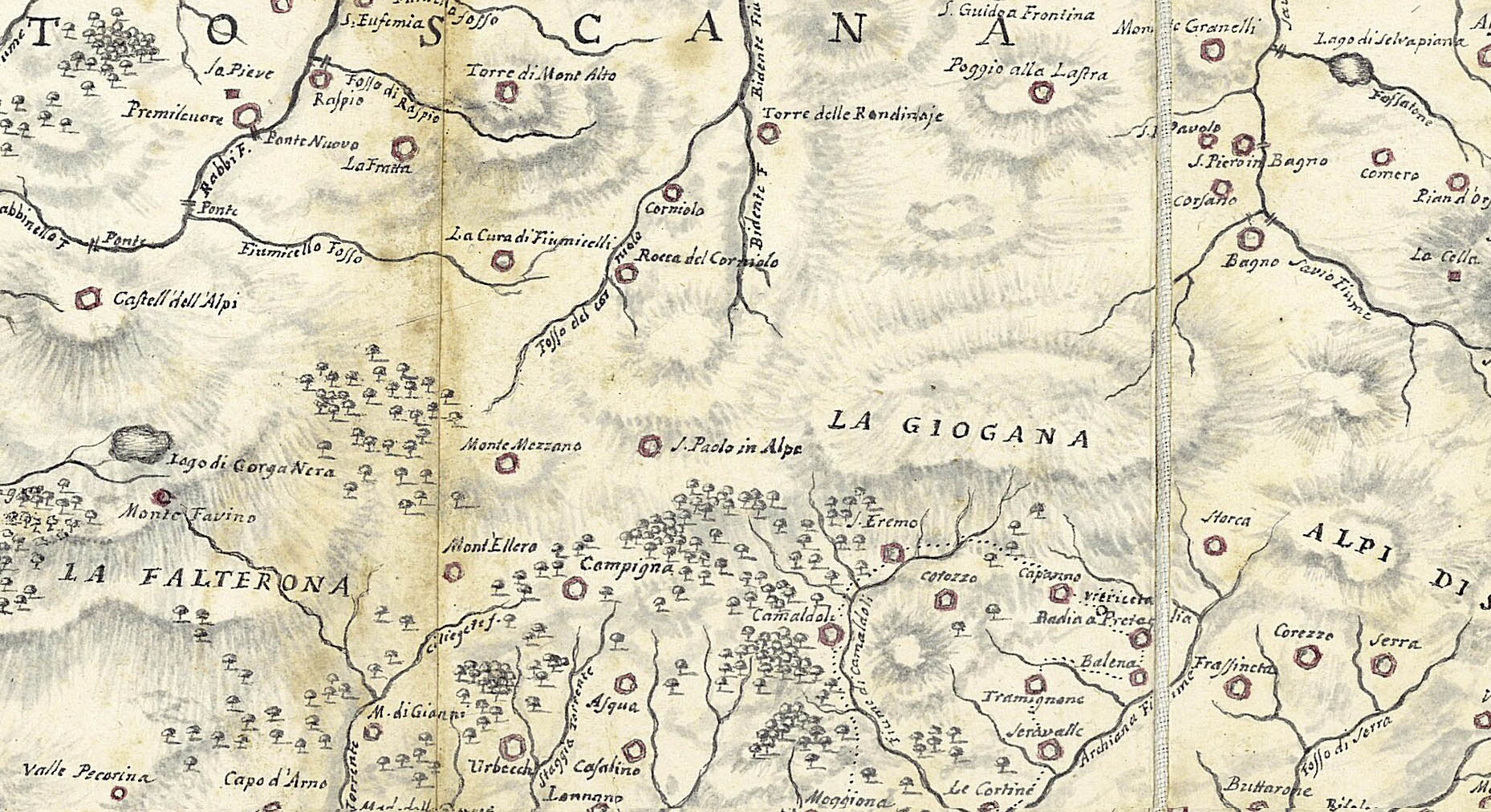

00d1 – 00d2 – Particolari da due mappe sette-ottocentesche. La Carta del Casentino del 1803 dall’impostazione planimetrica moderna, con l'orografia a sfumo resa in modo plastico, apre la strada ai successivi sviluppi topografici; è però errata nell’orografia appenninica con la toponomastica approssimativa Alpe della Falterona, Appennino della Penna e Alpe di Bagno. Nella mappa del Vicariato di Bagno di Romagna 1770-1783, una buffa orografia a tratteggio e sfumo è accompagnata dalla scrittura Sommità dei Monti Appennini che dividono la Romagna dal Casentino e dai toponimi Poggio Bettone (forse Prato Bertone), Poggio di Beventi (forse Monte Penna) e Somità dell’Alpe di Bagno (forse Cima del Termine). Sono anch’esse conservate presso il Nàrodni Archiv Praha - Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, nn. 227 e 166-3, Autorizz. NACRX0063I4I Prot. NA- 3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp - Licenza CC BY 4.0.
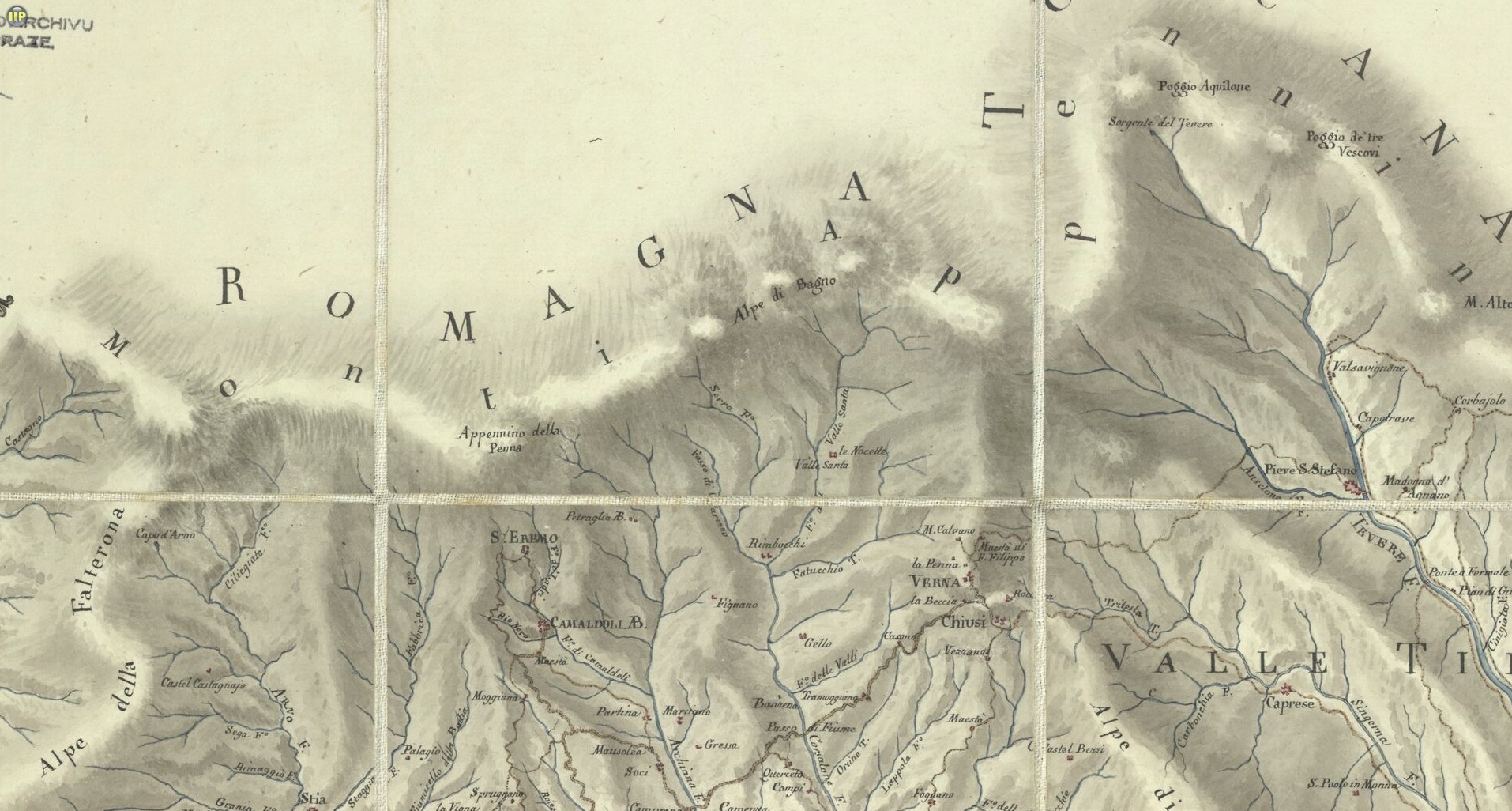
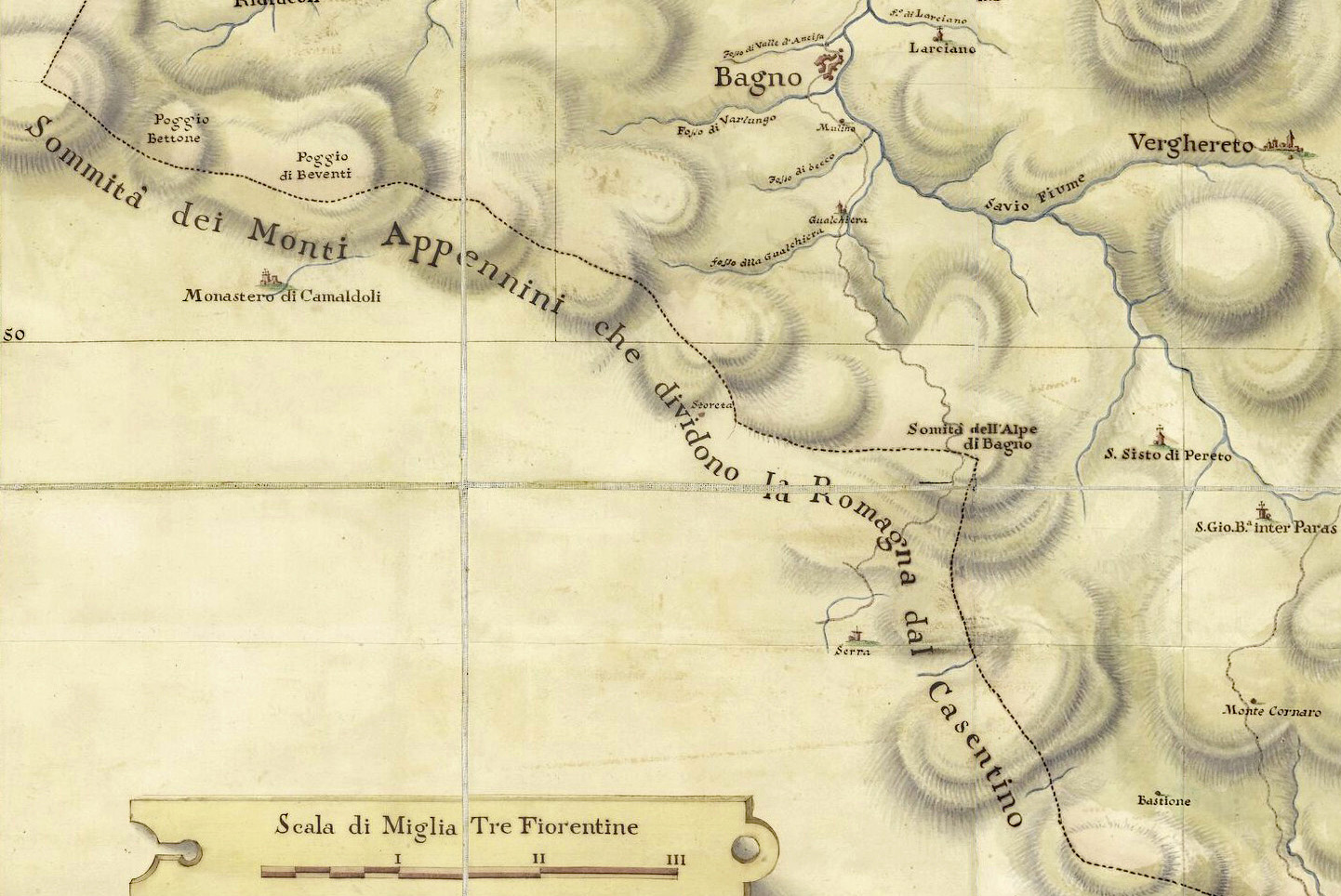
00d3 - 00d4 – 00d5 – Altri particolari da mappe sette-ottocentesche. La Carta geografica della Provincia del Casentino, 1760-1780, piuttosto precisa e particolareggiata con orografia planimetrica a tratteggio e sfumo e confine appenninico dettagliato con gli oronimi Alpi della Falterona, Alpi dell’Opera e Alpi di Camaldoli (a ciascuno il suo), nonché Calla di Campigna, Sodo delle Calle, Prato alla Penna, Crocina di Bagno e Le Rivolte di Bagno. La Pianta di una parte della Romagna granducale e della provincia del Casentino, del 1796, cartografia amministrativa con disegno misto planimetrico/prospettico, rilievi a “mucchio di talpa” e trascritti la Colla di Campigna e Sodo delle Calle, attribuiti alla Cancelleria e Comunità di Pratovecchio e S. Agos.no in Alpi attribuito alla Cancelleria di Rocca S. Cassiano e alla Comunità di Premilcuore. La Pianta della diocesi del Borgo S. Sepolcro, del 1794, e essenzialmente amministrativa con i “mucchi di talpa” anonimi. Sono anch’esse conservate presso il Nàrodni Archiv Praha - Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, nn. 228, 205 e 142, Autorizz. NACRX0063I4I Prot. NA- 3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp - Licenza CC BY 4.0.
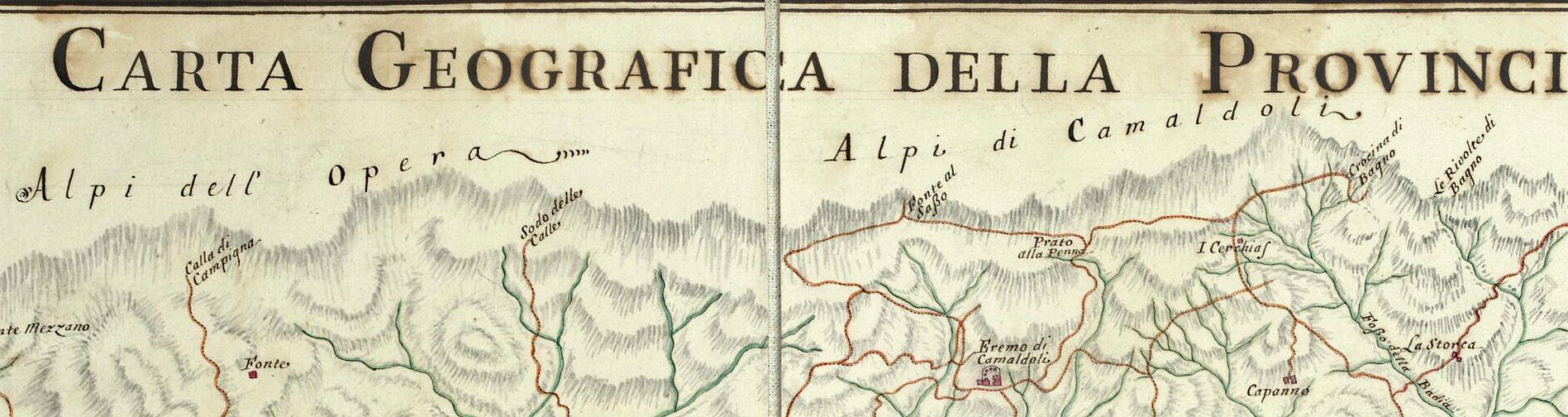
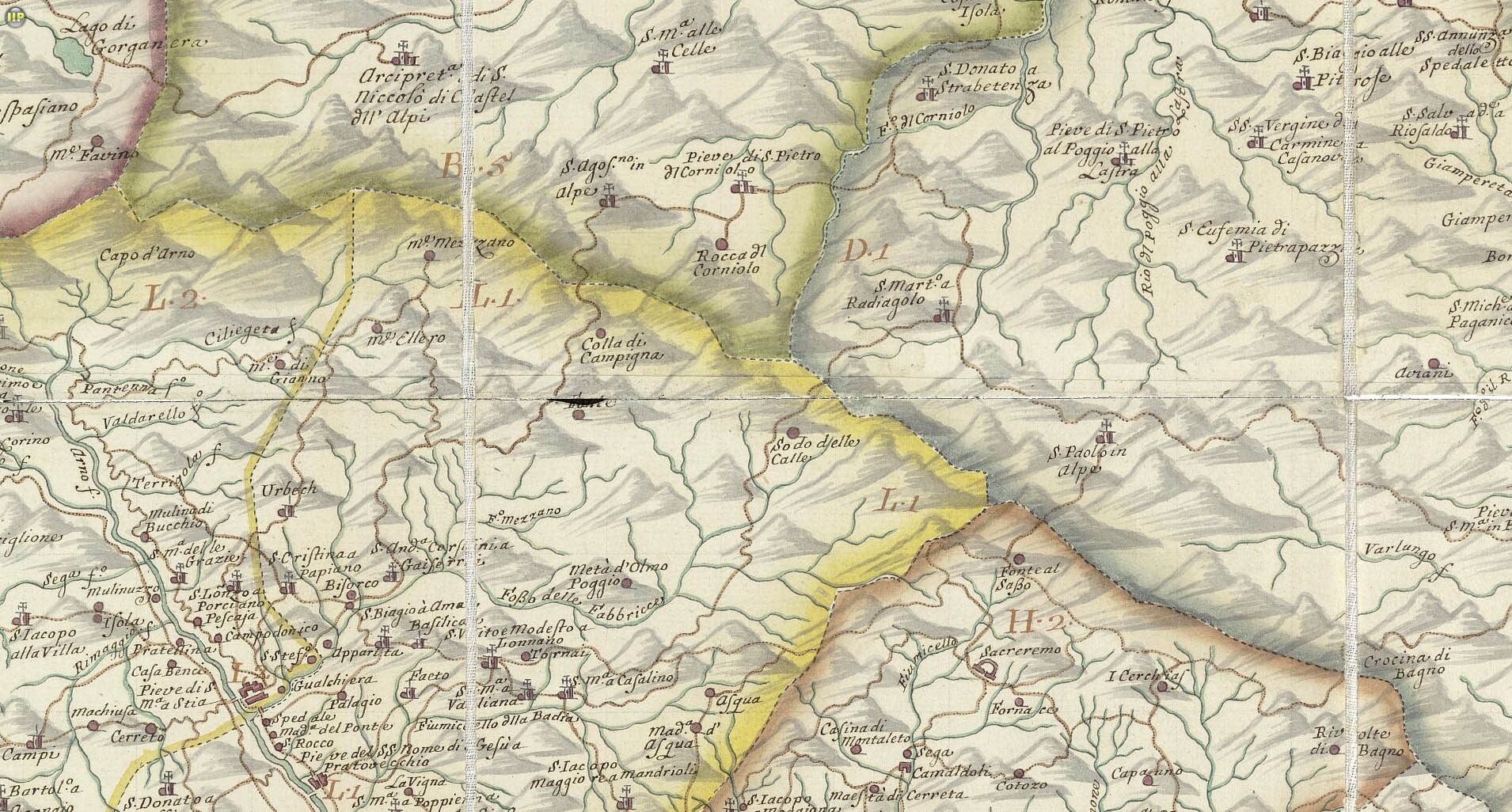
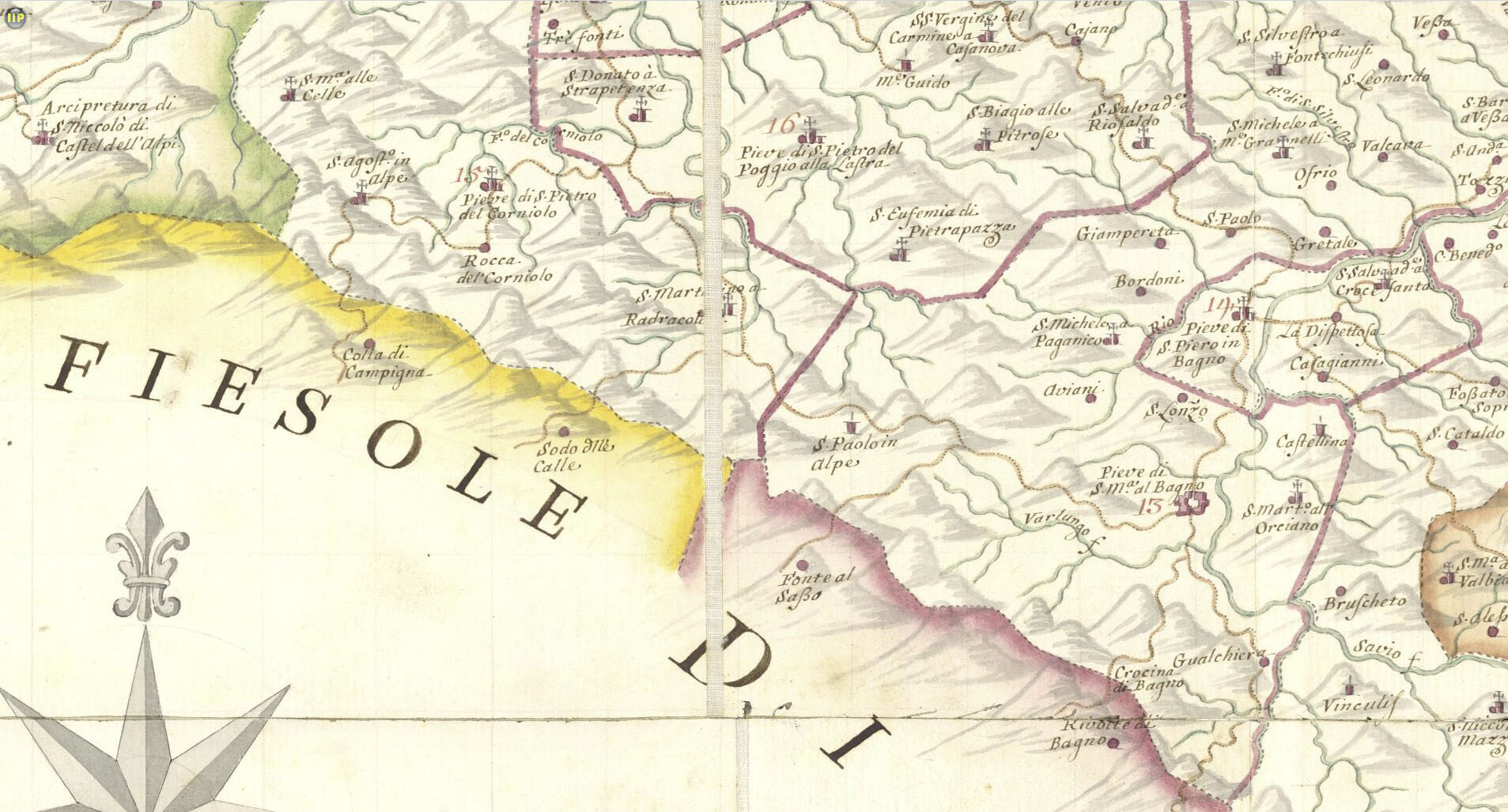
00d6 – 00d7 - Due particolari di valore pittorico. Nella Pianta del Casentino, Mugello, Val d’Arno di Sopra, databile 1760-1780, è evidenziato il Falterona con unico oronimo riportato., La mappa Vicariato di Poppi o Casentino, del Morozzi risalente al 1770-1783, è completata da riquadri nella cornice con varie vedute, tra cui quella del Castello di Stia, ovvero del borgo nel suo aspetto settecentesco a cui fa da sfondo la catena appenninica disegnata a tratteggio e sfumo con acquerello grigio. Sono anch’esse conservate presso il Nàrodni Archiv Praha - Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, nn. 229 e 182-2, Autorizz. NACRX0063I4I Prot. NA- 3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabili sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp - Licenza CC BY 4.0.
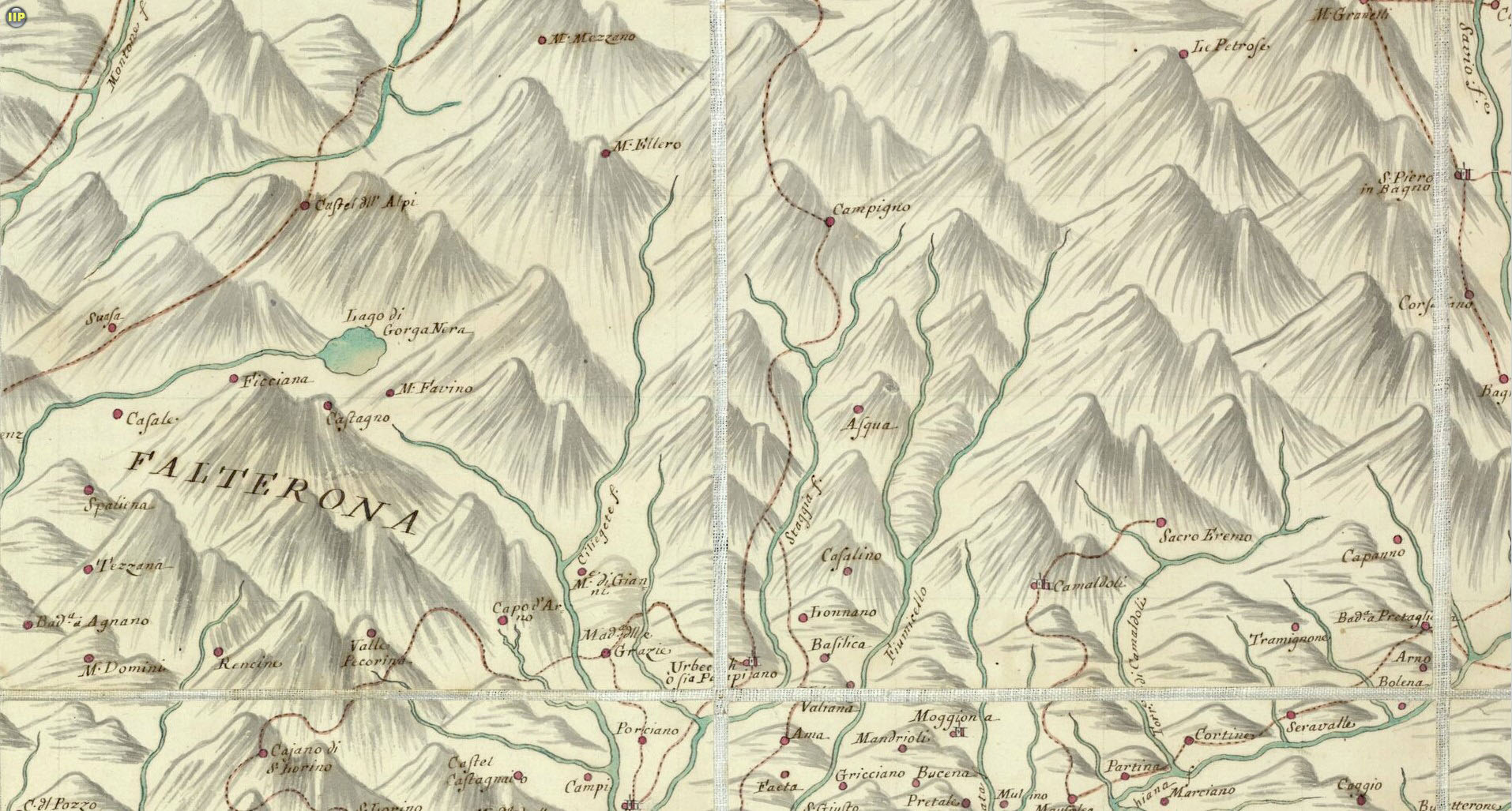
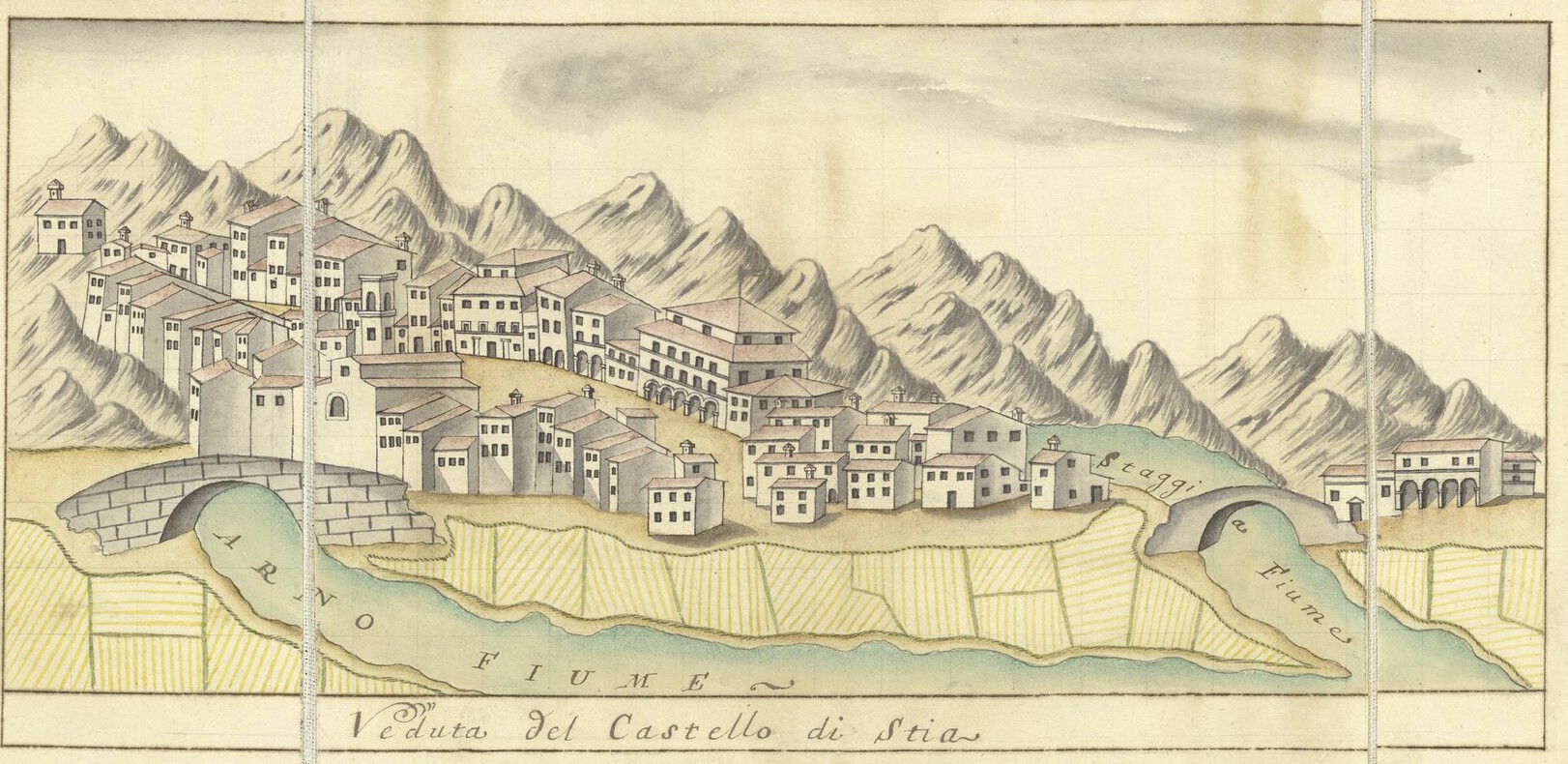
00d8 – 00d9 – 00d10 – Di seguito, tre ritagli dalla Carta Geometrica della Regia Foresta Casentinese dove, tra l’altro, si notano tre tratti della Giogana dal Passo della Calla a Poggio Scali, da Poggio Scali all’Eremo e dall’Eremo al Passo della Crocina. La mappa è conservata presso il Nàrodni Archiv Praha - Fondo Rodinný Archiv Toskánsckých Habsburku, n. 369, Autorizz. NACRX0063I4I Prot. NA- 3430-2/04-2025 del 17/06/25 e consultabile sul portale CASTORE della Regione Toscana https://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartografia_storica_regionale_start.jsp - Licenza CC BY 4.0.
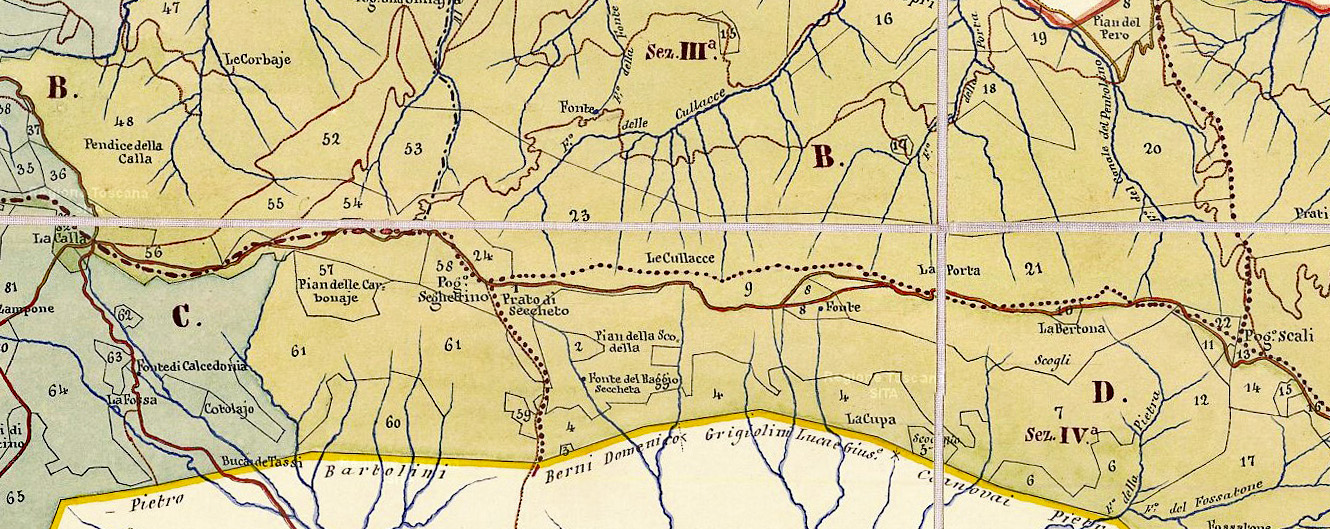
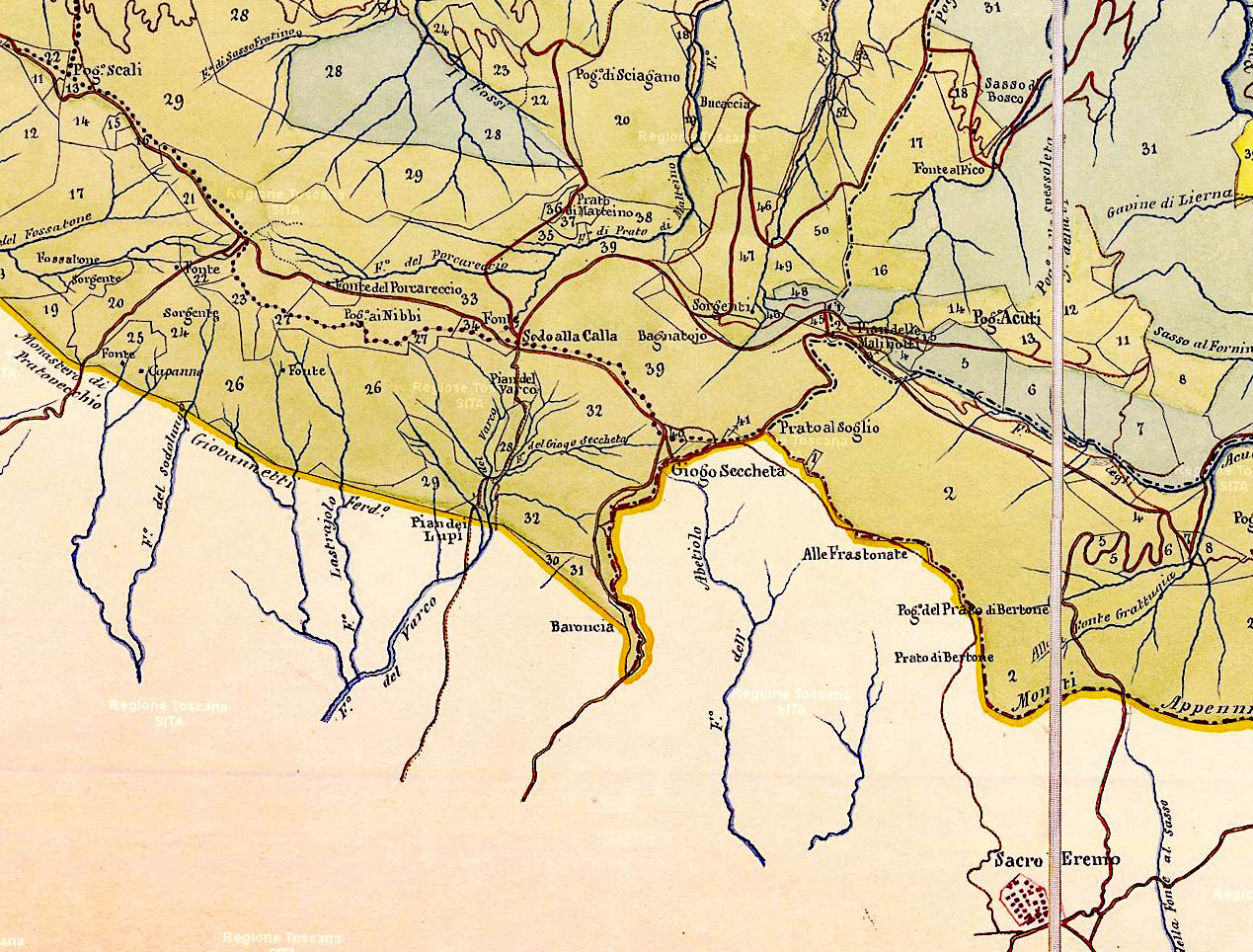
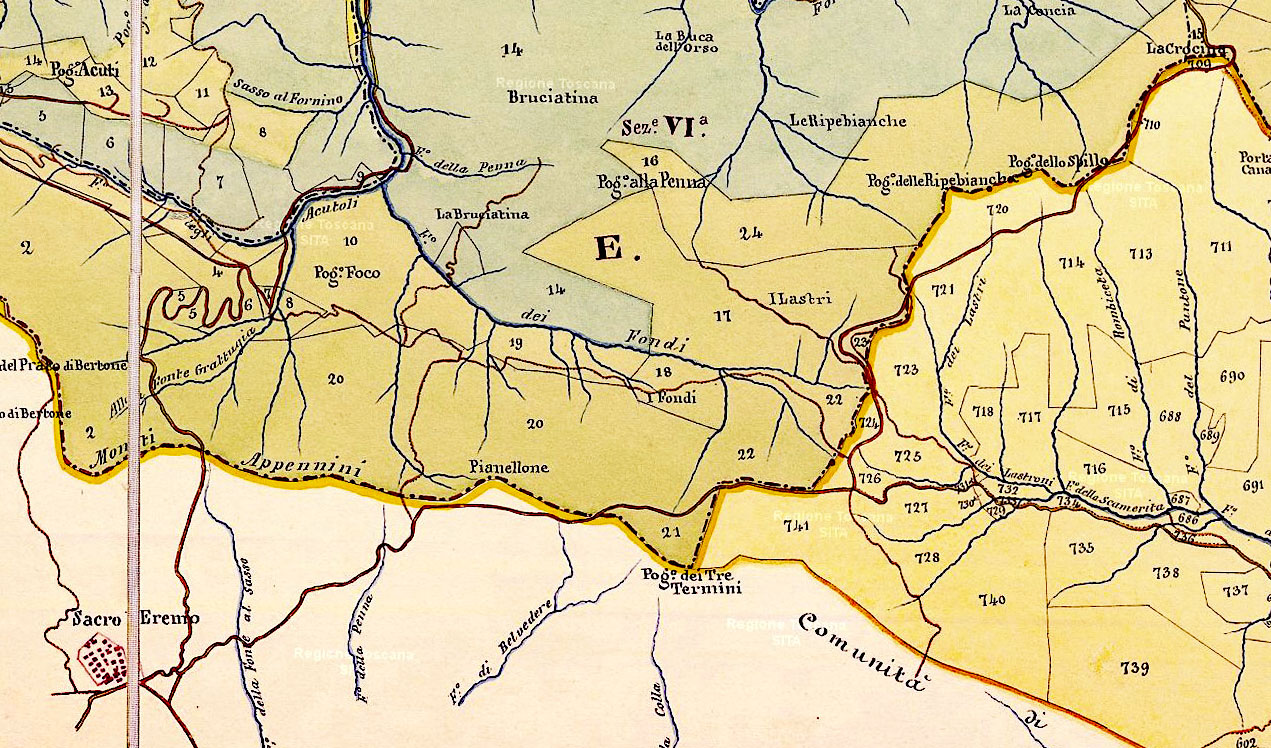
00d11 – 00d12 - Cartolina spedita nel 1964 riproducente Galeata nello sfondo della sua rupe, n. di serie 197 edita dalla Cartolux, fondata da Torquato Nanni Jr., che già negli Anni Trenta e Quaranta andava in giro per la Romagna a fotografare, come ricordano le figlie, e cartolina riproducente anche l’area di Pianetto, dove sorgeva Mevaniola. In età romana l’alta Val Bidente ricadeva sotto il controllo del Municipio di Mevaniola, centro cittadino dotato di teatro e terme, cosiddetto per i rapporti con gli umbri di Mevania, l’odierna Bevagna. L’economia locale, prevalentemente pastorale, e le consuetudini religiose caratterizzavano la piccola Mevania già dalla protostoria in rapporto al Casentino con i pellegrinaggi ai santuari delle acque medicamentose sul Falterona. Tra IV e V secolo d.C. questo centro istituzionale viene a mancare, decaduto e abbandonato per la stasi dei mercati e l’insicurezza dei traffici successivamente alla guerra greco-gotica (535-553 d.C.) e alla calata dei Longobardi (568 d.C.). Segue cartolina databile agli Anni Novanta dove è parzialmente visibile l'area archeologica di Mevaniola tra Galeata e Pianetto.
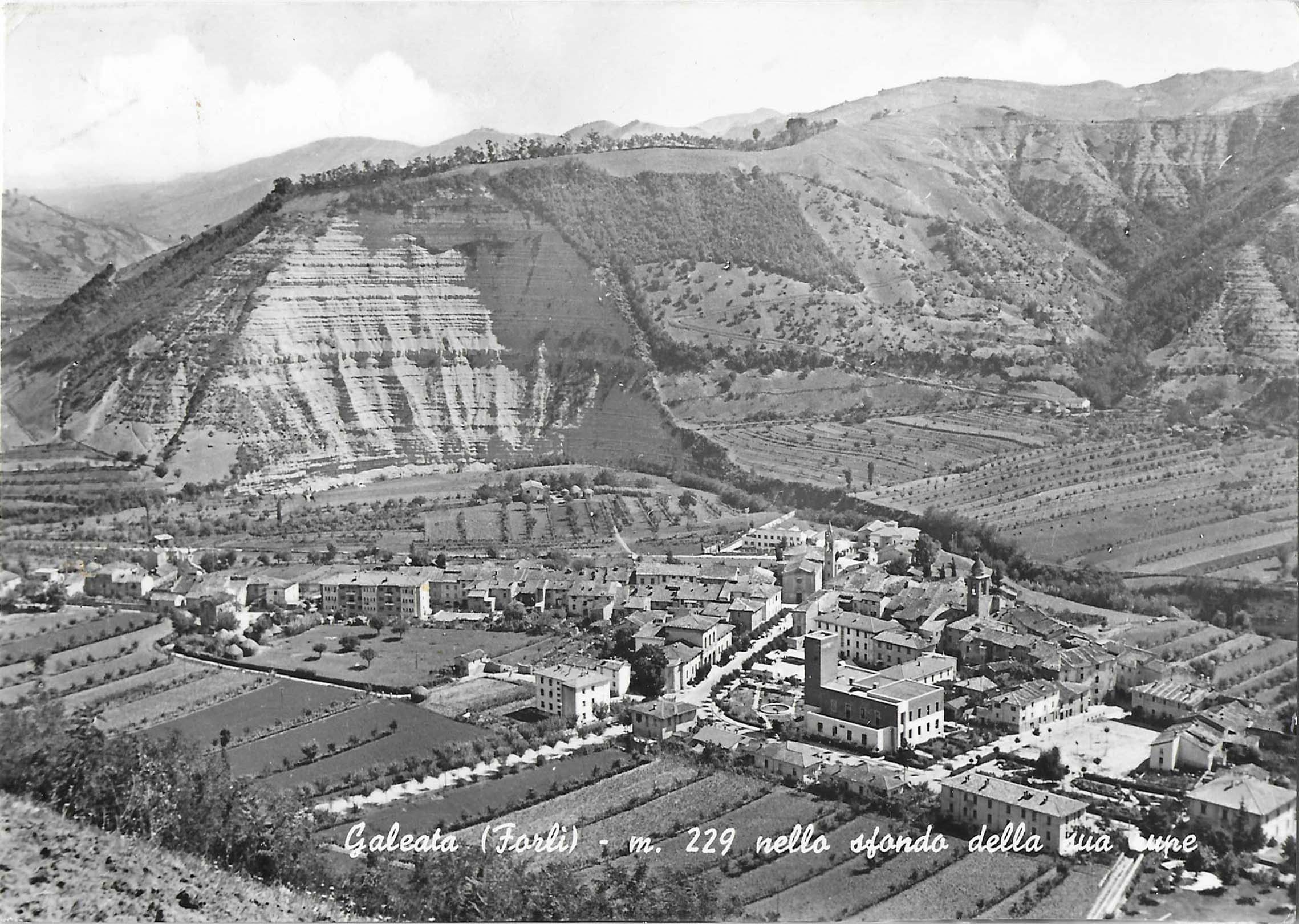
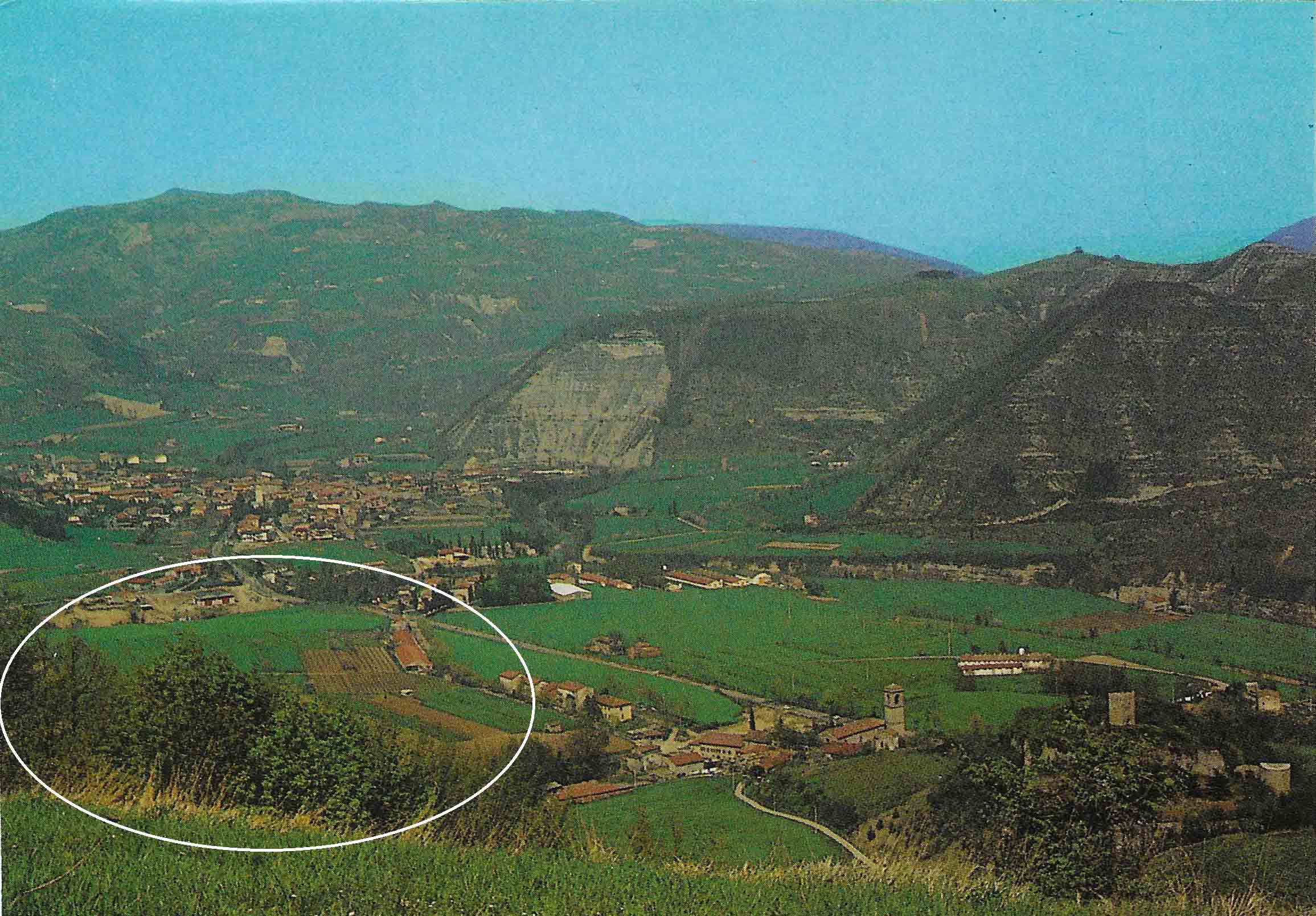
00e1 – Schema grafico evidenziante lo sviluppo della linea del crinale appenninico accompagnato dal profilo del crinale con le misure altimetriche maggiorate di 5 volte rispetto alle distanze in linea d’aria tra i rilievi, in modo da evidenziarli, altrimenti per le minime differenze intrinseche la stessa linea sarebbe risultata quasi piatta.
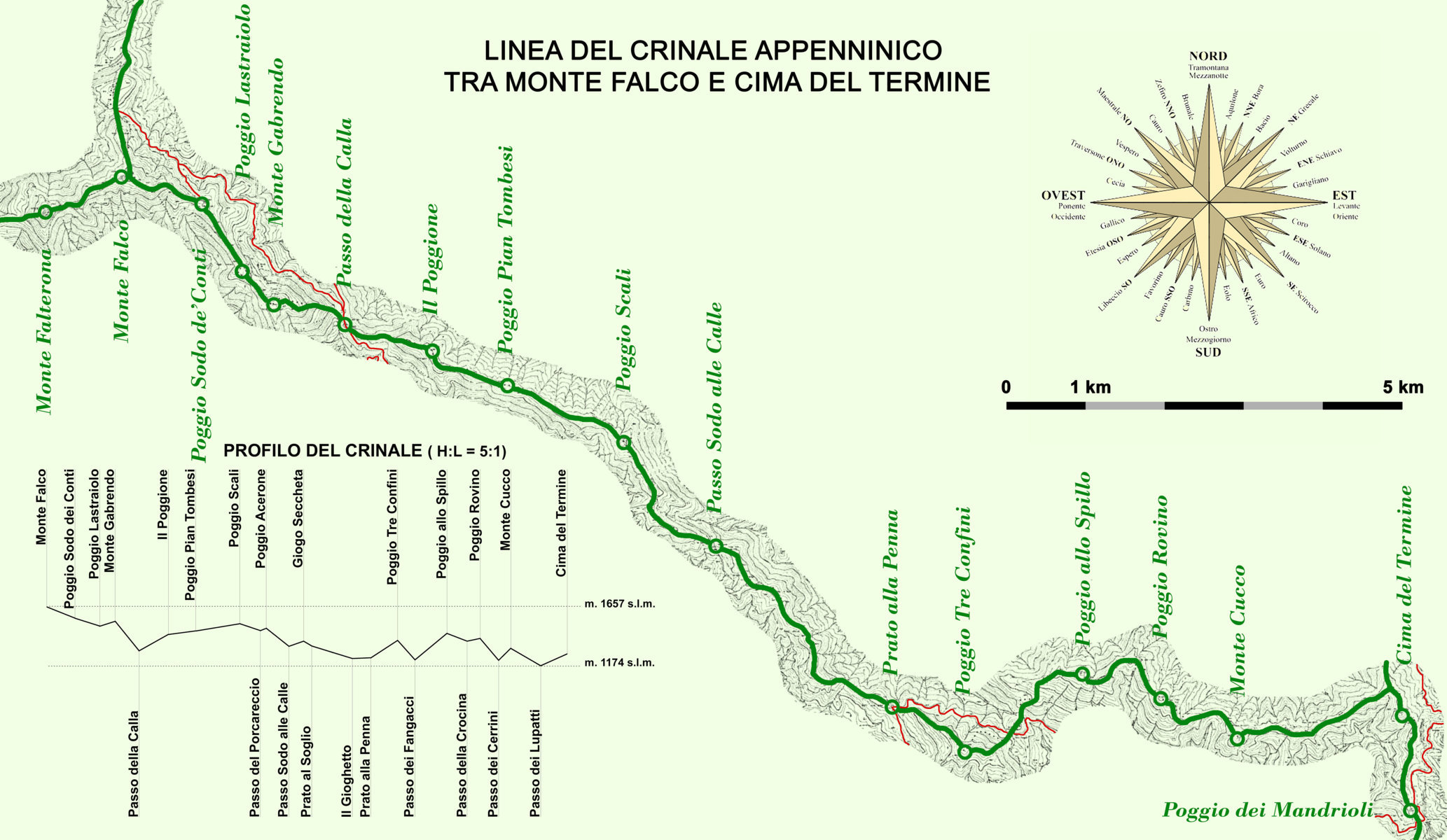
00e2 – 00e3 - Mappa originale della Giogana tra i Passi della Calla e della Crocina, dove le diverse colorazioni evidenziano le fasce altimetriche a partire da 1200 m s.l.m.; le isoipse (curve di livello) hanno equidistanza di 50 metri, tipico della cartografia in scala 1:50.000 per alleggerire il peso grafico, e mappa del tratto tra il Passo del Porcareccio e il Monte Zuccherodante dove è evidenziato lo sfalsamento e sdoppiamento dei crinali, con creazione delle valli degli Acuti e dei Fangacci con sbocco nella Lama, oltre al grande anfiteatro geografico di Badia Prataglia (quote evidenziate da colorazioni a partire da 1150 m s.l.m.).
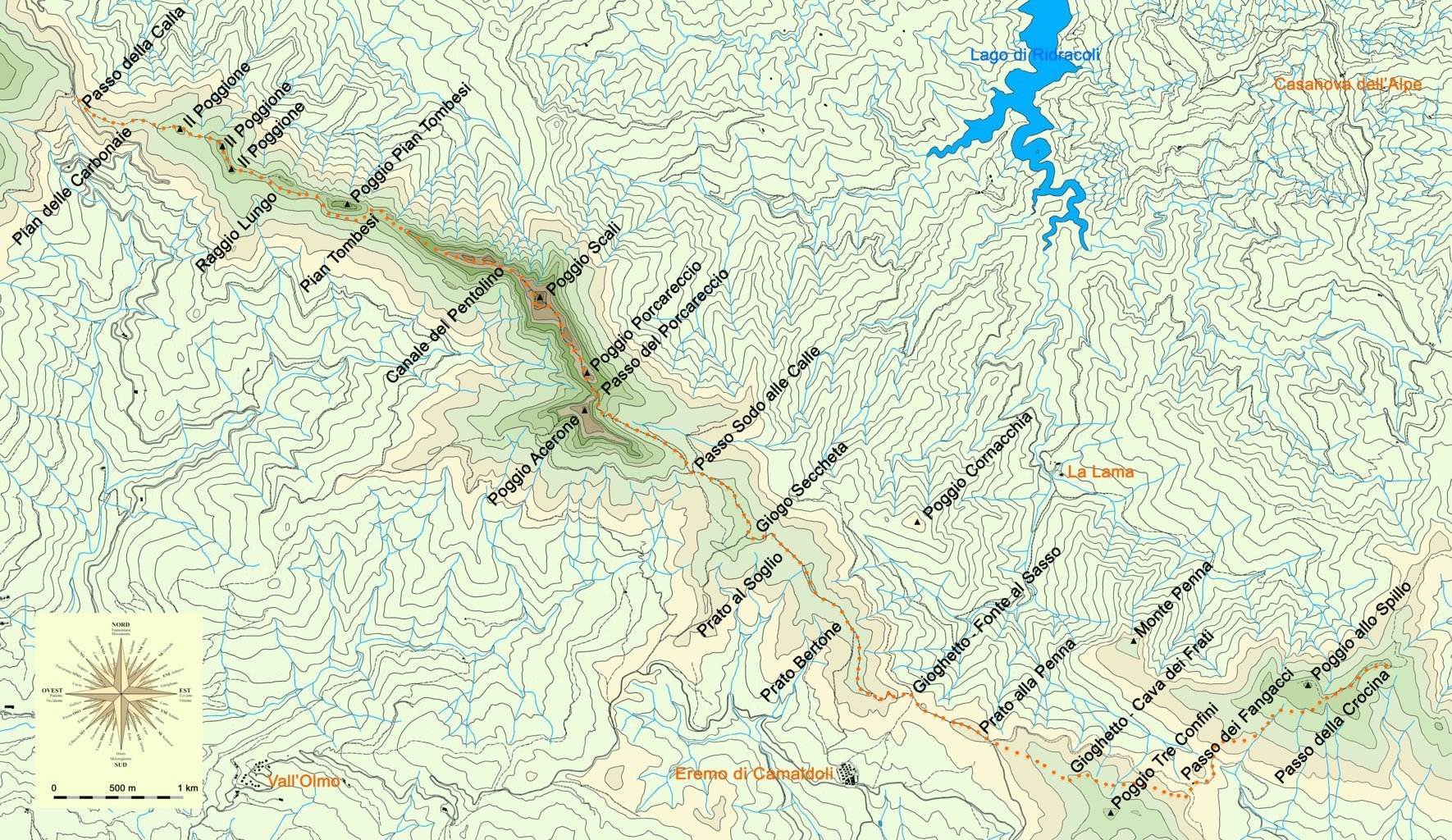
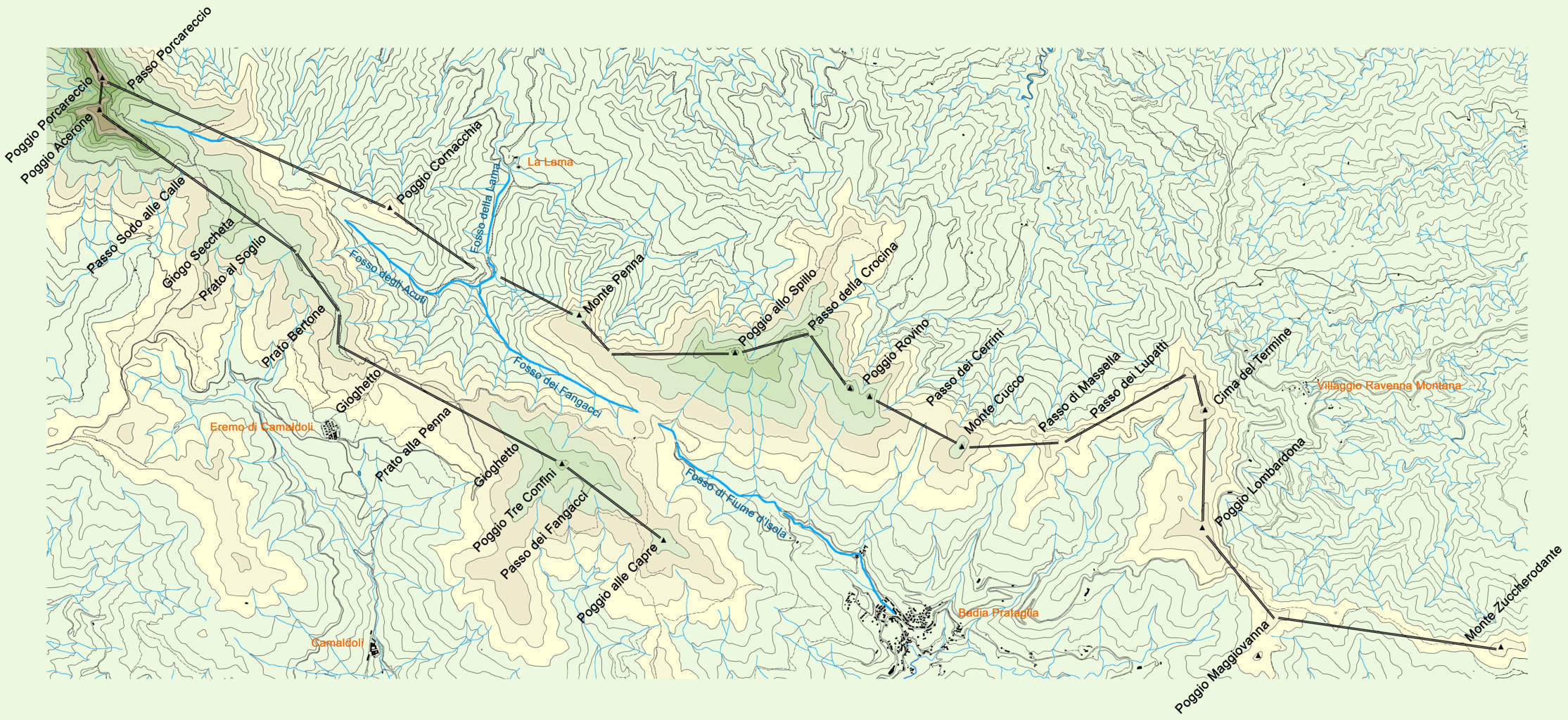
00f1a – Santa Sofia adagiata nella Valle del Bidente; sullo sfondo la Giogana con Poggio Scali. Foto di Oscar Tordi, per gentile concessione di Paolo Biguzzi per il gruppo id3king. La foto è particolarmente significativa per l’approccio storico-geografico della scheda riguardo la rappresentazione della remota meta che proprio attraverso questa valle si prefiggevano di raggiungere viandanti e conquistatori, ma anche commercianti, agricoltori, boscaioli, etc. alla ricerca delle risorse offerte dalla natura selvaggia. Pare giungesse fin qui la strata petrosa Langobardorum che conduceva ai valichi appenninici e il re dei longobardi Grimoaldo, che forse la percorse, avrebbe visto un simile panorama (30/04/25).

00f1b – Una veduta sullo stesso asse visivo della precedente panoramica, ma più ravvicinata: S. Sofia di Romagna (m. 257) Panorama nello sfondo dell’Appennino Tosco-Romagnolo, è riprodotta sulla cartolina Cartolux n. di serie 11; l’edificato della cittadina documentato dalla cartolina panoramica (una delle prime della serie, però non viaggiata - collezione personale) corrisponde all’estensione rilevata dalla mappa del 1937 dell’I.G.M., per cui si può datare l’epoca dello scatto fotografico agli Anni Trenta-Quaranta.
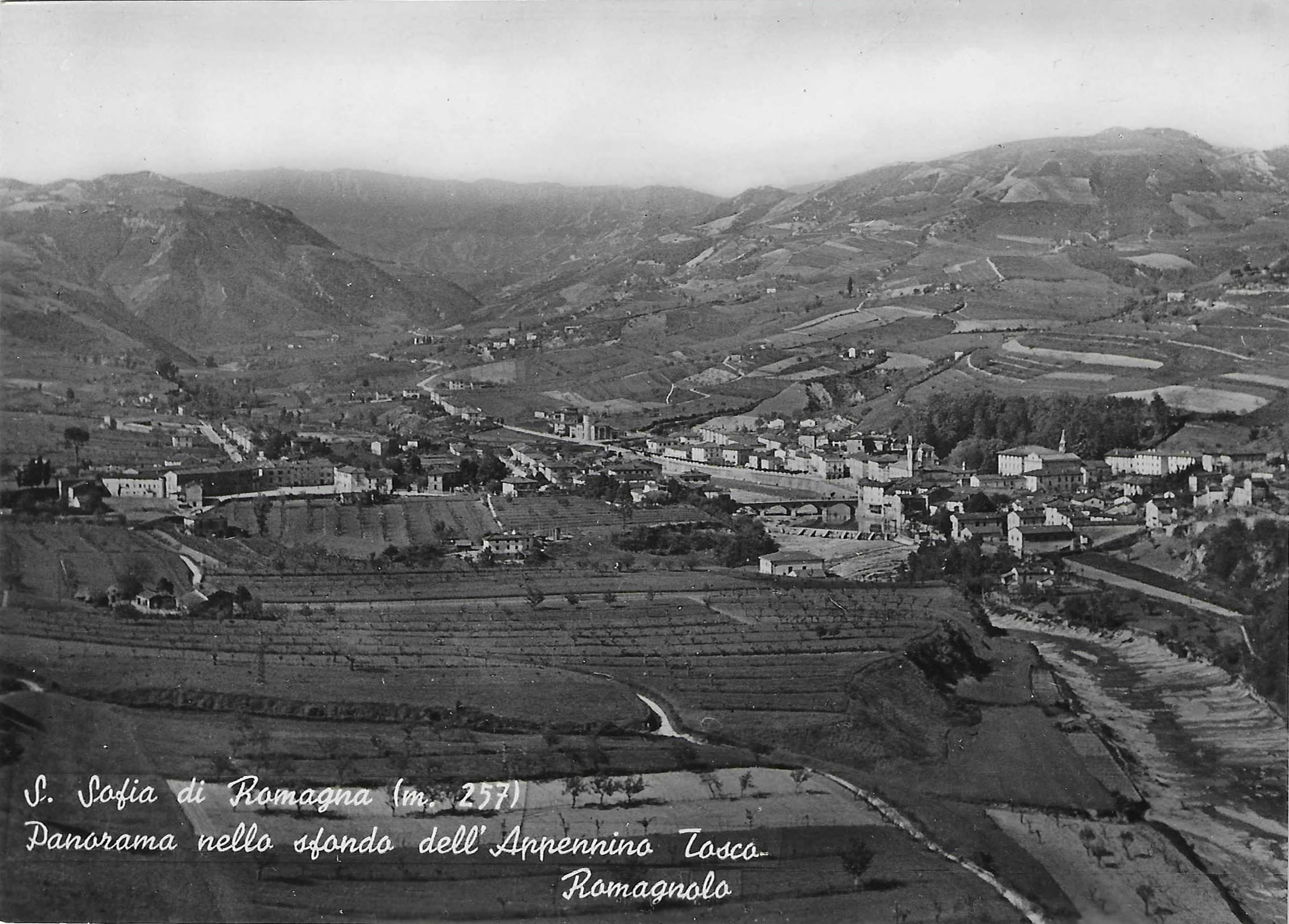
00f2 – 00f3 - 00f4- Dal Monte Piano, si gode la più ampia panoramica dello Spartiacque Appenninico compreso tra il Monte Zuccherodante e il complesso del Falterona (1/01/12).



00g1 - Dal crinale tra Poggio Squilla e Poggio Aguzzo, a monte di Ristèfani, panoramica della valle del Bidente di Campigna coronata dal tratto di Spartiacque Appenninico tra Poggio Scali e il Monte Gabrendo (25/04/18).

00h1/00h5 – Panoramiche da Casanova dell’Alpe, dal Monte Cerviaia, da cui si può notare la linea altimetrica piuttosto costante di un ampio tratto del crinale, e dai campi di Palestrina (5/10/16 – 16/10/16 – 28/08/18).





00i1/00i6 – Da S.Paolo in Alpe, panoramiche primaverili e pre-invernali della Giogana (25/04/18 – 21/11/18).






00i7 - Il tratto più consistente della bastionata, costituito dalle Ripe di Scali, Ripe della Porta e Ripe di Pian Tombesi, si osserva da distanza ravvicinata dal versante meridionale di Poggio Capannina (16/11/16).

00l1 – 00l2 – 00l3 – Dalla S.P.n.4 del Bidente, vedute della Giogana tra il Passo della Calla e Poggio Scali (28/03/18 – 20/05/18).



00m1 – 00m2 – Dal Monte Penna, scorci prospettici della Giogana da Giogo Seccheta a Poggio Scali con il vallone del Bagnatoio delimitato dallo sdoppiamento di cresta fino a Poggio Cornacchia e il versante impervio di Sasso Fratino (10/12/10 – 7/2/11).


00n1 – Dal crinale tra Poggio Sodo dei Conti e Poggio Lastraiolo, scorcio prospettico della Giogana che esalta l’innalzamento di Poggio Scali (22/12/11).

00o1 – 00o2 – 00o3 – Da Poggio Giogarello, uno dei rari scorci dello Spartiacque dal lato toscano, con particolare della Riserva La Pietra e del Geosito omonimo; si nota PoggioScali (11/01/12).



00p1 – Da Scarpaccia, a monte di Pratovecchio, panoramica da remoto dal lato toscano dello Spartiacque, dal Falterona (dietro il palo) al Passo Sodo alle Calle o La Scossa; qualcosa poi emerge sulla verticale del Castello di Romena che spunta oltre la boscaglia in medio piano, forse Poggio allo Spillo (22/07/13).

00p2 – 00p3 – Vedute di fine ‘800 del Falterona e dello Spartiacque da Stia contenute in cartoline postali di inizio ‘900: la prima, spedita nel 1900, mostra il versante montano ancora non segnato dalla futura strada provinciale con il borgo antico nel fondovalle mentre emerge in lontananza il gruppo del Falterona, la seconda, spedita nel 1904, evidenzia la struttura ottocentesca del borgo alla confluenza tra Staggia ed Arno attraversati dai due ponti antichi mentre in lontananza emerge il tratto di Spartiacque dal Monte Gabrendo verso Poggio Sodo dei Conti ed oltre (collezione personale).
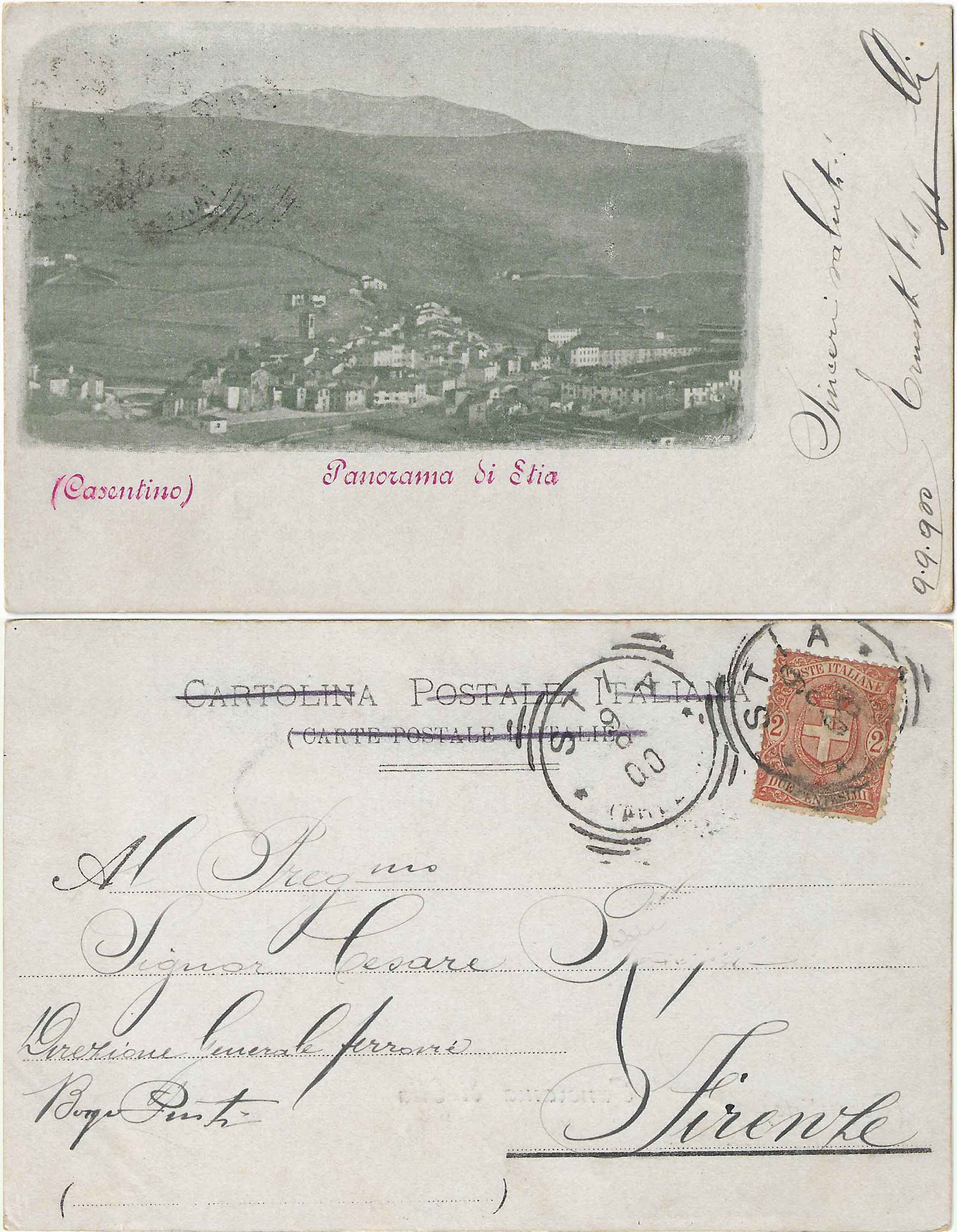
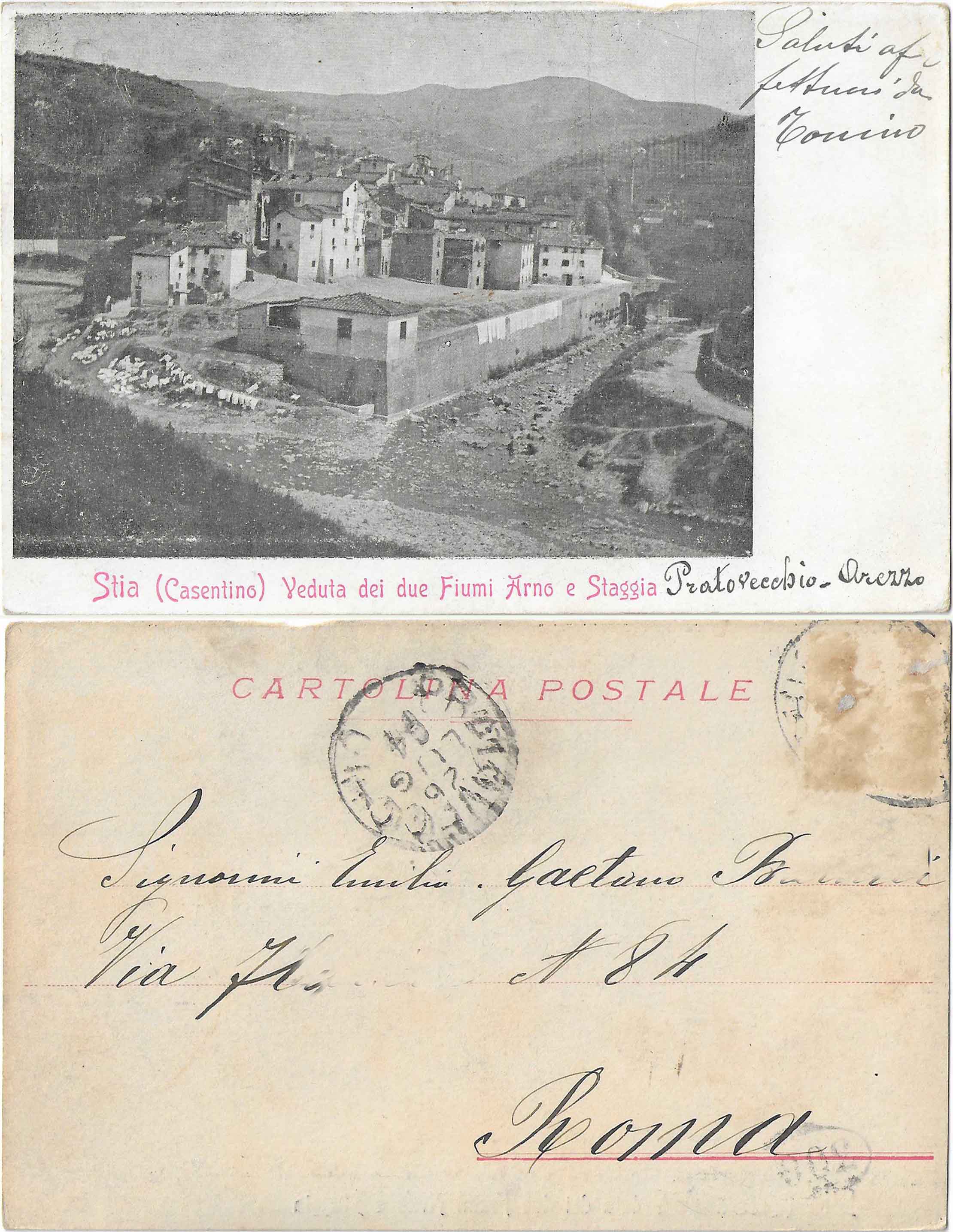
00p4 – Cartolina datata 1916 con soggetto il Ricovero Dante artisticamente riprodotto sul Falterona, come da didascalia Proprietà edil. Luigi Poggiolini in Rocca S. Casciano – Prem. all’Esp. Di Lodi 1901. Perugia 1902 (Medaglia d’oro), da S. M. la Regina Elena e a Firenze Esposiz. 1904. Il frontespizio riporta la terzina dantesca Purg. XIV, 16-18 sull’Arno (collezione personale).
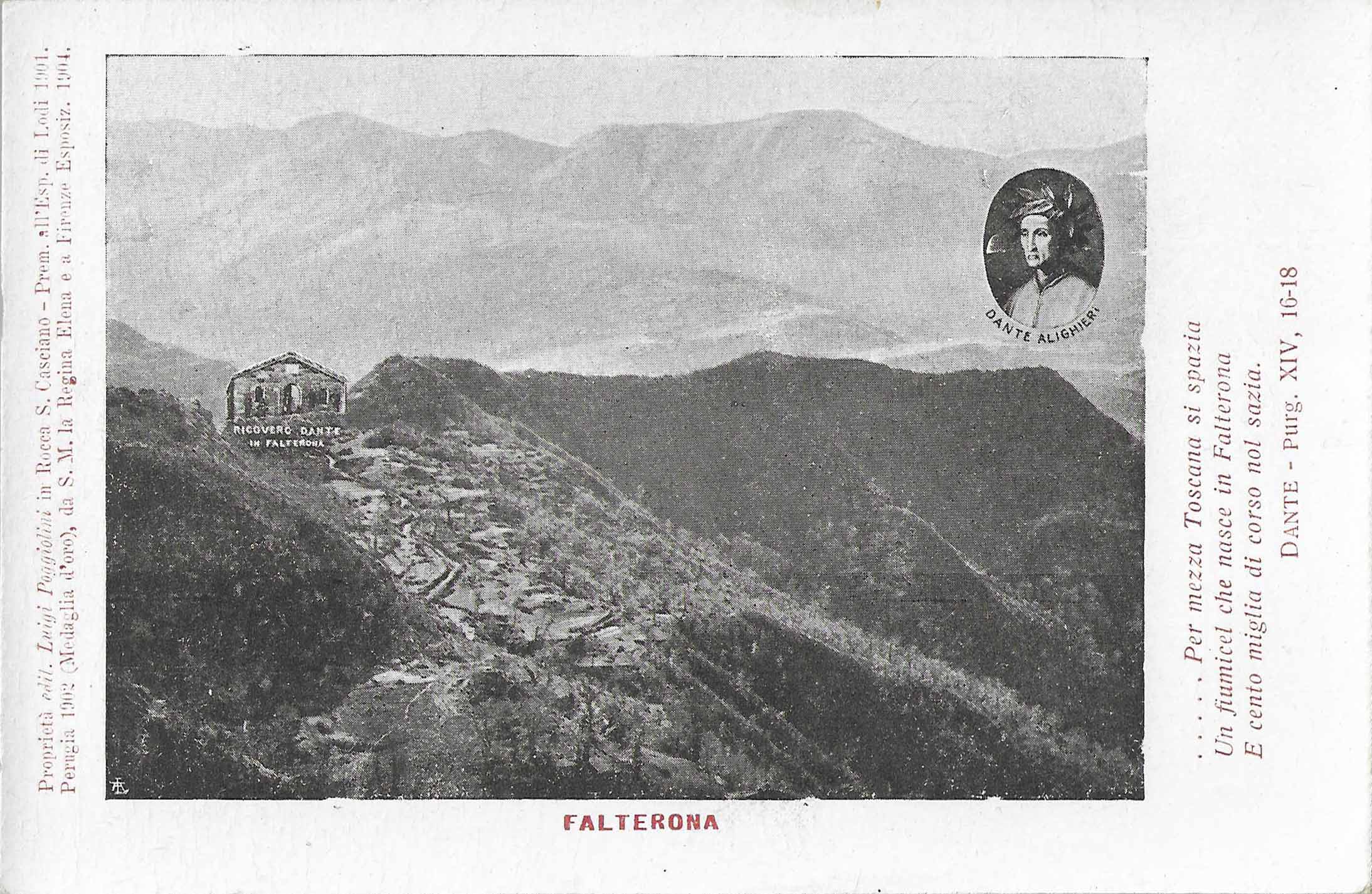
00p5 – Veduta del Ricovero Dante tra militari e cacciatori in posa secondo uno scatto fotografico che pare fosse apologeticamente tipico all’epoca, contenuta in una Cartolina Postale spedita nel 1906 (collezione personale).
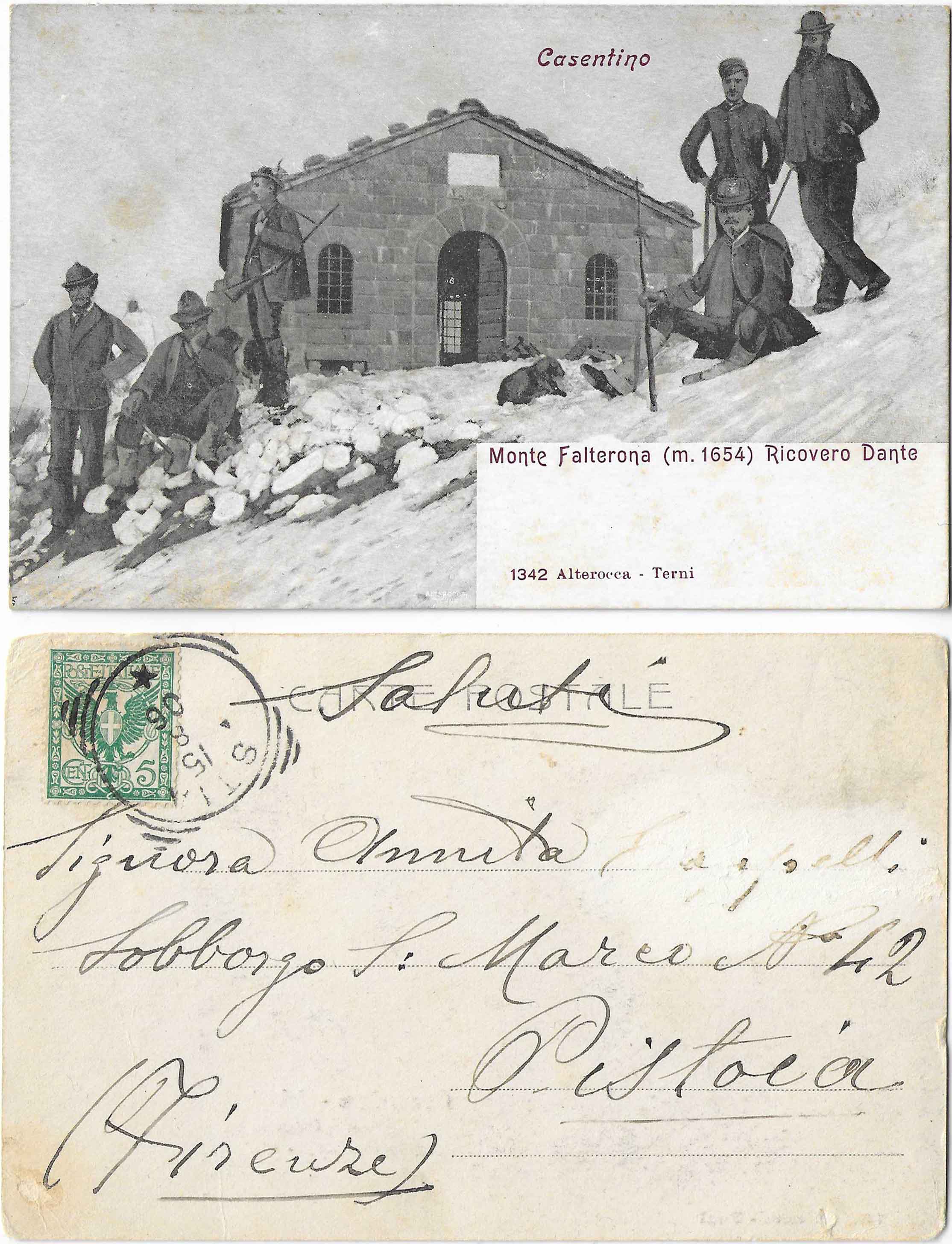
00p6 – 0097 – Veduta del Ricovero Dante tra spalatori e sciatori, contenuto nella Guida Beni del 1889 (cit.), ed estratto cartografico del 1894 da cui se ne rileva l’esatta quota e posizionamento rispetto alla vetta del Falterona.
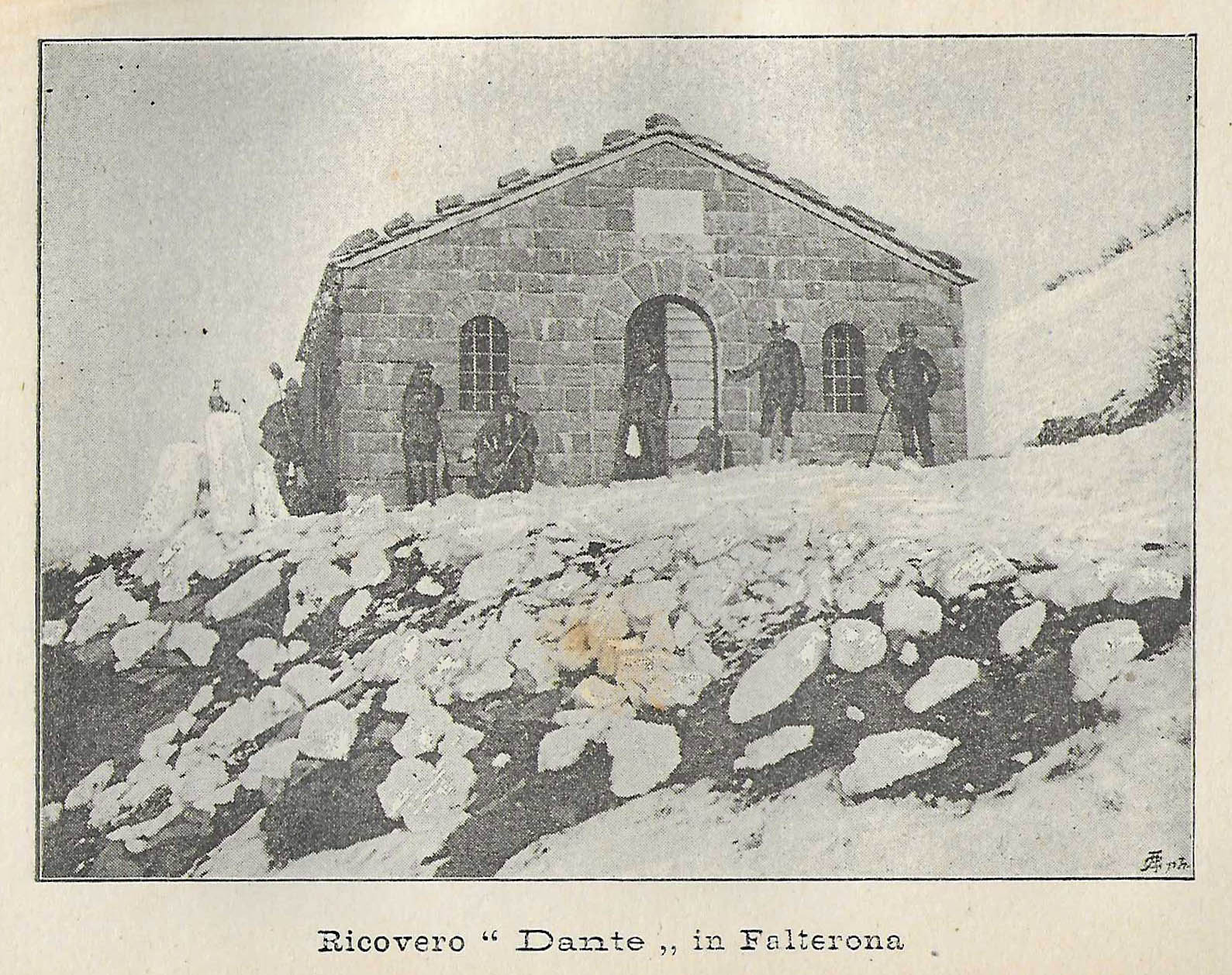
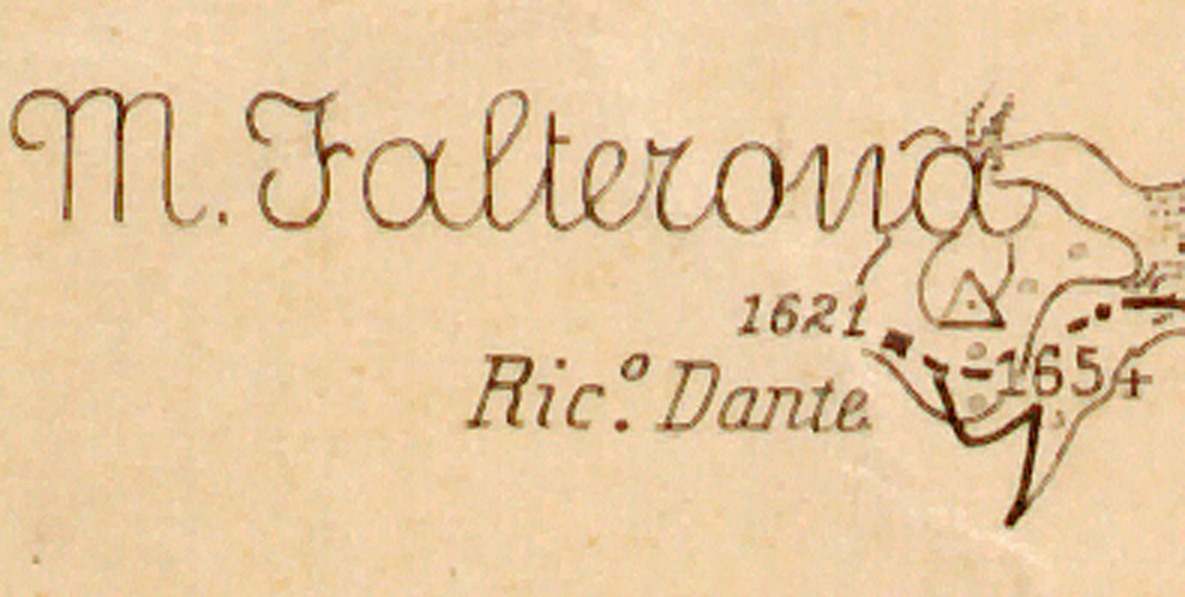
00p8 – Cartolina Cartolux n. di serie 352 spedita nel 1962 contenente veduta Castagno di Andrea e Monte Falterona (collezione personale).
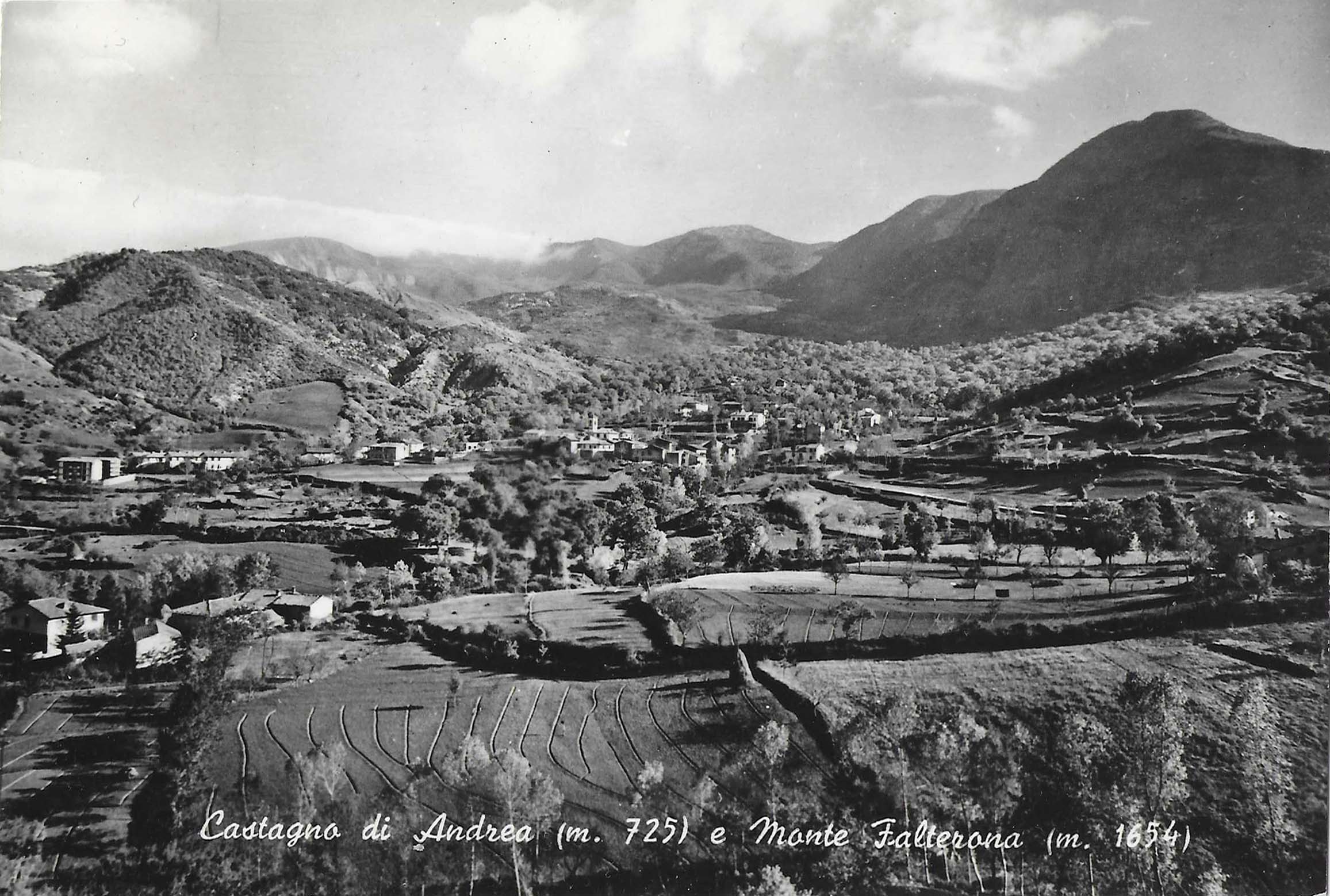
00p9 – 00p10 - Rara cartolina panoramica pieghevole a doppio formato riproducente lo Spartiacque presso Cima del Termine e il Contrafforte Principale tra i Monti Castelluccio e Piano, completa di indice fotografico; la foto, ripresa da S. Piero in Bagno, risale agli anni 1936-37 (Alterocca-Terni XV – Ediz. e Foto Moretti 121743) ed è stata spedita nel 1938. Segue cartolina riproducente il Contrafforte con simile punto di ripresa, Ediz. J. Moretti Fot. A. Canale 29291 2036, spedita nel 1926 (collezione personale).

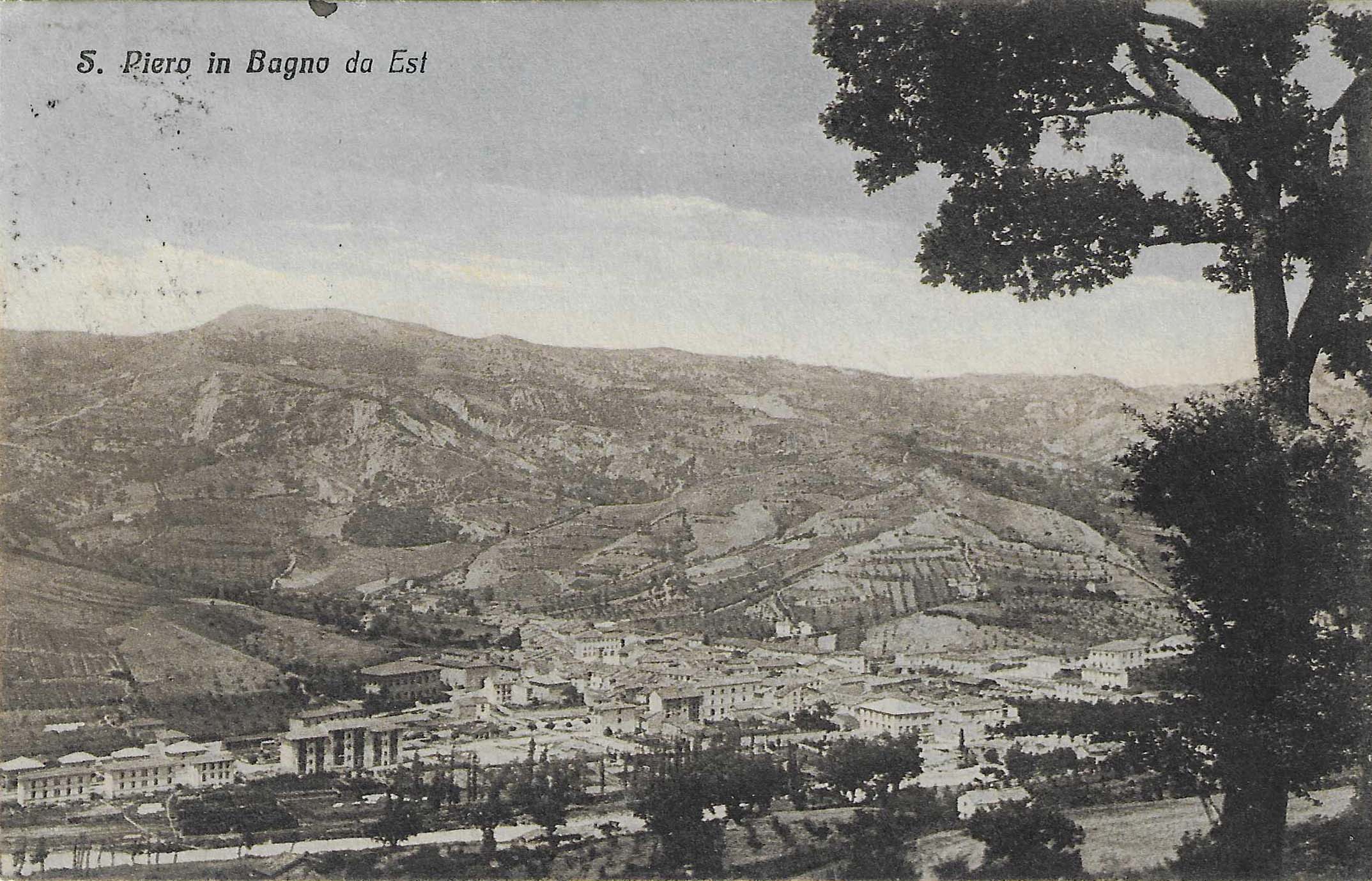
00p11 – 00p12 – 00p13 – Cartoline con foto riprese da Bagno di Romagna verso lo Spartiacque e il Contrafforte Principale; nella prima Ed. Jacopo Moretti spedita nel 1955 si nota tra l’altro il Monte Zuccherodante, le altre due (rispettivamente Ed. Leone Zaccarelli e Fototipia Berretta) hanno identico punto di ripresa ma risalgono per spedizione al 1957, con didascalia sul retro “Terme di Bagno di Romagna” e al 1972 (collezione personale).
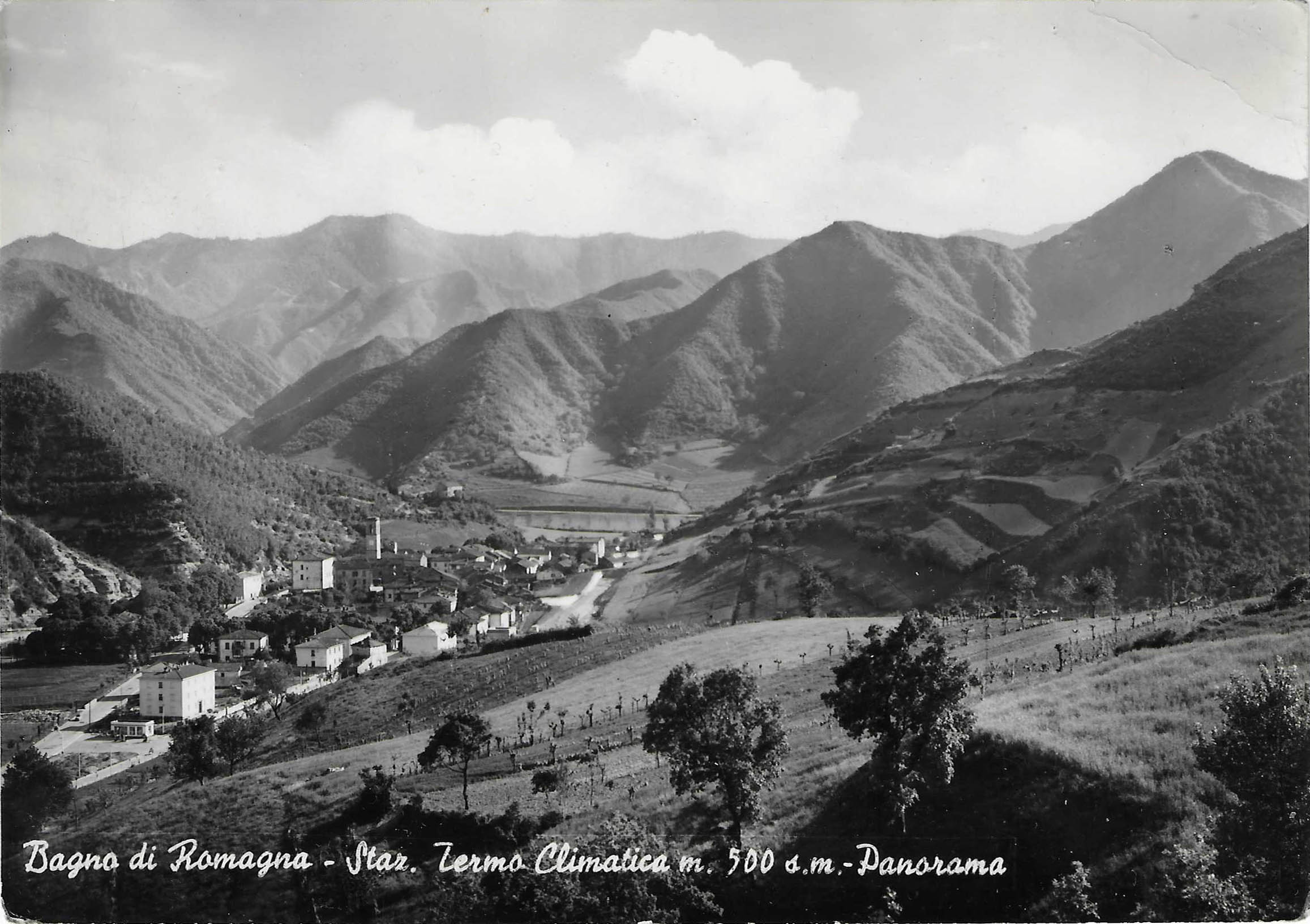
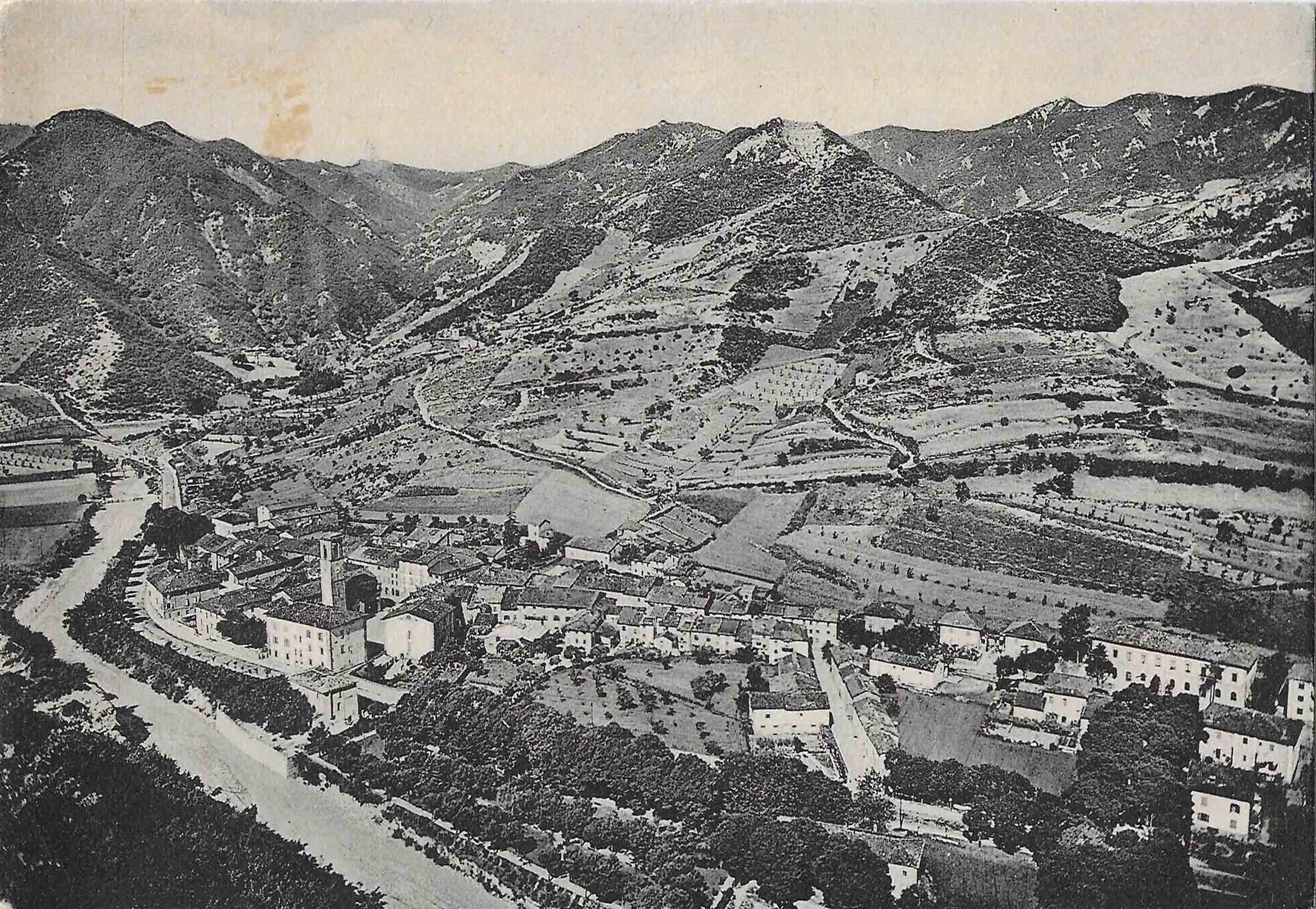
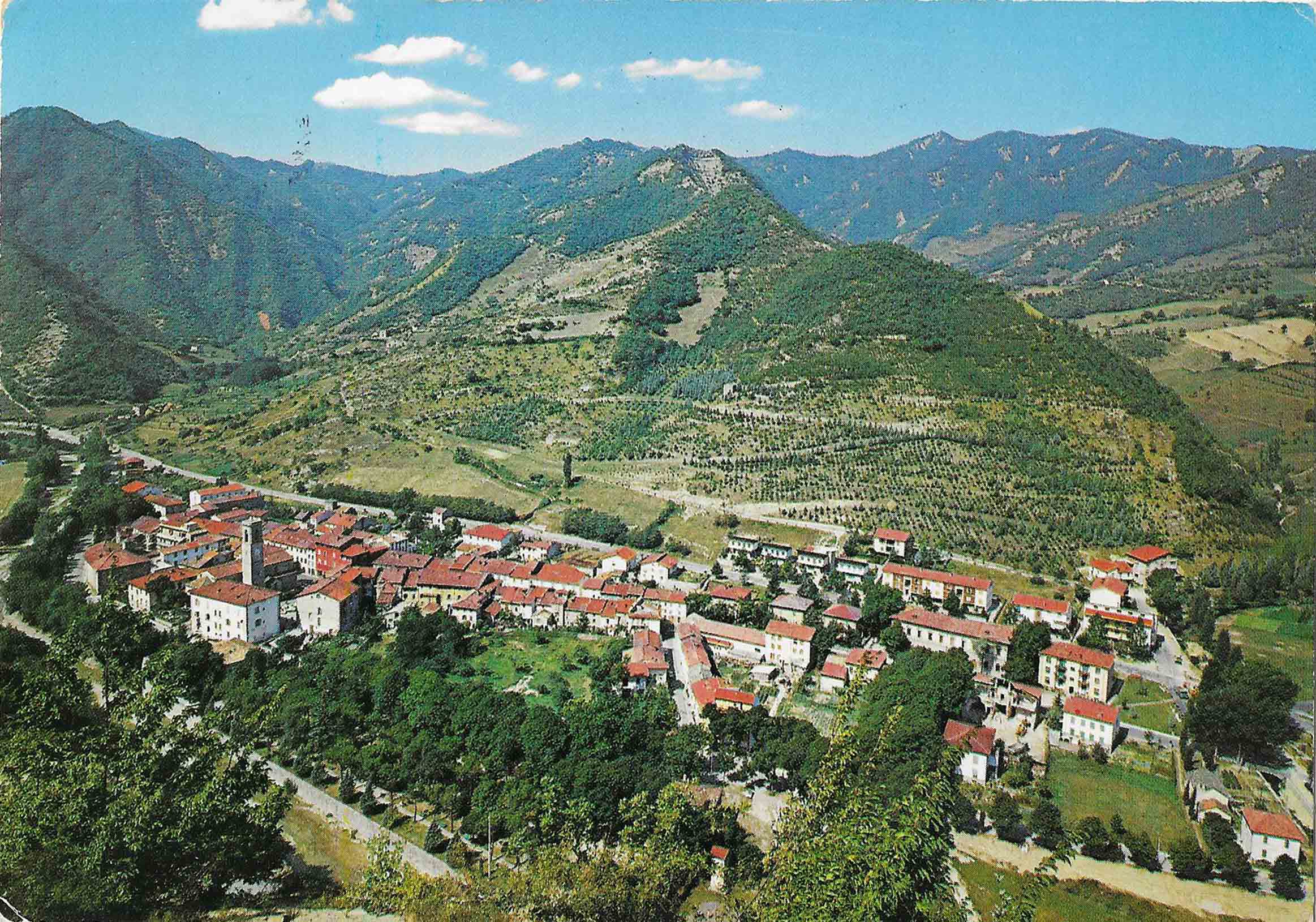
00q1 – 00q2 – Vedute della leggera pendice orientale del Monte Falco e della pista che rasenta la vetta del Falterona interessate dagli antichi itinerari di valico (21/12/11).

00q3/00q7 – Vedute di Monte Gabrendo e di Poggio Lastraiolo con i prati della Burraia, già detta Stradella, area anch’essa interessata da antichi itinerari di valico, in particolare dalla Gran Via dei Legni, di cui si scorge l’imbocco sulle pendici del Gabrendo e cartoline comparative edite dalla Cartolux: la prima n. serie 400 è stata spedita nel 1963, la seconda n. serie 96, spedita nel 1952, ha inquadratura più ravvicinata e in base alla crescita vegetativa e allo stato della sciovia la foto dovrebbe essere anteriore di pochi anni e risalire agli anni 1950-52, comunque entrambe antecedenti alla realizzazione dello skilift (collezione personale) (collezione personale) (21/06/11 – 15/05/23).





00q8a – 00q8b - Fotografia di Pietro Zangheri: Crinale dell'Appennino in località Burraia sopra Campigna (Data scatto: 15-08-29 - Negativo n. ZAN098) e particolare degli edifici. La foto è stata ripresa dal Gabrendo verso Campigna e si notano i due fabbricati della Burraia, la stalla e il locale per la lavorazione del latte, mentre non compaiono i capanni, evidentemente posteriori, e tantomeno il Rifugio Città di Forlì, del 1974 (Fonte: Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Per gentile concessione dell’Ente Parco - Autorizzazione del 5/08/2025).
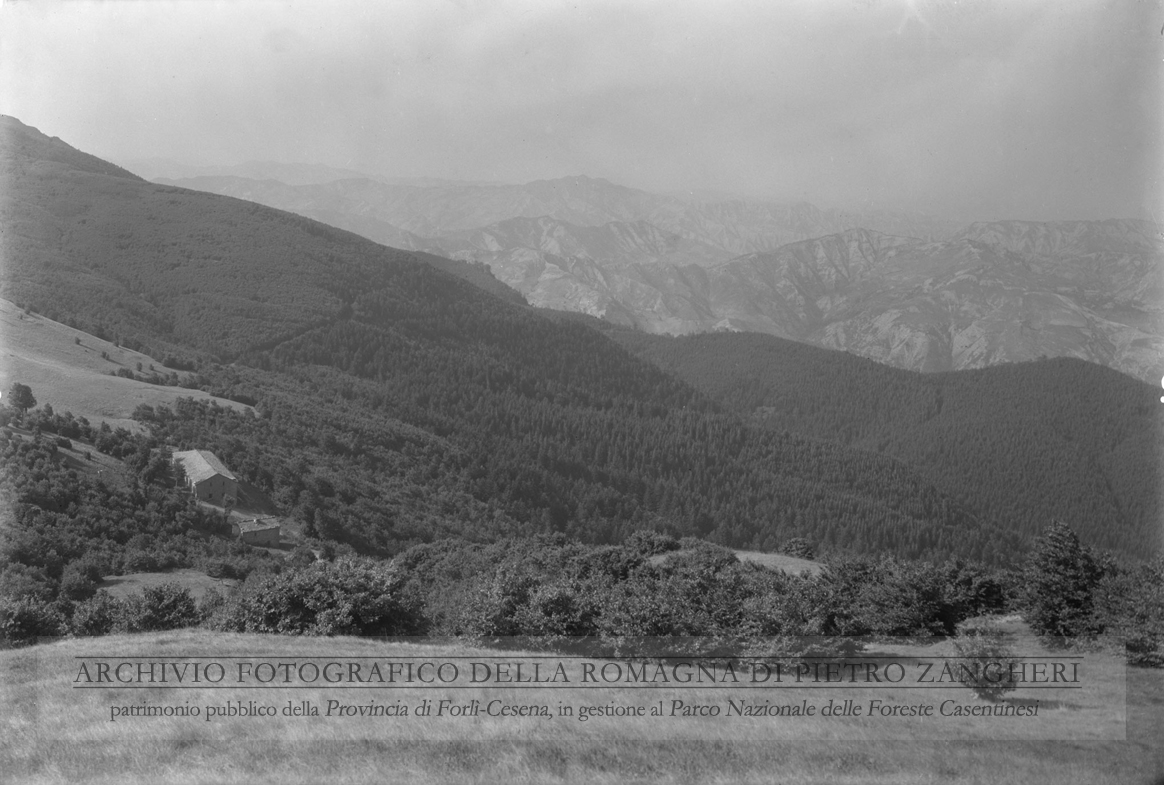

00q8c – Cartolina Postale spedita nel 1900 con veduta della Burraia con mandriani (collezione personale).
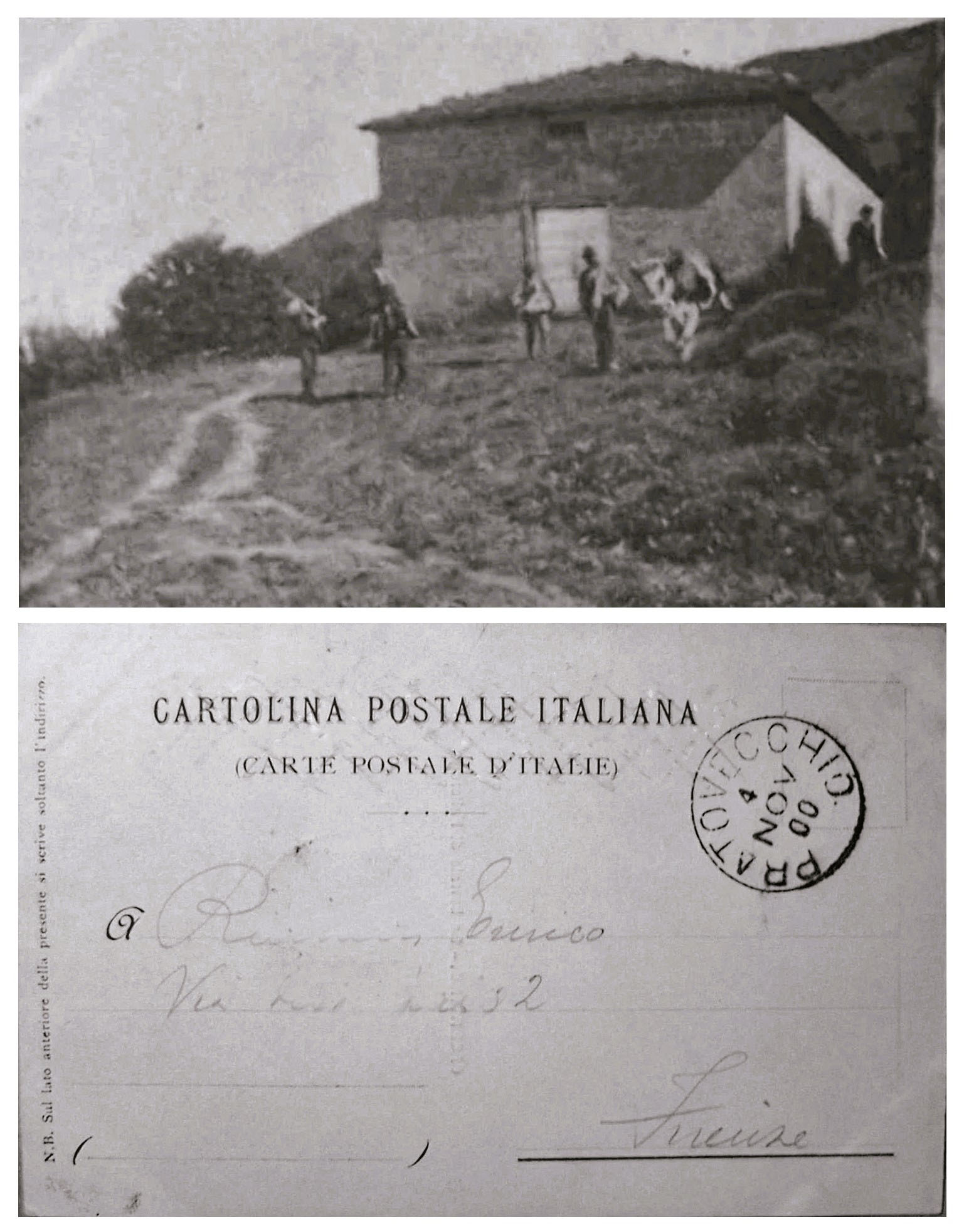
00q9a – Cartolina della Cartolux, n. serie 262/3, Camaldoli Campigna – Campi di sci della Burraia, con veduta della Burraia innevata ripresa dal Gabrendo e l’area sciistica in piena attività, infatti in primo piano si nota lo skilift a palo lungo con molla interna e numerosi sciatori sulla pista dei prati. Nella cartolina, risalente alla fine degli Anni Cinquanta in quanto già esistente lo skilift, si notano inoltre i fabbricati della Burraia e tre ex-casermette militari poste sul margine dei prati, distanziate tra essi, che vennero utilizzate dai militari di servizio presso la stazione radio ubicata presso la Burraia forse fino al 1947; all’epoca della foto una delle tre casermette veniva utilizzata dallo Sci Club (collezione personale).

00q9b – Cartolina della Cartolux, n. serie 264, Burraia (m. 1450) – Nello sfondo della Giogana di Scali (m. 1520), di interesse anche in quanto oltre a recare sul retro il timbro “Villeggiatura Estiva Sport Invernali LA BURRAIA” ha come mittente un militare di servizio al Ponte Radio Militare, probabilmente ancora in funzione alla Burraia essendo forse costruenda la stazione di Poggio Sodo dei Conti. La cartolina, spedita ma con timbro abraso, risalirebbe alla fine degli Anni Cinquanta per via del n. di serie (collezione personale).
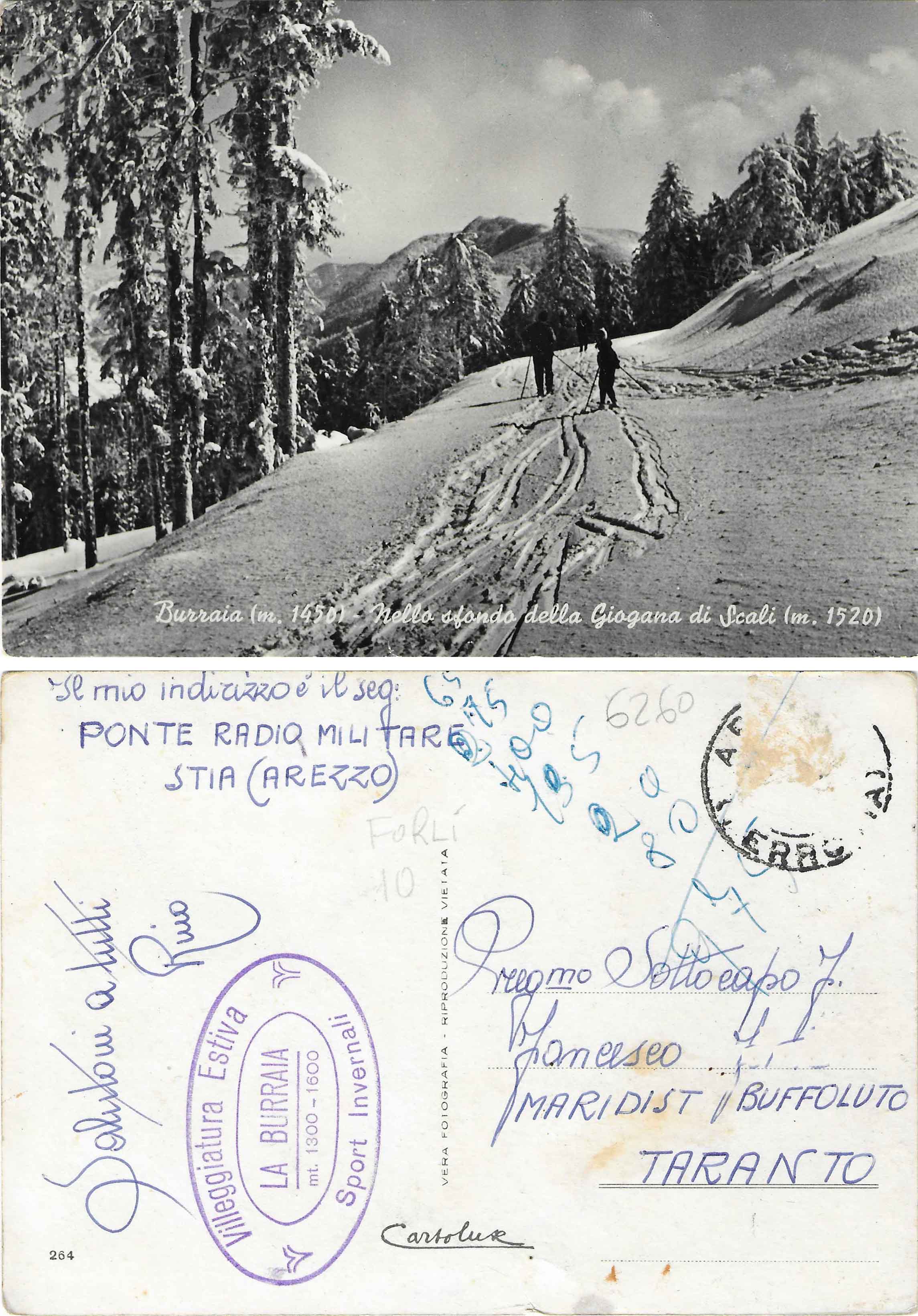
00q10 - Cartolina della Cartolux, n. serie 184, viaggiata nel 1954, Campigna – La Burraia, sul retro: Nuovo Skilift dalla rotabile presso la Calla a Poggio Gabrendo, con veduta della Burraia ripresa dal Gabrendo ma non si nota lo skilift mentre si notano il capanno minore posto tra i due edifici ed i capanni minori sul bordo della prateria innevata non esistenti in precedenza (collezione personale).

00q11 – Cartolina della Cartolux, n. serie 161, La Burraia – Appenino Tosco Romagnolo, con veduta della Burraia ripresa dal Gabrendo, dove si nota un capanno minore posto tra i due edifici non esistente in precedenza, non spedita, risalirebbe agli Anni Quaranta in quanto assente la stazione militare di Poggio Sodo dei Conti (collezione personale).

00q12a – Cartolina FOTORAPIDA COLOR – TERNI, Ed. Cipriani Silvano - Tab. 2 – Stia, viaggiata nel 1978, sul retro: Appennino Tosco-Romagnolo LA BURRAIA – Rifugio, riedizione malamente colorata ad acquerello di uno scatto b/n molto anteriore (Anni Quaranta/Cinquanta), con apparente lacuna che farebbe supporre un’inesistente costruzione che emerge oltre la macchia boschiva, mentre sono evidenti gli altri capanni e il grezzo della stazione militare di Poggio Sodo dei Conti (collezione personale).

00q12b – Cartolina Cartolux a colori serie n. 1052, sul retro didascalia PRATI DELLA BURRAIA, non viaggiata, databile intorno al 1974 per via del Rifugio Città di Forlì ormai costruito ma apparentemente non ultimato (risale a tale data), mentre ancora si notano i vari capanni (collezione personale).

00q13a - 00q13b – Cartolina Cartolux serie n. 808 spedita nel 1968, didascalia sul retro: Foresta di Campigna – Zona Monte Falco – Prato dei Fangacci presso il Rifugio “La Capanna”, sciovia per Monte Falco, che mostra l’area prima della sistemazione e realizzazione dello Snowpark, e Cartolina Cartolux serie n. 807 spedita nel 1972, didascalia sul retro “MONTE FALCO – Arrivo pista n.2 Rifugio La Capanna – Ristorante – Bar – Tavola calda – Appennino Tosco-Romagnolo”, interessante per lo stato del versante attraversato dalla pista, con il bosco ancora giovane che lascia emergere il profilo dei rilievi (collezione personale).
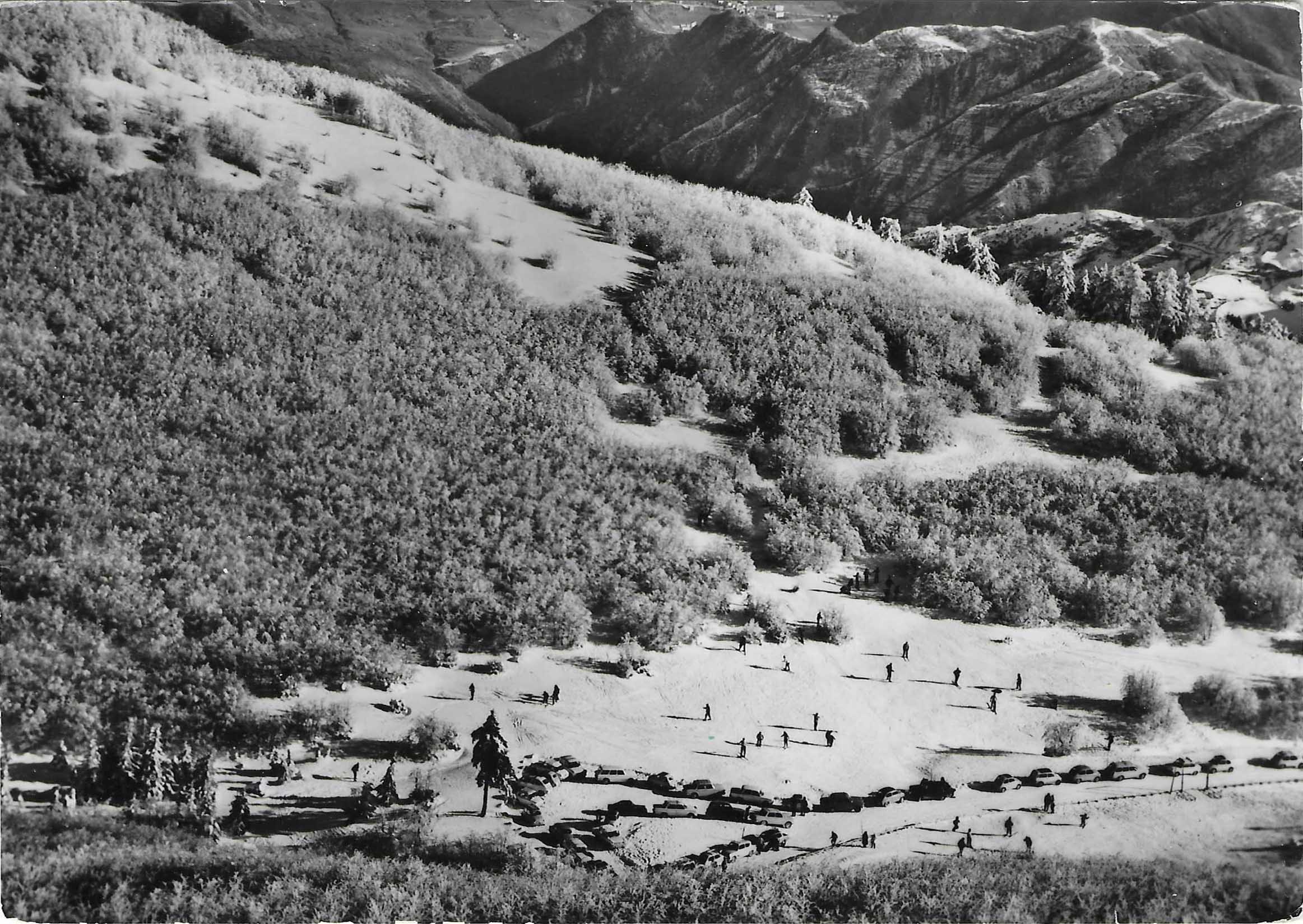
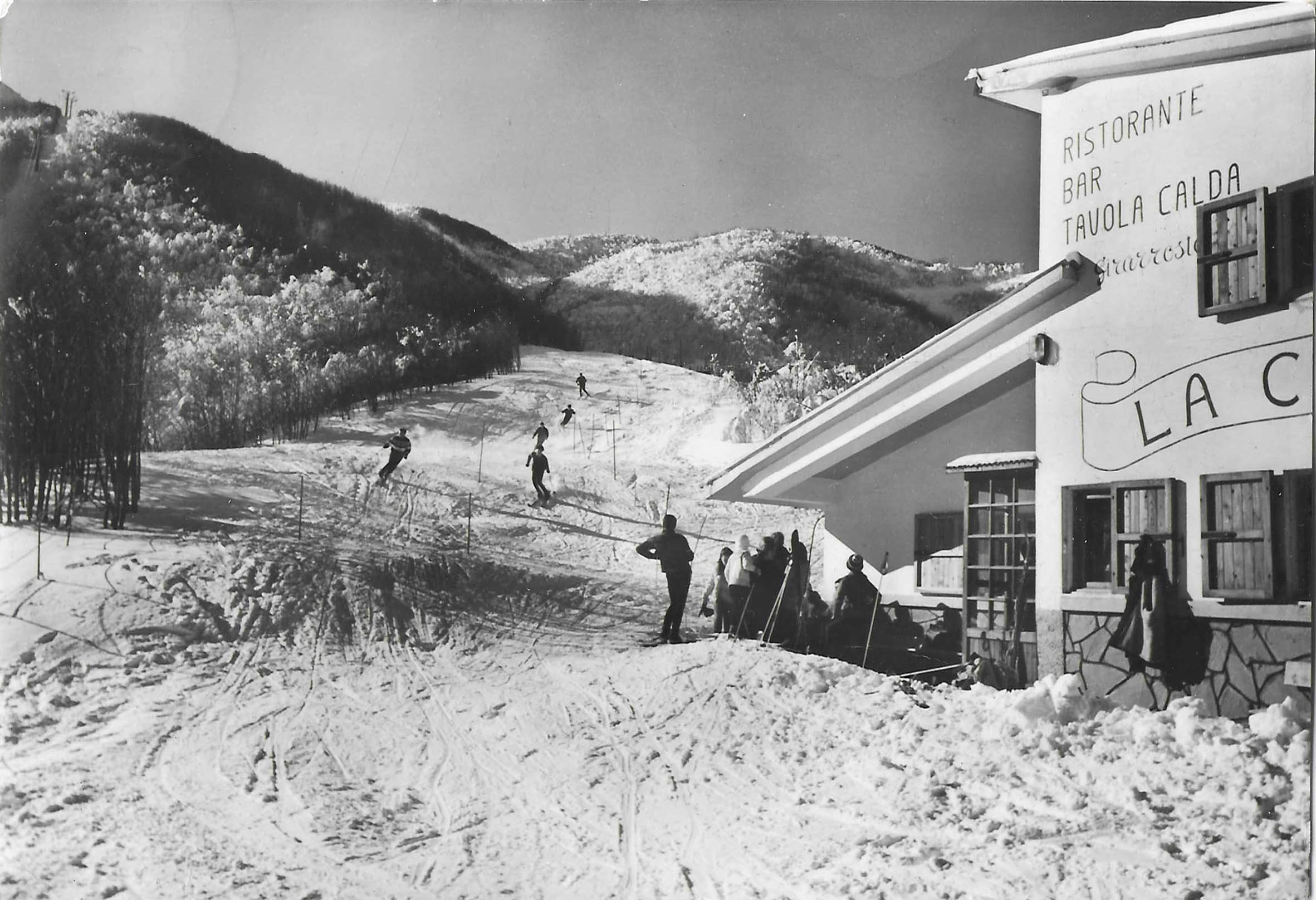
00g13c – Cartolina Cartolux n. serie 408, Campigna Skilift all’Albergo Scoiattolo, databile ai primi Anni Sessanta (si scorge l’Hotel Granduca ristrutturato) che documenta come a Campigna esistesse una pista da sci attrezzata con skilift sulla sterrata che scende a Villaneta (collezione personale).
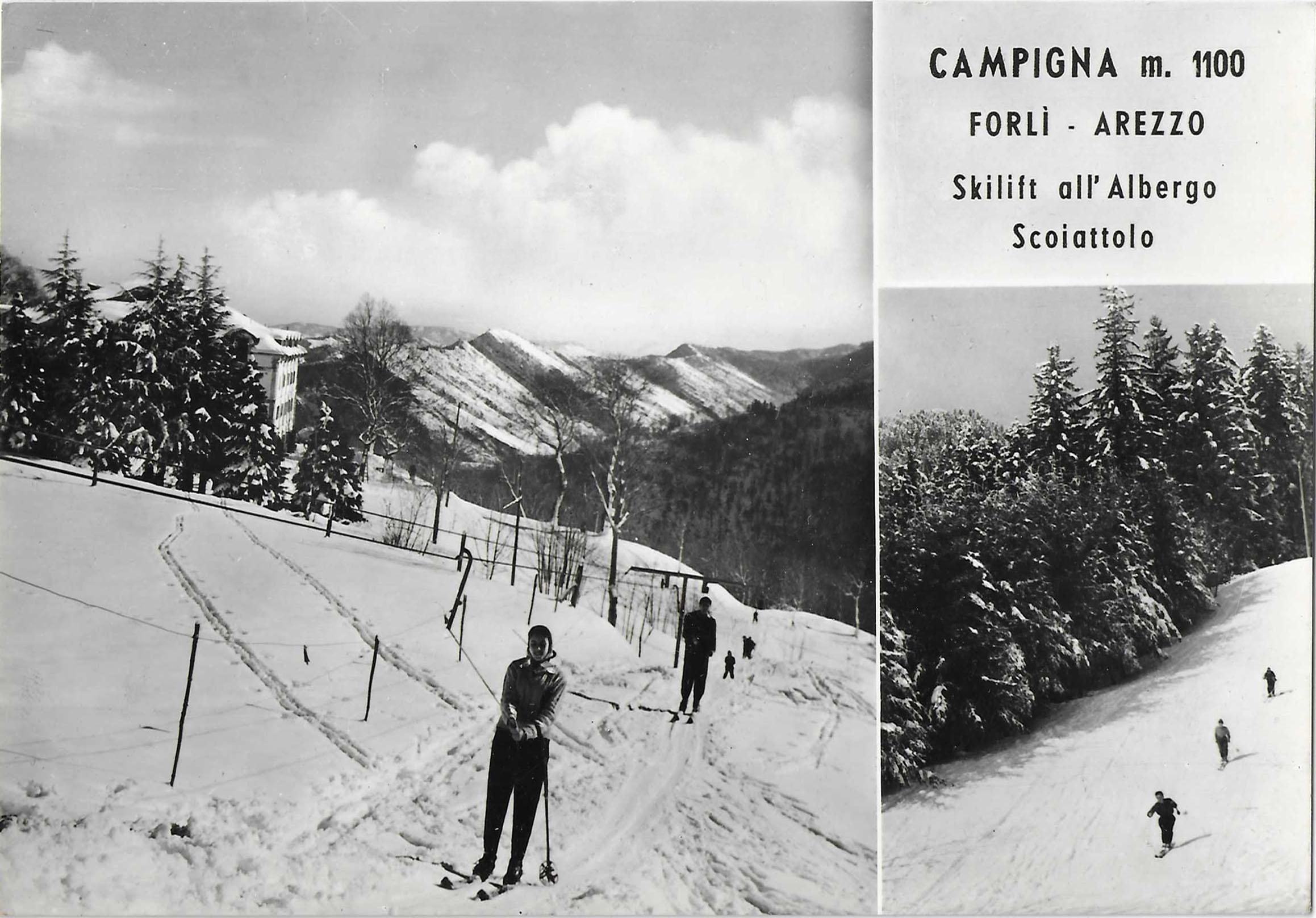
00q14 – Veduta del Passo della Calla, versante toscano (11/1/12).
00q15a – Cartolina a colori della Cartolux, n. serie 1051 con veduta del passo ripresa dall’inizio della Giogana, databile agli Anni Sessanta/Settanta in quanto si riconosce una Simca 1000 e una Fiat 1100 R che venne prodotta nel periodo ’66/’69; si nota la carrabile che risale il crinale ancora ininterrotta. Edizione Cartolux n.1051 (collezione personale).

0015b – Cartolina Cartolux n. serie 413, spedita nel 1960, con inquadratura più ampia della precedente dove si nota la strada non asfaltata e un Maggiolino che pare apprestarsi a risalire sulla Giogana (collezione personale).
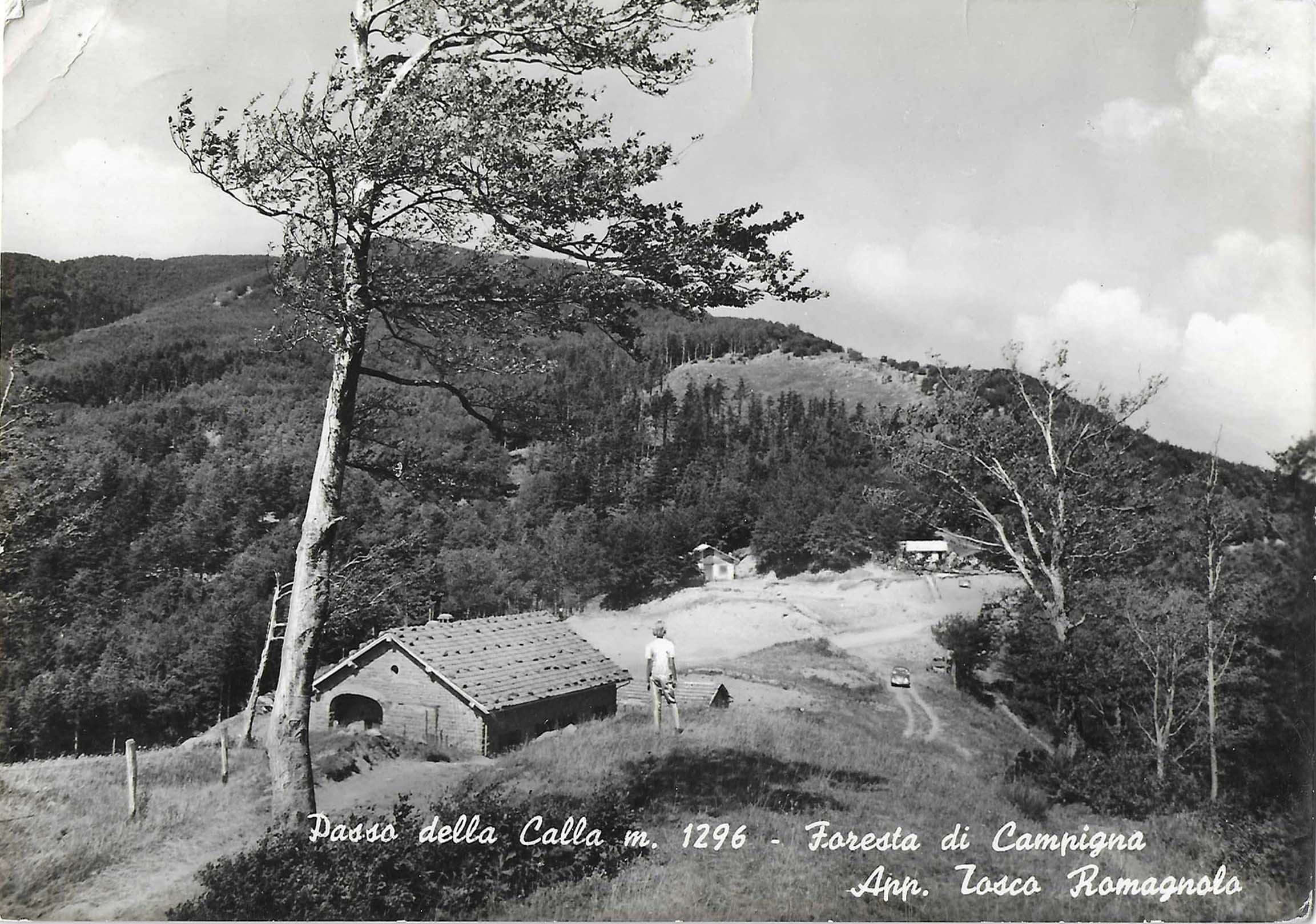
00q16 – Fotografia di Pietro Zangheri: Il Passo della Calla sopra Campigna (Data scatto: 01-08-24 - Negativo n. ZAN151). La foto riprende la nuova strada provinciale ormai aperta che si appresta a scendere verso Campigna oltre al bivio della (pare) costruenda pista verso i Fangacci con il viandante che riposa sul suo ciglio (Fonte: Archivio Fotografico della Romagna di Pietro Zangheri - patrimonio pubblico della Provincia di Forlì-Cesena, in gestione al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Per gentile concessione dell’Ente Parco - Autorizzazione del 5/08/2025). La stessa foto fu pubblicata da Zangheri nel testo sopracitato (1961, rist.anast. 1989, p. 12, Fig. 7) con la seguente didascalia: I valichi appenninici della Provincia di Forlì: II, il Passo della Calla, uno dei più centrali, ed è il più elevato (m. 1296). Si apre in mezzo alle abetine e faggete di Campigna ed è sbocco della valle del Ronco.

00q17 – Veduta odierna del passo verso l’innesto della Giogana (7/07/11).
00q18a – 00q18b - 00q18c - Cartoline con veduta da similare punto di ripresa, la prima, Cartolux n. serie 98 viaggiata nel 1952, dove si nota sia la strada sia la Giogana in pessime condizioni, la seconda, spedita nel 1958 Edizione “L’Artista del Paesaggio” Q. Candiotti S. Giovanni in Marignano (Forlì), databile ai primi Anni Cinquanta (come da probabile Fiat 500 C Belvedere 1949-1955), mostra una simile stato della viabilità ed una sorta di ripristino della carrabile che, comunque in pessime condizioni, risale il crinale, la terza, Edizione Tina Alterini, non spedita databile non prima del 1955 come dimostra la Fiat 600 prodotta dal 1955, mostra un ulteriore miglioramento sella viabilità principale e della pista sulla Giogana con evidenti tracce di utilizzo veicolare, oltre al primo pannello pubblicitario che invita a sostare al ristorante (collezione personale).
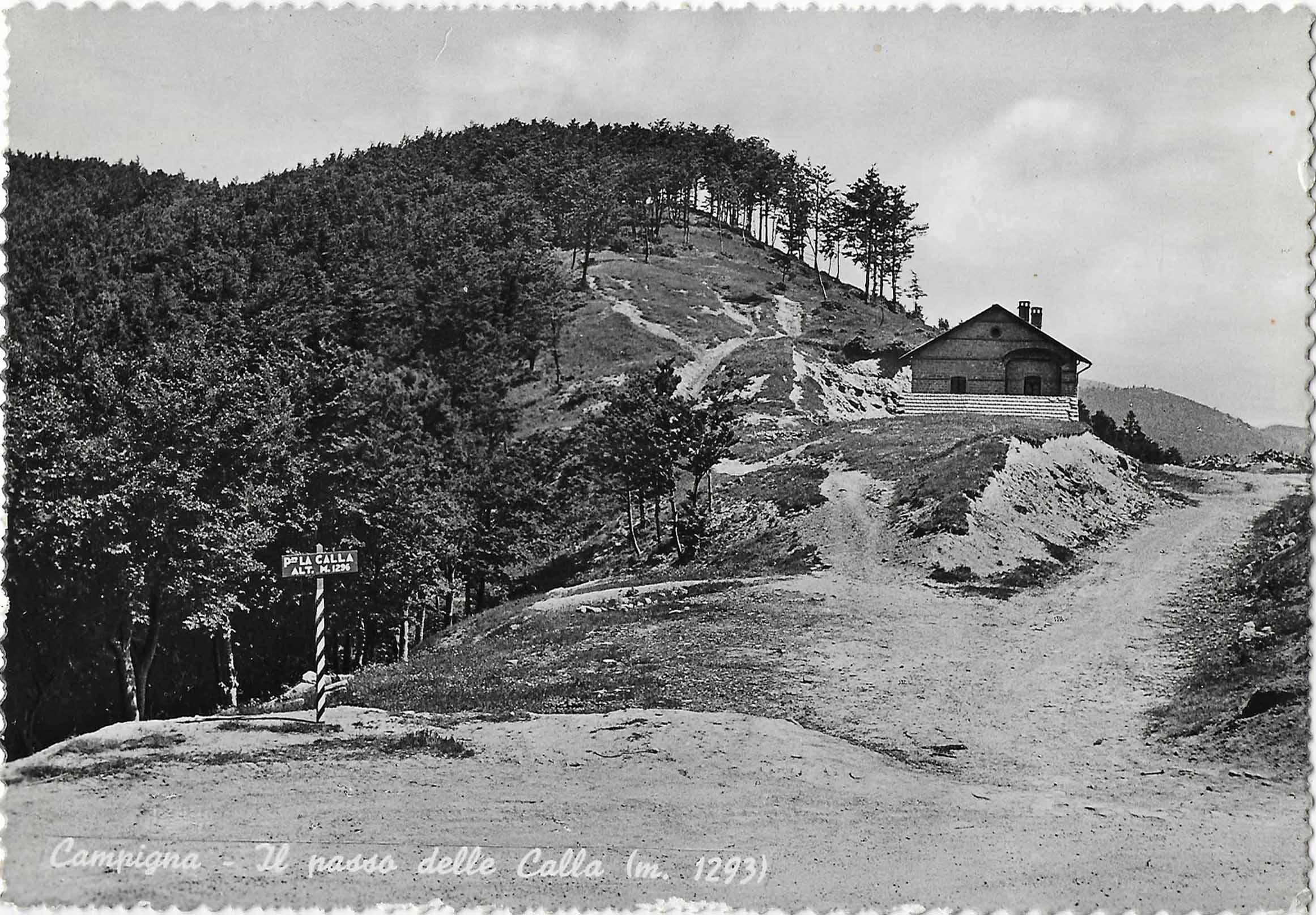

00q18d – Cartolina Ediz. G. Burzagli, Stia, spedita nel 1957, ma sicuramente antecedente alle precedenti, che mostra una situazione precaria della viabilità e caotica riguardo la sistemazione dell’area e l'utilizzo come deposito del legname (collezione personale).

00q18e – 00q18f – Cartoline Cartolux, la prima n. serie 284, spedita nel 1961 con timbro sul retro “Alpenbar” Campigna, e la seconda n. serie 162, Campigna – Il Passo della Calla, viaggiata nel 1955 con timbro sul retro “Albergo Campigna Tassinari Alcide”, riproducono il primo fabbricato del Ristorante I Faggi con immancabile Maggiolino e il piccolo capanno utilizzato dalle guardie forestali, che poi venne ingrandito ed oggi costituisce il Rifugio CAI, oltre alla viabilità non asfaltata (collezione personale).
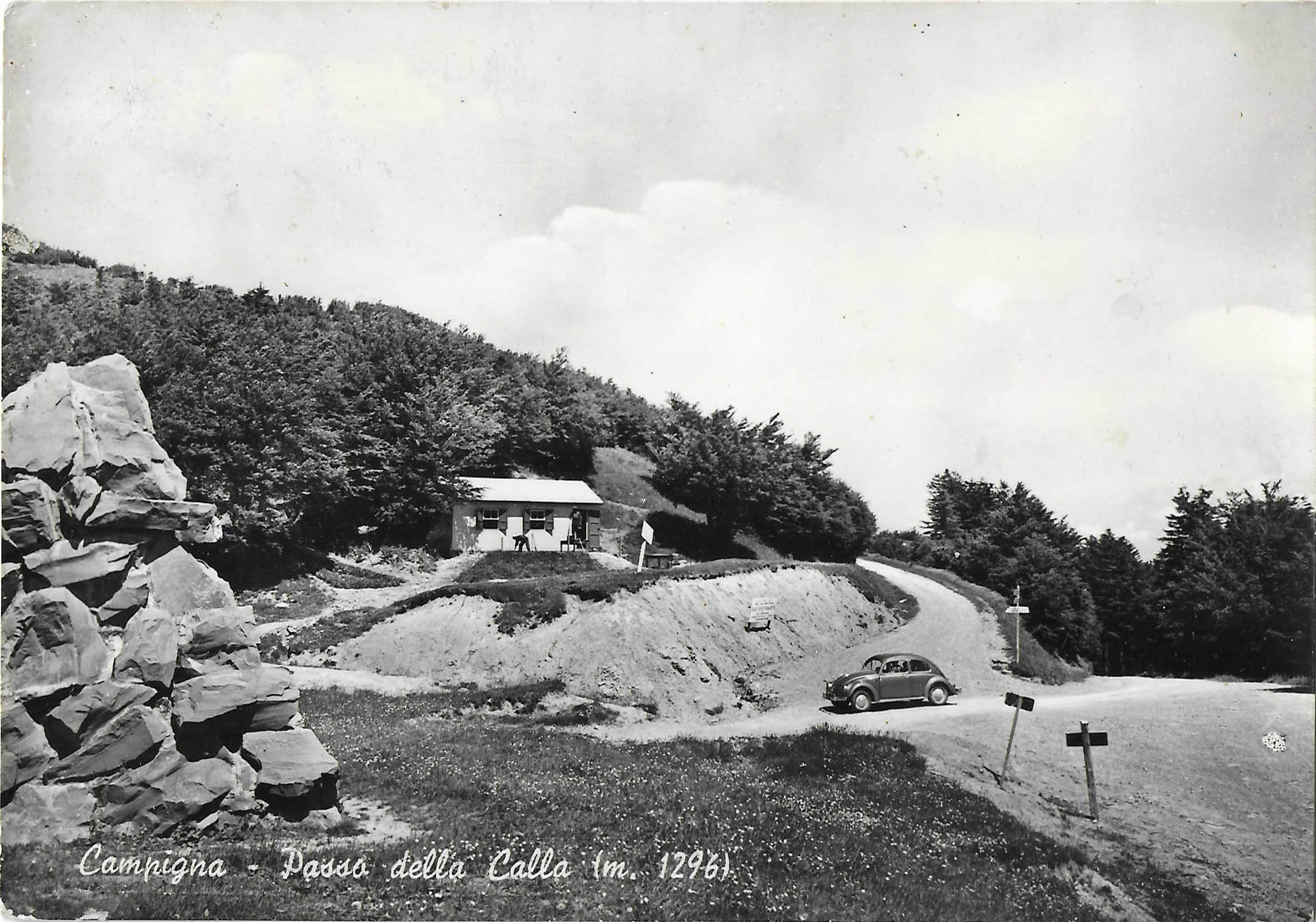
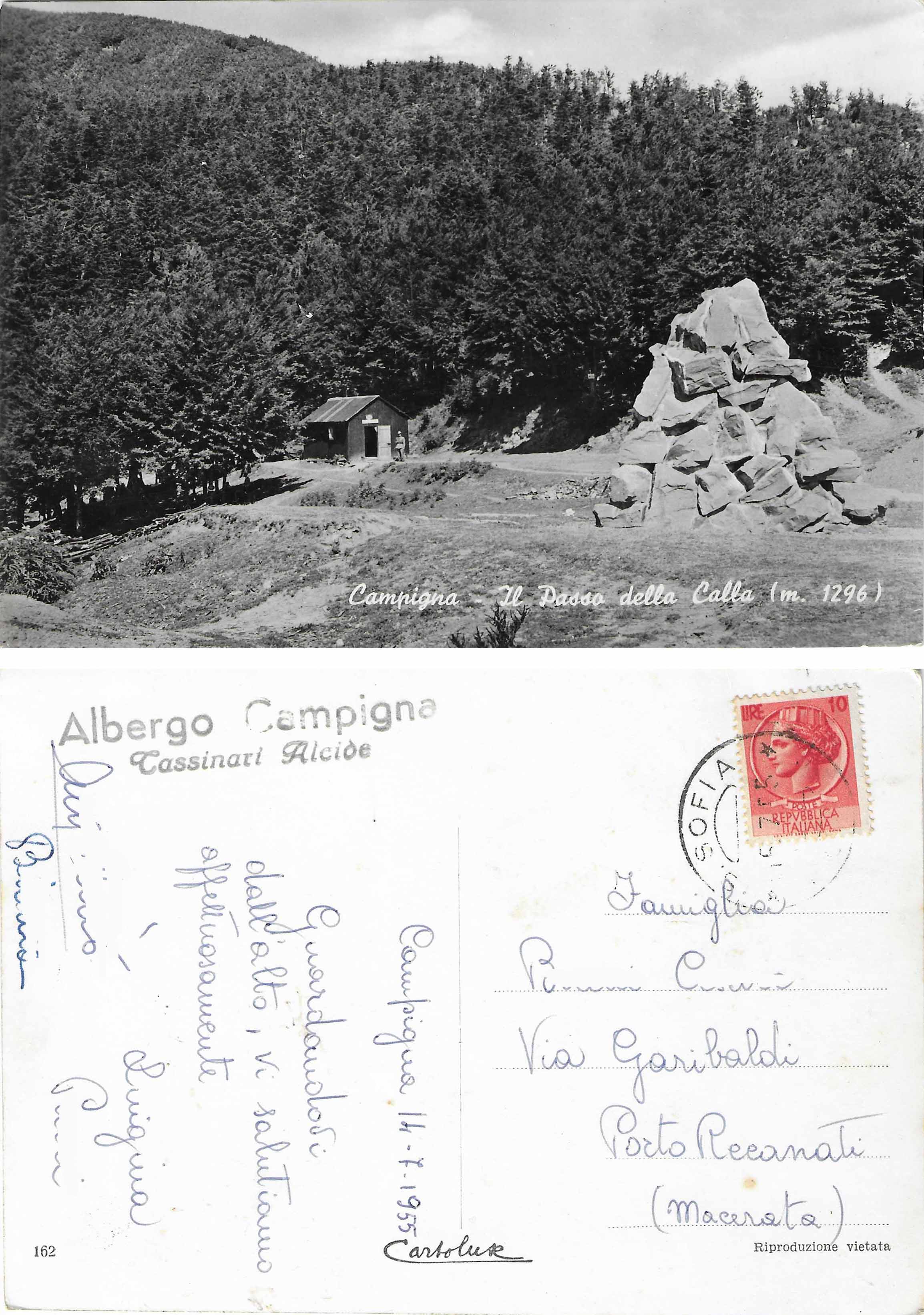
00q19 – Pittura digitale da foto degli Anni Settanta dove si nota una rotabile di crinale in perfette condizioni, poco prima della definitiva interruzione della libera circolazione.

00q20/00q21 – Vedute dei resti dell’antico itinerario di valico nel lato romagnolo, costituito dalla Mulattiera del Granduca che oggi si innesta sulla SP n.4 a 500 m dal passo (2/07/18).

00q22/00q25 – Vedute dei resti dell’antico itinerario di valico nel lato toscano che si intreccia con i tornanti del primo tracciato della provinciale, oggi sbarrato, e che in parte corrisponde con il sentiero CAI 80 fino alla Fonte di Calcedonia (15/05/23 – 14/09/23).
00q26 - 00r1 – L’inizio della Giogana con il nuovo pannello illustrativo sull’Antico Territorio Granducale e le “vie dei legni” (per gentile concessione di Graziano Maggi, 18/07/24).

00r2 – Veduta di resti di massicciata nel primo tratto di Giogana (16/01/11).
00r3 – Da Pian delle Carbonaie si diparte il Sentiero delle Cullacce sulla traccia della “Strada Antica via dei Legni” (19/06/18).

00r4/00r10 – Vedute del lungo tratto di Giogana molto regolare, anticamente detto Raggio Lungo (13/01/11 – 16/01/11 - 19/06/18 – 9/07/18).


00r11 – 00r12 - Vedute della Giogana a Pian Tombesi e all’altezza del Canale del Pentolino (13/01/11).


00r13a – 00r13b - 00r14 – Vedute della Giogana dai versanti opposti di Poggio Scali e Cartolina Cartolux n. di serie 25 spedita nel 1956 (collezione personale), didascalia Camaldoli Campigna – Poggio Scali (m. 1520) con punto di ripresa simile alla veduta precedente, dove si nota il versante occidentale del poggio con la vegetazione più giovane e privo delle installazioni moderne (13/01/11 – 19/04/11).
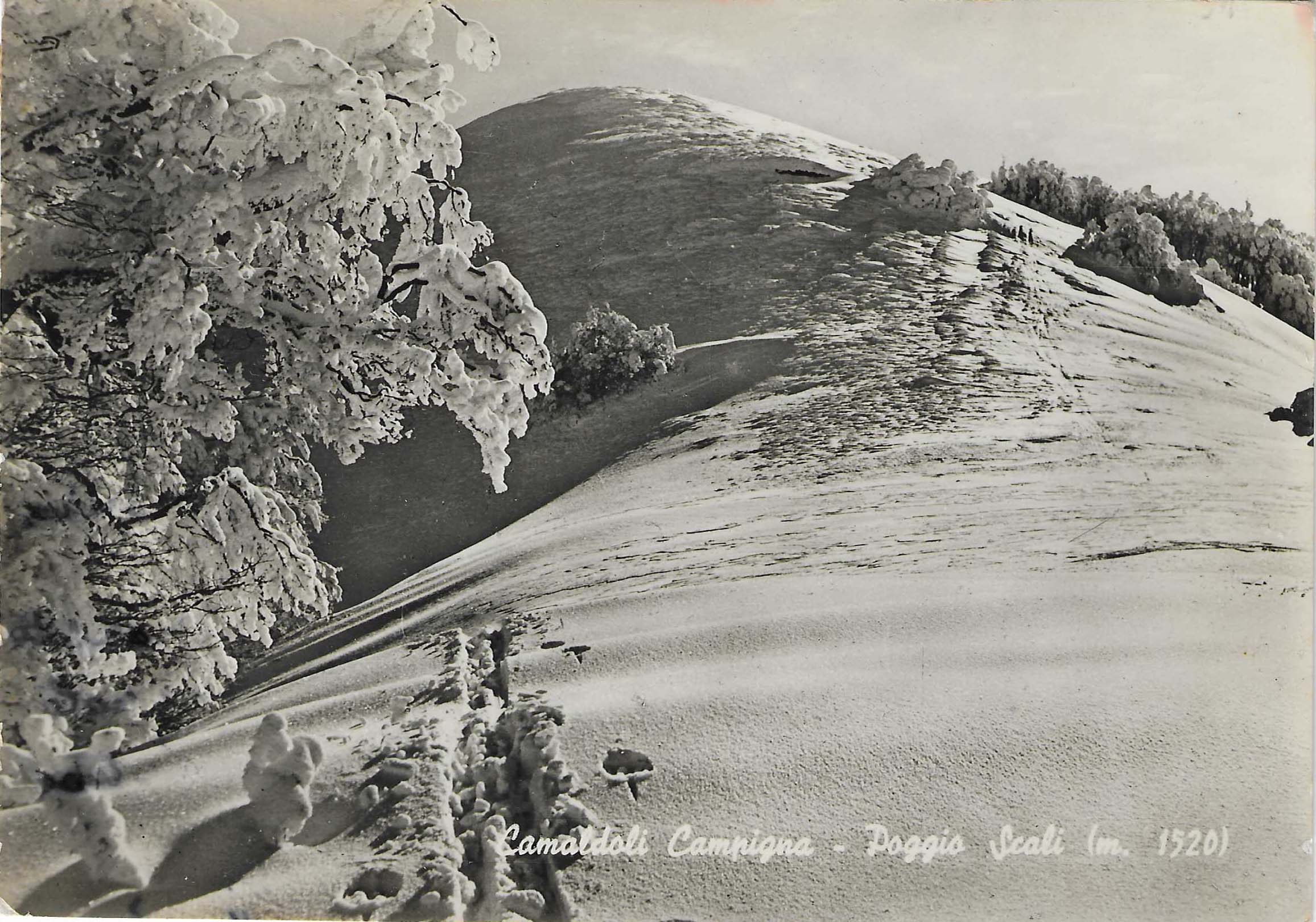

00r15/00r18 – Vedute della Via del Giogo di Scali ai due estremi opposti della Riserva di Sasso Fratino, ovvero sulle pendici di Poggio Scali e a Pian del Pero, oltre a panoramica dall’altopiano di S.Paolo in Alpe (19/06/19 – 25/04/18 – 17/03/23).

00r19 – 00r20 – 00r21 - Vedute del Passo del Porcareccio e della Strada Romagnola che risale dal versante toscano lungo la quale si trova l’antico cippo con raro stemma camaldolese (13/01/11 –18/01/18 - 14/09/23).

00r22 – Veduta dicembrina con galaverna del Passo Sodo alle Calle o La Scossa (11/12/19).

00r23 – 00r24 – 00r25 – Veduta dell’antica Strada che da Campo Ominacci va a Stia che dal passo si dirigeva a Sasso Fratino, i cui resti si trovano sotto la pista selciata in parte di epoca moderna, bruscamente interrotta sul confine della Riserva, forse a seguito della sua istituzione (26/11/19).


00r26 – Veduta della pista forestale che dal passo si dirige verso Pian del Varco; il riparo ormai pericolante della foto è stato rimosso (16/07/17).

00r27 – 00r28 – Vedute della pista forestale che dal passo scende ad attraversare il Bagnatoio, forse anticamente detta vecchia strada bordonaia de legni quadri (26/11/19).


00r29 – 00r30 – 00r31 – Vedute dell’innesto sulla Giogana della Strada delle Pulci, rivolto verso Giogo Seccheta ma modificato dalla risistemazione della pista di crinale, e di due tratti con resti di massicciata (17/12/19).


00r32 - Veduta delle Tre Fonti, all’inizio della pista forestale diretta a Poggio Acerone, si tratta della sesta pista convergente sul Combarbio (incrocio di vie) di Sodo alle Calle, con la Giogana sono sette (16/07/17).

00r33a – Panoramica di Giogo Seccheta (11/12/14).

00r33b - Cartolina Cartolux n. di serie 27 spedita nel 1952 e didascalia sul retro “Camaldoli - Campigna - Giogo Secchieto (m. 1383)” dove si nota il capanno di Giogo Seccheta, allora ancora esistente (collezione personale).

00r34 – 00r35 – 00r36 – Vedute della “via dei legni” che prima con un reticolo di percorsi (come illustrato da Ducci e Maggi nel loro testo citato) poi con una pista ben tracciata scende dal Giogo verso Pian del Varco e Battilocchio (1/05/13 – 11/12/14 – 14/09/23).



00r37 – Veduta dell’antico tracciato di crinale descritto da Beni che dal Giogo scendeva a Prato al Soglio prima delle migliorie di Siemoni e moderne (17/12/19).

00r38 – Panoramica di Prato al Soglio (1/05/13).

00r39 – 00r40 – 00r41 – Alcuni “termini di pietra” dei 4 cippi superstiti su 9 impiantati nell’800, numerati 68-70-72-74, posti sul bordo del prato e confine regionale; per l’esatto posizionamento cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, cit. (15/06/11).



00r42 – 00r43 – Vedute dell’antico tracciato che da Prato al Soglio scendeva verso il Bagnatoio e La Lama tramite gli Acuti, innestandosi sulla Strada delle Pulci (12/06/17 – 17/12/19).

00r44 – 00r45 – Vedute della Giogana a Prato Bertone dove anticamente la viabilità principale abbandonava il crinale unicamente discendendo all’Eremo, come oggi si innesta il sentiero 68 CAI (15/06/11 – 17/12/19).


00r46 – 00r47 – 00r48 - Per un lungo tratto fino a discendere verso Gioghetto si trovano superstiti alcuni dei cippi leopoldini (numerati 64-55-51-45, per l’esatto posizionamento cfr. M. Ducci, G. Maggi, 2022, cit.), di cui il 51 ben conservato, mentre pare sia scomparso il cippo 46 o 47, che alcuni anni fa giaceva spezzato sulla scarpata sopra strada (19/04/11 – 17/12/19).



00r49 – Veduta del Gioghetto, anticamente detto Fonte al Sasso (27/12/19).
00r50 – 00r51 – Vedute del tratto antico, poi abbandonato, che dal Gioghetto giungeva all’Eremo sul lato orientale, nel catasto moderno detta Strada Vicinale di Fonte al Sasso (24/06/23).


00r52 – 00r53 – Vedute della Strada della Lama o Via delle Svolte che dal Gioghetto scendeva alla Lama (12/06/17).


00r54 – 00r55 – Il “termine di pietra” n.31 si trova a Poggio di Fuoco, tra il Gioghetto e Prato alla Penna (15/06/11).


00r56 – Cartolina Postale spedita nel 1918 riproducente la meta raggiunte dalla Giogana dell’Eremo e di Camaldoli in un’antica stampa camaldolese (collezione personale).
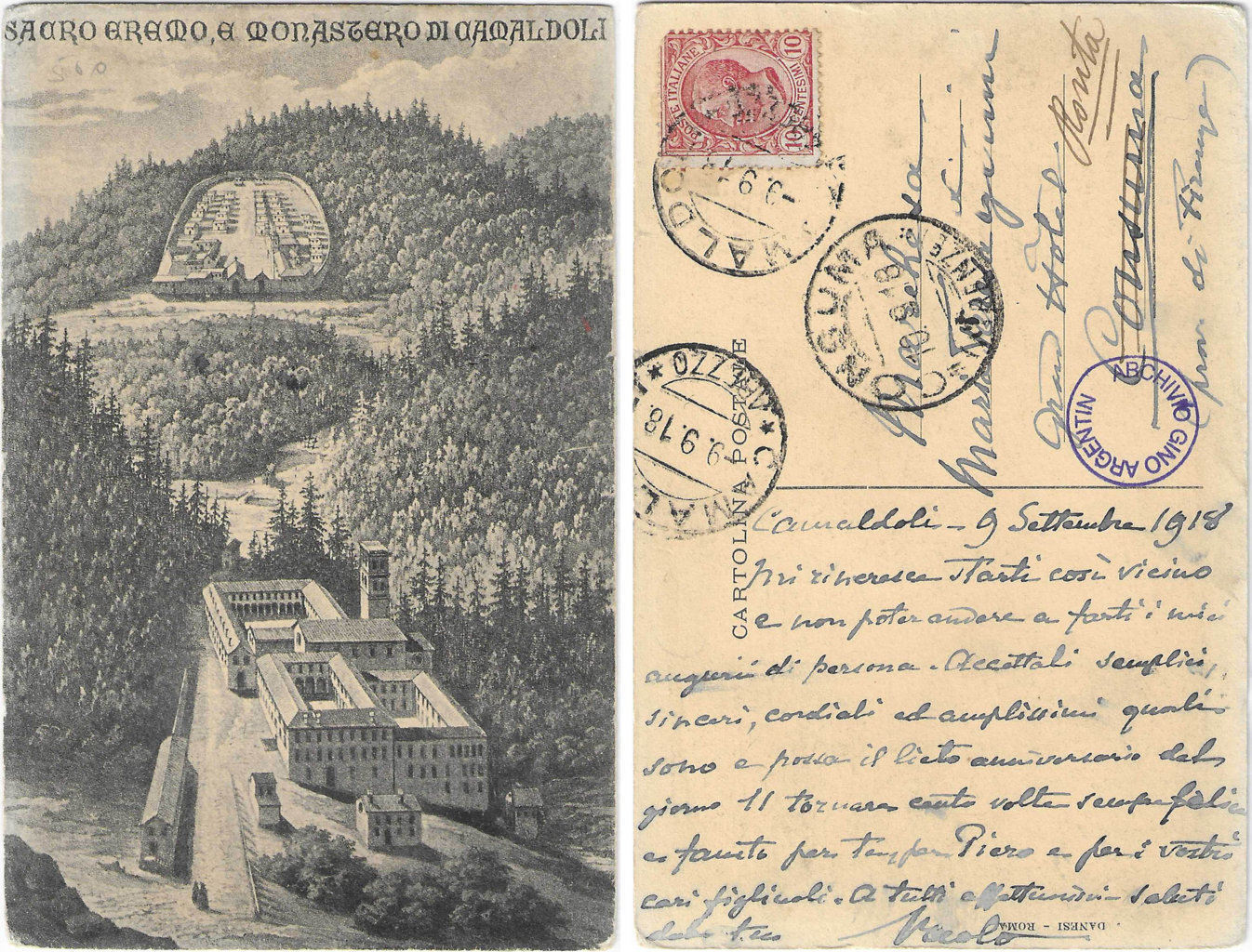
00s1/00s4 – Vedute di Prato alla Penna, del nuovo pannello informativo sui “Termini di confine” e del 'termine' n.25, posto presso la sbarra (10/12/10 - 13/01/16 – 20/02/20 – 24/07/24).

00s5 – Veduta della Via della Bertesca che dal Prato scende all’Eremo, oggi sentiero 74 CAI (20/02/20).

00s6 – Veduta della S.P. n.69 dell’Eremo, nel tratto romagnolo opportunamente non asfaltata, con scorcio del Monte Penna (17/03/20).
00s7 – 00s8 – 00s9 – Vedute della Via della Bertesca, oggi 00 GEA CT, che dal Prato risale verso il Gioghetto e Poggio Tre Confini (20/02/20).
00s10 – Veduta del bivio presso il Gioghetto tra la Via della Bertesca sulla sx e il tracciato di esbosco che prosegue sul crinale come descritto nell’antica relazione sull’apposizione dei “Termini di pietra” (cfr. Ducci-Maggi) (20/02/20).
00s11 – 00s12 – 00s13 – Veduta del Gioghetto, erroneamente tabellato come Cava dei Frati, sul bivio tra il 00 GEA CT e il 68 CAI per Poggio tre Confini, lungo il quale si trovano alcuni dei cippi superstiti che Ducci e Maggi hanno individuato nei nn. 12-5-4-3 (20/02/20).


00s14 – Veduta della sommità di Poggio Tre Confini (20/02/20).
00s15 – 00s16 – 00s17 – Vedute della Via della Bertesca che dal Gioghetto scende verso il Passo dei Fangacci, della zona della Cava dei Frati e del passo con il moderno Rifugio Fangacci (20/02/20 – 17/03/20).


00s18 – 00s19 – Vedute dell’inizio del Sentiero degli Scalandrini, 227 CAI, e del bivio oltre il quale in effetti proseguiva l’unico percorso che anticamente scendeva dal passo verso La Lama (27/12/19 – 17/03/20).


00s20 – Veduta della Strada dei Legni che dal passo scende a Badia Prataglia tramite il Capanno (26/05/23).

00s21 – Veduta del combarbio, luogo dove si incrociano varie vie antiche, tra cui la Via dei nespoli verso Serravalle e la Via della bertesca (20/02/20).
00t1 – 00t2 – 00t3 - Vedute dell’Aia di Guerrino, prima che venisse abbattuto il maestoso abete, e del tratto che risale verso il Passo della Crocina variamente detto Via della bertesca, Strada che va alla bertesca, Via dall’Eremo in Romagna, Via dei legni, con i resti della massicciata adiacenti al bivio per il Monte Penna (7/2/11 – 18/06/11 - 19/06/20).



00t4 – 00t5 – Vedute del Passo della Crocina (28/10/20).


00t6 – Veduta del tratto romagnolo oltre il passo, nel ‘600 detta Via Maestra che vien dall’Eremo, oggi sentiero 207 CAI (18/06/11).

00t7 – Veduta dell’unica via che anticamente scendeva dal passo verso Badia Prataglia, prima sviluppandosi con modestissima pendenza sul versante di Poggio Rovino, nel catasto ottocentesco detta Via della fonte del prete (9/10/20).


